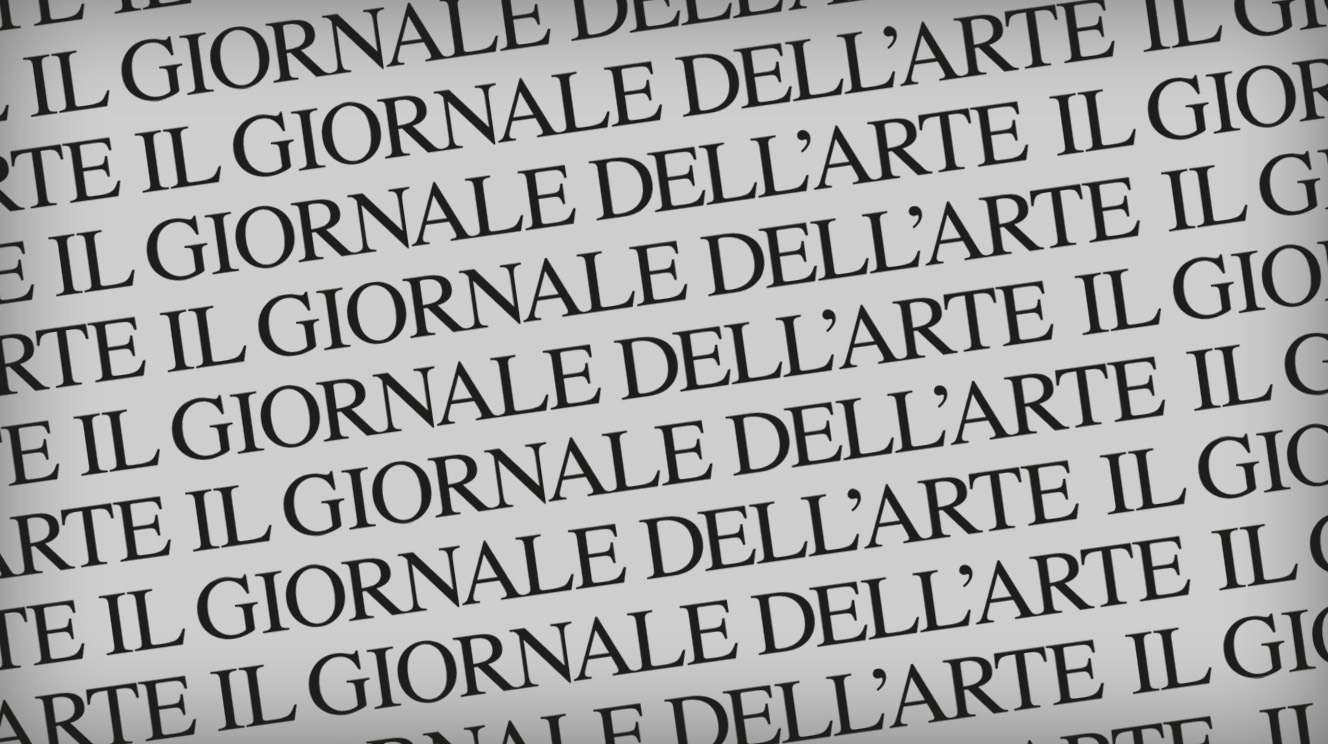Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Antonio Aimi
Leggi i suoi articoliNei suoi interventi sulle nomine dei 20 megadirettori il ministro Franceschini, oltre a fare considerazioni condivisibili (almeno a livello teorico) sulla necessità di semplificare norme in parte arcaiche (rimaniamo in attesa dei fatti), ripete spesso una parolina magica, che sembra al centro dell’azione del Governo in tema di politica museale: «valorizzazione». Dato che per il dizionario Treccani significa «operazione di mettere in valore», verrebbe da pensare che siamo alla vigilia di ingenti investimenti nel campo dei beni culturali, perché, esattamente come avviene con le nozze, è noto che la valorizzazione non si fa coi fichi secchi.
Se, però, il ministro pensa a una «valorizzazione commerciale», fatta di più visitatori, di più incassi dalla biglietteria ecc. è sorprendente osservare che i criteri di assegnazione dei punteggi nella selezione dei nuovi direttori hanno ignorato proprio la capacità di attrarre visitatori e risorse dimostrata dai singoli candidati nell’esercizio delle loro funzioni direttive. Curiosamente, però, nelle dichiarazioni fatte il 15 settembre Franceschini, da un lato, sembra prendere atto che il «numero chiuso» agli Uffizi rende impossibile un’ulteriore valorizzazione del museo sul piano dei visitatori, dall’altro sembra ignorare che lo stesso problema si porrà tra breve anche per il Colosseo e il Foro Romano, per non parlare di Venezia.
Dato, quindi, che quella che gli specialisti chiamano «capacità di carico» di un museo o di un sito archeologico (e qui sarebbe bene che anche il ministro e i funzionari del Mibact cominciassero a pensare a partire dalle categorie del lessico specialistico) impone dei limiti alla «valorizzazione commerciale», sarebbe opportuno, se si vuole percorrere questa strada, che si puntasse su un’altra parolina magica: «progettualità». Da questo punto di vista l’esperienza di Paesi come il Messico e il Perù, che hanno un patrimonio archeologico analogo a quello dell’Italia e che a torto continuiamo a considerare del Terzo Mondo, avrebbe molto da insegnarci, mostrandoci come si valorizza un territorio nel suo complesso. Come? Investendo sulla cultura a prescindere dall’andamento del Pil e conservando splendidamente anche i più piccoli museos de sitio, come fa, eroicamente, il Messico nella situazione della terribile guerra contro i narcos. Promuovendo, come fa il Perù, nuove mete turistiche, per esempio la ruta Moche, fatte di siti archeologici e di nuovi musei.
I due casi, però, dimostrano che anche per una valorizzazione commerciale sono necessarie risorse ingenti senza aspettarsi ritorni immediati. Di nuovo, quindi, appare evidente che non si possono fare le nozze coi fichi secchi e che ogni discorso serio sui musei deve prevedere, oltre a interventi ovvi e necessari, un vero e proprio progetto di investimenti, che, oltre a migliorare la situazione nei luoghi sul punto di superare la loro capacità di carico, promuova le centinaia di musei e di siti cosiddetti «minori».
Altri articoli dell'autore
Al MuCiv gli interventi di artisti e «specialisti» privi di competenze antropologiche non funzionano
Serve un cambio di rotta per far tornare i visitatori nel più importante museo italiano di antropologia all’Eur, dove opere di arte contemporanea, nella sezione della Preistoria, penalizzano le collezioni anziché valorizzarle
Nel sito di cultura Marañón, dove la pianta era considerata sacra e associata alle donne e alla luna, l’archeologo Quirino Olivera ha trovato rarissime sculture che ne raffigurano i frutti
Aperta alle Scuderie la mostra che celebra 150 anni di relazioni diplomatiche tra Italia e Messico: in rassegna fischietti e flauti e altri strumenti sonori e rituali
Al Rietberg Museum il valore simbolico della lega di oro e rame per le popolazioni indigene