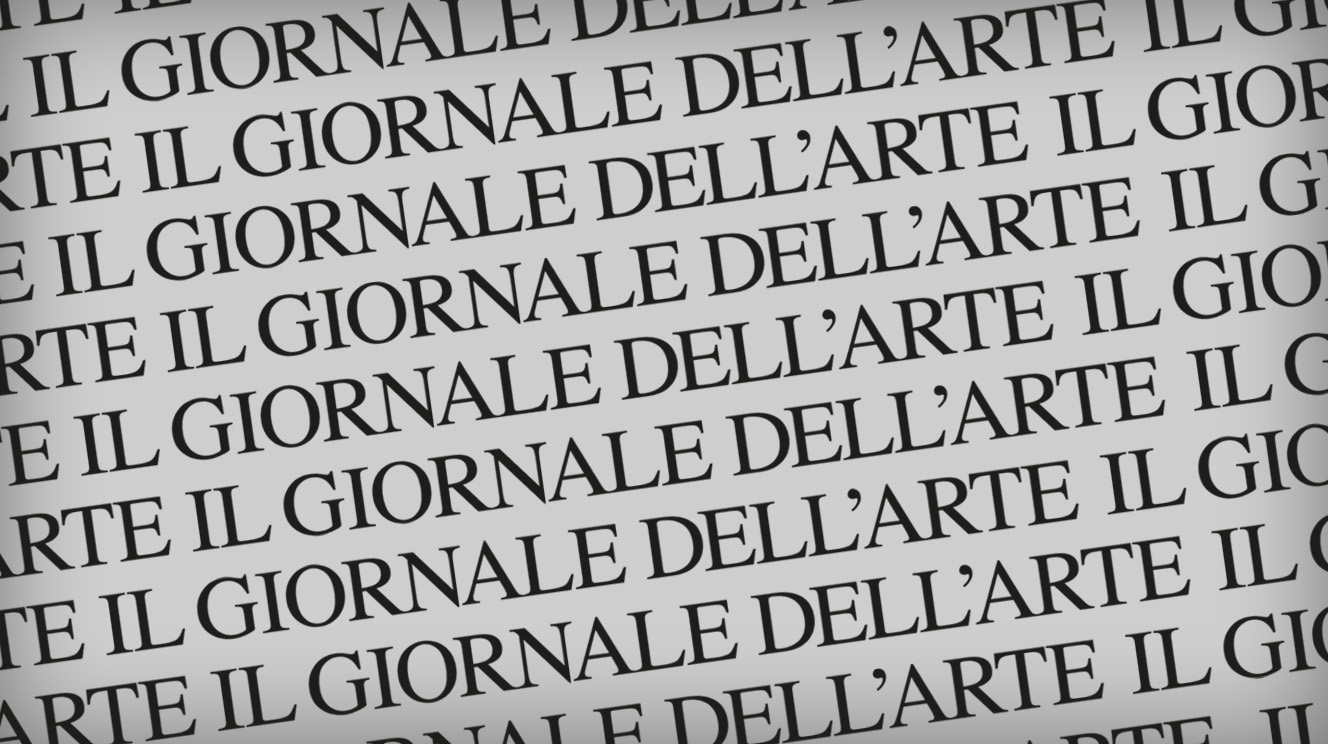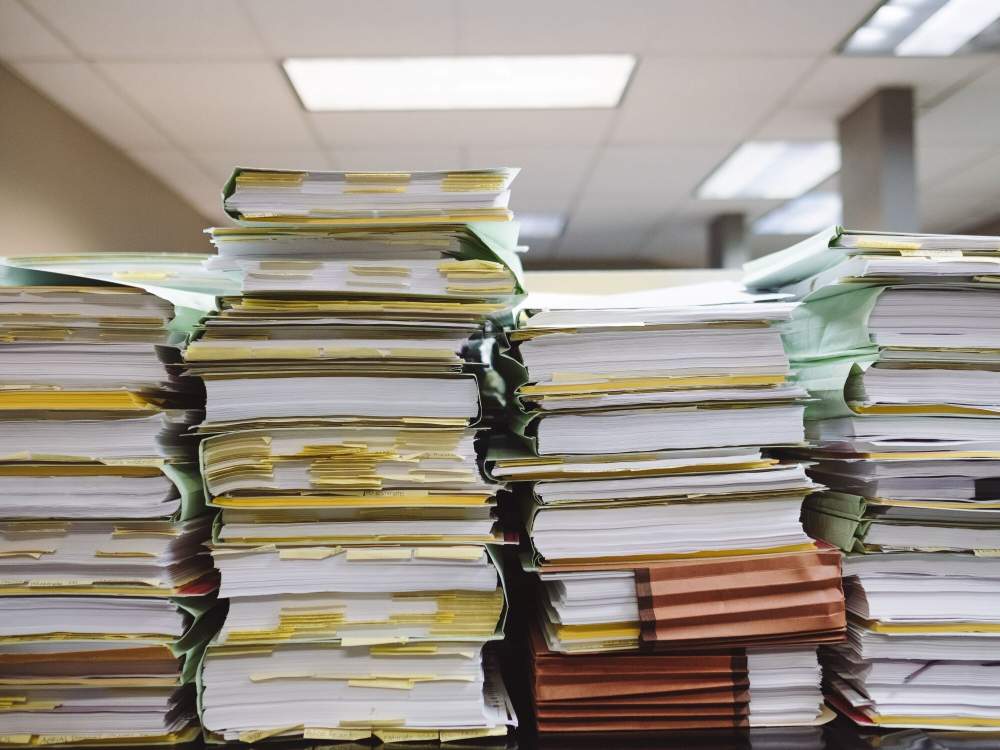Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Redazione GDA
Leggi i suoi articoliLe Monde
Enwezor per molti aspetti redige un atto d’accusa: Biennale politica, ma non necessariamente benpensante, come testimonia la presenza all’Arsenale del turco Kutlug Ataman, di cui restano memorabili le dichiarazioni pubbliche contro i rivoltosi del Parco Gezi nell’agosto 2013, nel momento in cui intellettuali e giornalisti laici erano in prigione. Biennale cupa. Date le circostanze attuali, non si vede come potrebbe essere diversamente.
Philippe Dagen e Harry Bellet
la Repubblica
Prevale una forte tensione progettuale che restituisce l’etica di un ruolo, quello del curatore, capace di un giudizio e di un’interpretazione del presente e del nostro passato prossimo. Dunque non una semplice documentazione e manutenzione espositiva del nuovo, ma piuttosto la volontà di rappresentare la complessità e la conflittualità del nostro tempo. Non prevalgono trend interni al sistema dell’arte o qualche supremazia continentale bensì una modalità espositiva consona a una lettura globale delle cose, per un pubblico multiculturale.
Achille Bonito Oliva
La Stampa
Enwezor con la sua mostra intitolata «Tutti i futuri del mondo» è riuscito a dire e a fare quello che né Expo né gli imbecilli dei Black Bloc sono stati capaci di fare e di dire. Il mondo o meglio i tanti mondi che compongono il nostro pianeta è fatto di problemi e delle loro possibili soluzioni. Il curatore nigeriano (...) le mette in scena con grande potenza ed eleganza aiutato nell’allestimento della mostra dall’architetto inglese David Adjaye. (...) I temi e i protagonisti che mette sul palcoscenico (perché questa Biennale è un vero e proprio pezzo di teatro) arrivano da luoghi, società e culture dove la modernità sta ancora facendo i conti con diverse realtà, spesso contraddittorie e conflittuali: dall’Africa al Sudamerica all’Asia.
Francesco Bonami
El País
In un rapido giro attraverso questa mostra gigantesca ad attirare l’attenzione è il peso recuperato dal video e dalla fotografia, qualcosa che ha a che fare con la richiesta del curatore di recuperare la parola per raccontare storie in modo comprensibile allo spettatore.
Ángeles García e Milena Fernández
Il Corriere della Sera
Se negli anni Settanta l’arte era forma di liberazione dal giogo borghese (come insegnavano Sartre e Marcuse) oggi è diventata la sua rivisitazione etno-chic in una prospettiva le cui radici sono ben piantate nell’élite capitalistica internazionale e globalista. Una prospettiva talmente multiculturalista che, mentre da un lato la Biennale conta 89 padiglioni nazionali per offrire materiale identitario, nella mostra del curatore Enwezor difficilmente si può fissare la nazionalità degli artisti esposti, perché sono quasi tutti apolidi.
Pierluigi Panza
The New York Times
Nel secolo in cui sono apparsi per la prima volta, i padiglioni nazionali della Biennale di Venezia hanno svolto la funzione di avamposti culturali dei Paesi che rappresentano. Ma che cosa succede quando quei Paesi sono coinvolti in un conflitto armato? L’arte spesso rispecchia gli orrori che avvengono in Patria: artisti e curatori, che considerano un proprio dovere ritrarre la realtà, li illustrano in una varietà di mezzi espressivi e Venezia diventa un palco per attriti geopolitici.
Farah Nayeri
Frankfurter Allgemeine Zeitung
La 56ma Biennale d’arte comincia in modo diverso da quella degli anni passati. Inizia con un muro, su cui sta scritto un testo, che deve essere letto, prima di entrare nel Padiglione Centrale, il grande spazio espositivo dei Giardini. Ancora due anni fa, nella Biennale precedente, introducevano il discorso le immagini oniriche dello psicanalista Carl Gustav Jung; quattro anni fa erano i dipinti del XVI secolo di Tintoretto, che per la durata della mostra avevano traslocato dal centro storico di Venezia ai padiglioni della Biennale. Ora, nel 2015, non c’è alcuno sguardo retrospettivo nel passato o nella storia dell’arte. Conta il presente, e precisamente la parola del direttore artistico Okwui Enwezor, che già nella prima frase suona furiosa. Julia Voss
il Giornale
Tra i tanti curatori Enwezor è quello che più si serve dei lavori e degli artisti per dimostrare un proprio assunto, sacrificando (se è il caso) la percezione estetica e la chiarezza espositiva sull’altare dell’attualità. «All the World’s Futures» è l’autoritratto di chi l’ha concepita, densa di temi ma scarna di visioni, spesso rivolta al passato e un po’ grossolana nel cercare quello spirito di contestazione che piace tanto alla borghesia illuminata.
Luca Beatrice
Il Sole 24 Ore
Questa Biennale di rivoluzionario non ha niente né vuole averlo. Anzi, accoglie il concetto di forma senza temere il formalismo, mette artisti classici come Georg Baselitz e Marlene Dumas a confronto con i più giovani, ripropone tra le tecniche asseverate anche quelle che includono il tempo, il caso, la corporeità, la presenza di un pubblico chiamato a partecipare. La durezza delle tematiche e delle forme è bilanciata dall’eleganza dell’insieme, allestito senza improvvisazioni e con l’aiuto di un supporto architettonico che, soprattutto all’Arsenale, usa ma non subisce gli spazi. (...) Alla fine è la più risolta tra le ultime biennali. Enwezor ha intuito, all’apice di una carriera e di un’esperienza uniche, che una mostra non cambia il mondo. Ha il compito di passarlo al setaccio come in un filtro alchemico. L’arte il mondo lo pensa, lo racconta e lo ipotizza. Angela Vettese
Libération
Nel percorso, assai complesso, della mostra si ammassano proposte opache. Lo scoglio principale qui non è solo la ridicola mancanza di spiegazioni, di dati fattuali che accompagnino la lettura basica di un’installazione, ma anche il fatto stesso che queste decine di opere sono allineate in una mostra che ambisce a far pensare il visitatore. A indurlo a impegnarsi, politicamente, personalmente o esteticamente. A che pro devitalizzare tante proposte visive allineandole in un allestimento tanto accademico e superato?
Clément Ghys
il Fatto Quotidiano
L’arte riscopre l’antagonismo, il terzomondismo, perfino il marxismo: questa la promessa di una Biennale «che vuole disturbare», come ha teorizzato il curatore Okwui Enwezor, e come in effetti accade, sia pure in modo alterno. Il grande pannello che ai Giardini introduce al cosiddetto «Parlamento delle forme» promette, testuale, «non un unico tema onnicomprensivo, ma una coreografia iterativa, una diversità di approcci, come l’idea di montaggio dialettico di Sergei Eisenstein». Uno legge, rilegge, capisce quello che può, e alla fine vede stagliarsi l’ombra di Fantozzi e della sua immortale reazione di fronte al «montaggio analogico» della «Corazzata Potemkin». Non sarà che «Il Capitale» di Karl Marx, di cui la Biennale propone la lettura integrale, rischia di fare la stessa fine? Durante la visita ai Giardini il dubbio resta, anche se poi negli spazi dell’Arsenale tutto acquista respiro, fondo, emozione. Nanni Delbecchi
The Guardian
Gli artisti sono in ansia per la situazione del mondo e delle proprie nazioni, e a molti di loro non importa se quel che producono è al livello dell’agit-prop. Vista una specie di pianta in pericolo, viste tutte; visto un teschio simbolico, visti tutti; e ho perso il numero degli alberi infetti e degli edifici abbattuti. Il vocabolario dell’arte della Biennale si sta riducendo. Ovunque ci sono bandiere gettate nella spazzatura e orologi ticchettanti, insieme a una varietà di installazioni di negozi: capitalismo in microcosmo. Il che è leggermente ridicolo, dal momento che molti padiglioni sono diventati essi stessi dei negozi, le mostre sono pagate dalle gallerie degli artisti e tutte le opere sono in vendita.
Laura Cumming
Il Messaggero
«All the World’s Futures» ci fa conoscere i lavori di altri autori poco noti o quasi ignorati da una cultura che ha privilegiato europei e americani. No, non è più possibile dividerci fra noi e loro. Ed ecco le tante soprese positive, come mai se ne erano viste nelle precedenti Biennali, di artisti come la brasiliana Sonia Gomes con le sue sbalorditive sculture di stoffa e le installazioni di Barthélémy Togou dal Camerun con i timbri in legno sulle scale di acciaio o le conflittuali visioni pittoriche di Lavar Munroe, originario delle Bahamas.
Massimo Di Forti
Le Figaro
All’ingresso del padiglione internazionale, ai Giardini, Timo Kappeller, direttore della galleria Hauser & Wirth di New York, aspettava il cliente con il listino prezzi delle 17 opere di Fabio Mauri, maestro italiano del dopoguerra morto nel 2009, del quale la Biennale dovrebbe potenziare le quotazioni: da 95mila dollari per i suoi «Schemini», lavagne dove è scritta la frase «In Fine», a un milione di dollari per il suo gigantesco cumulo di valigie. Stesso scenario, ma meno evidente, al fondo dell’Arsenale, dove la spettacolare serie degli otto Baselitz (capovolti) è stata rapidamente venduta a François Pinault per circa 30 milioni di euro dalle gallerie Gagosian, Thaddaeus Ropac e White Cube.
Béatrice de Rochebouët
Altri articoli dell'autore
L’Associazione archeologi del Pubblico Impiego (Api-MiBact) ha inviato una nota al Ministero della Cultura e a quello della Funzione Pubblica, nonché ai membri delle Commissioni cultura di Camera e Senato, per esprimere il proprio dissenso per il bando per 75 posti nell’area dell’elevate professionalità (Ep), le cui domande di partecipazione vanno presentate entro il 26 giugno
Il premio Nobel e il direttore del Museo Egizio si sono incontrati per parlare di musei e romanzi: «Sono simili: sono i “luoghi” in cui avviene l’interpretazione del significato della nostra vita, nei quali riflettere su sé stessi»
Anche quest’anno Tag Art Night, la Notte delle Arti Contemporanee, propone un palinsesto di mostre diffuse sul territorio cittadino
Rimodulate le competenze e modificato la struttura organizzativa: dal Segretariato generale al modello dipartimentale