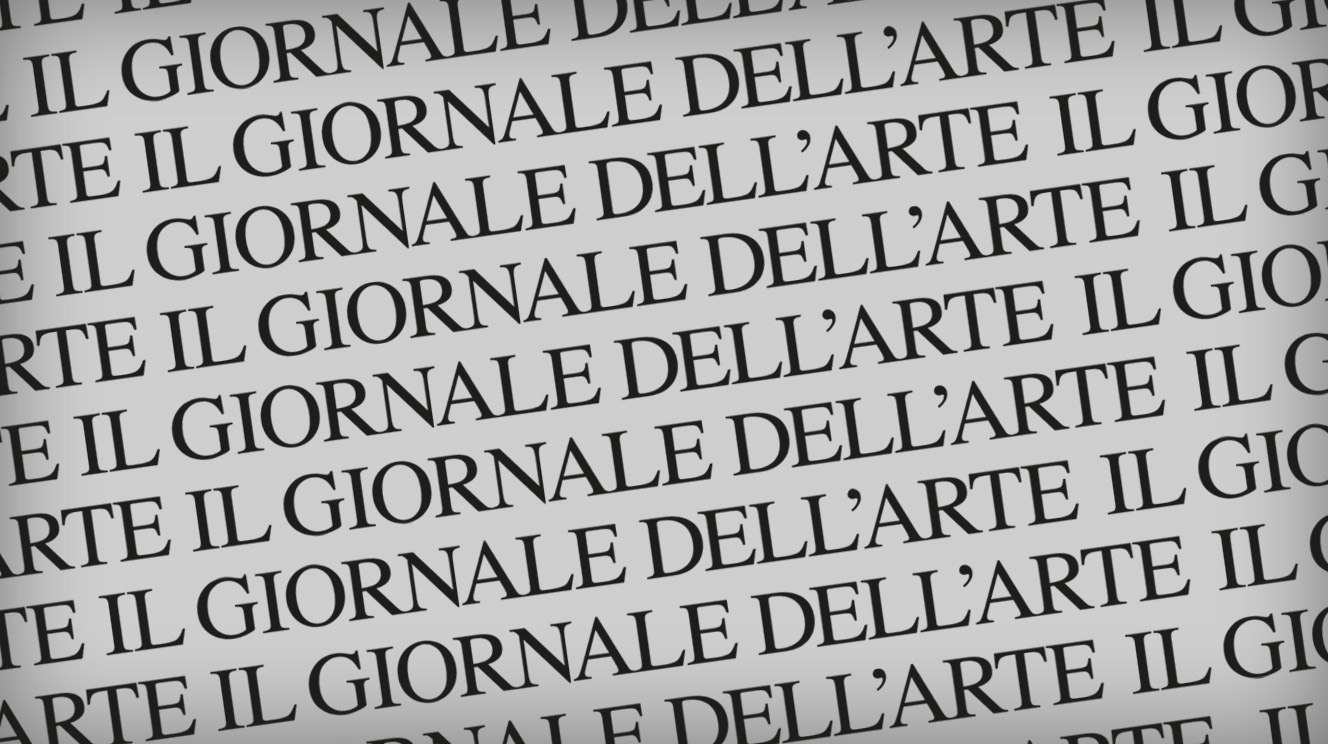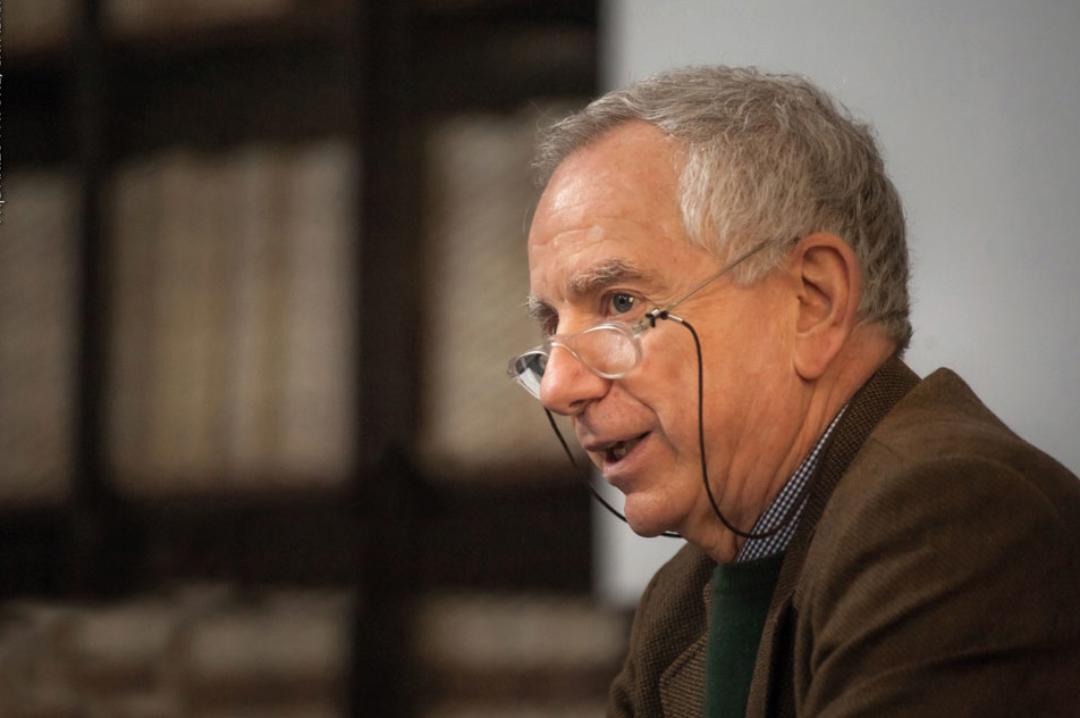Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
.jpeg)
«Ho provato a dare voce, con semplicità ma cercando di evitare la banalità, ai tanti tanti tanti che vorrebbero dire e fare pur qualcosa di positivo per il nostro patrimonio, ma che forse pensano che non ci sia il modo e il luogo per dirlo e per farlo».
Nascono da qui gli «aforismi» che Daniele Manacorda, ordinario di Metodologia della ricerca archeologica presso l’Università di Roma Tre, ha raccolto in un intelligente e poco convenzionale libricino di Istruzioni e ostruzioni per il patrimonio culturale, pensato, anche, in risposta ad altre Istruzioni: quelle per l’uso del futuro che danno il titolo a un libro del 2014 di Tomaso Montanari. Ecco una sintesi dei lemmi che compongono l’abbecedario di Manacorda. Altamente raccomandabile.
A. APPARTENENZA
«Dimmi con chi stai e ti dirò chi sei» è la scorciatoia spesso drammatica che annulla gli individui. Le appartenenze uccidono infatti il giudizio sui singoli e azzerano il merito. Sono tecnicamente la fonte dei peggiori pregiudizi.
La logica delle appartenenze protegge i peggiori e umilia chi ha finalità più alte. I migliori sono legione, anche nella Pubblica Amministrazione, ma la macchina non lavora per loro. È questo il meccanismo da invertire.
B. BELLEZZA
La retorica del Bello che salverà il mondo ci parla di una Bellezza che è fuori dell’oggi e della storia. Se usiamo di meno questa parola ambigua forse facilitiamo la diffusione e la percezione del suo significato.
C. CONSERVAZIONE
Il conservatorismo produce una diagnosi del male, ma sorvola sull’anamnesi, cioè sui motivi che lo hanno generato. Oppure li trova nei fattori esterni all’organismo che si dovrebbe curare.
I conservatori citano a ripetizione l’articolo 9 della Costituzione, ma confondono la Repubblica con lo Stato, perché non sono ancora arrivati a leggere l’articolo 114. Confondono gestione comunitaria e gestione burocratica. Se non hanno letto il 114 come possono conoscere l’articolo 118?
D. DIVULGAZIONE
Per gli «esimi palati» la divulgazione non ha valore scientifico. È l’alibi dei pigri o degli struzzi, di chi non ha mai provato il brivido di una ricerca davvero originale o di chi pensa che una comunicazione meriti il titolo di scientifica solo perché ha un bel corredo di note a piè di pagina.
E. ECONOMIA DELLA CULTURA
Il calcolo economico più importante è quello che misura la ricchezza prodotta nel lungo periodo. Comportamenti sociali rispettosi dei monumenti, del paesaggio e dell’ambiente producono vantaggi duraturi.
F. FOTOGRAFARE
La liberalizzazione voluta da Franceschini ha rimosso un malcostume imbellettato da leggi primitive che avevano vietato le fotografie nei musei. Il visitatore con macchina fotografica era guardato come un ladro dei fumetti, quelli che girano con il grimaldello in mano e la mascherina sugli occhi. Ladri in casa propria.
G. GESTIONE
Chi detta le regole, controlla e valuta non può anche gestire. Uno Stato forte e autorevole dovrebbe cedere quote di potere, svolgendo appieno la sua funzione di indirizzo, di definizione di regole certe, di procedure trasparenti, di standard qualitativi e di seria valutazione. I conflitti di interesse nascono quando il controllore (lo Stato) è anche il controllato (da se stesso).
La parola «manager» suscita nei sacerdoti della tutela striduli anatemi contro il mercante che penetra nel tempio per mercificare la cultura. Ma il manager non «comanda»; dà concretezza alle scelte formulate da un pool di competenze.
H. HERITAGE
L’espressione inglese Cultural Heritage ha il pregio di non amareggiare gli «esimi palati», che storcono il naso alla sola parola «patrimonio», solforosa espressione che evoca monetizzazioni e mercificazioni.
I. IDENTITÀ
Parliamo spesso delle nostre «radici». Un termine ambiguo perché un albero senza radici perde le foglie e non dà frutti, ma sappiamo anche che i frutti migliori provengono dagli innesti.
L. LINEE GUIDA
La riforma del Mibact ha creato una specifica Direzione generale per i Musei con il compito, fra altri, di favorire «la loro funzione di luoghi vitali, inclusivi», capaci di promuovere «la partecipazione attiva degli utenti». Qualcosa forse si muove.
M. MARKETING
Fuorviati dall’ossessione pubblicitaria di automobili e detersivi, il marketing sembra a molti nel settore culturale qualcosa che porta nel sacrario dell’arte la volgarità di Dulcamara. Ma se lo intendiamo per quello che è, un museo d’arte o un parco archeologico trovano nella sua pratica un alleato potente.
N. NO
Nella società italiana, come in molte società dell’Occidente, la logica del NO prevale su quella ben più impegnativa del SÌ. Il NO non si misura con una propria progettualità, il SÌ invece la impone.
Dire sempre e comunque NO significa confessare una sostanziale impotenza politica che ostacola una innovazione colta. Alla fine dei giochi non tutela il patrimonio.
O. OLISTICO
Fa piacere leggere nel testo di riforma del Mibact che le nuove Commissioni regionali per il patrimonio culturale dovranno favorire l’integrazione multidisciplinare tra i diversi istituti e garantire una visione olistica del patrimonio culturale. È un passo in avanti. Ma non sarebbe stato più semplice prevedere Soprintendenze uniche?
P. PETROLIO
La valorizzazione è una parola bellissima, perché descrive la mèta di un processo di promozione della cultura, che parte dalla ricerca (che è riconoscimento di valore) e passa attraverso la tutela.
Bandiamo pure l’infelice metafora, magari sostituendola con «risorsa», che non si presta a letture ambigue. Oppure facciamo un patto: gli uni non usino a sproposito la parola petrolio e gli altri facciano altrettanto con la parola bellezza.
Q. QUATTRINI
I finanziamenti sono così miserabili perché le strutture sono inefficienti o le strutture sono diventate sempre più inefficienti perché le risorse sono sempre più inadeguate? Una buona cartina di tornasole può darla l’analisi delle capacità di spesa di una istituzione.
R. RESTAURO
Maneggiando il nostro patrimonio monumentale e d’arte dovremmo liberarci dal demone del falso, preservando l’amore per l’autentico, dal demone del frammento, preservando l’interesse per il documento, dal demone dell’antico, preservando l’attenzione a tutto ciò che può raccontarci il passato.
S. SPECIALIZZAZIONE
La tutela ha bisogno di cultura, non di erudizione. In mancanza di cultura scattano la gestione burocratica e la concezione proprietaria dei beni culturali che focalizza la propria attenzione sulla sola conservazione del patrimonio.
T. TURISMO
Il turismo è democrazia: sta ai ceti più colti decidere se arroccarsi arricciando il naso nei propri angoli di paradiso evitando il contatto con le masse o se mettersi in gioco trasferendo le proprie competenze nella comunicazione di quel patrimonio, accettando anche le inevitabili contaminazioni.
U. UNIVERSITÀ
Da tempo è sul tappeto la proposta di istituire dei «policlinici del patrimonio» su scala territoriale. Come l’organismo umano, anche paesaggi, monumenti e opere d’arte sono sistemi complessi che non possono essere guardati con una sola lente.
V. VALLETTA (Convenzione della)
Nessuno dei Governi dell’ultimo ventennio aveva adottato la Convenzione per la protezione del patrimonio archeologico, che pur avevamo sottoscritta. I casi sono due: o si firma o si dice perché non si vuole firmare.
P.s. Finalmente la ratifica è arrivata con la legge 57 del 29 aprile 2015.
Z. ZERO
In una società democratica la ricchezza versata per la salvaguardia del patrimonio è proporzionale alla percezione del suo valore e all’uso sociale che ne viene fatto. Dunque Zero è la quota di Pil che gli italiani, diseredati e indifferenti, intendono investire nel patrimonio culturale ormai non più loro.
L’Italia agli italiani. Istruzioni e ostruzioni per il patrimonio culturale, di Daniele Manacorda, 152 pp., Edipuglia, Santo Spirito (Bari) 2014, € 12,00
Altri articoli dell'autore
L’ultimo libro di Giuliano De Felice per Laterza secondo Daniele Manacorda opera una «“scelta di campo” rischiosa»
L’archeologo Daniele Manacorda traccia una road map per il neonominato al dicastero del Collegio Romano
Il vero problema sembra essere la nuova (vecchia) organizzazione per Dipartimenti, già varata ai tempi del ministro Buttiglione e presto abbandonata non per motivi politici, ma perché ritenuta non adeguata a un Dicastero come quello della Cultura, capillarmente distribuito sul territorio
Considerazioni sul decreto ministeriale sui canoni di concessione d’uso della immagini del patrimonio culturale pubblico