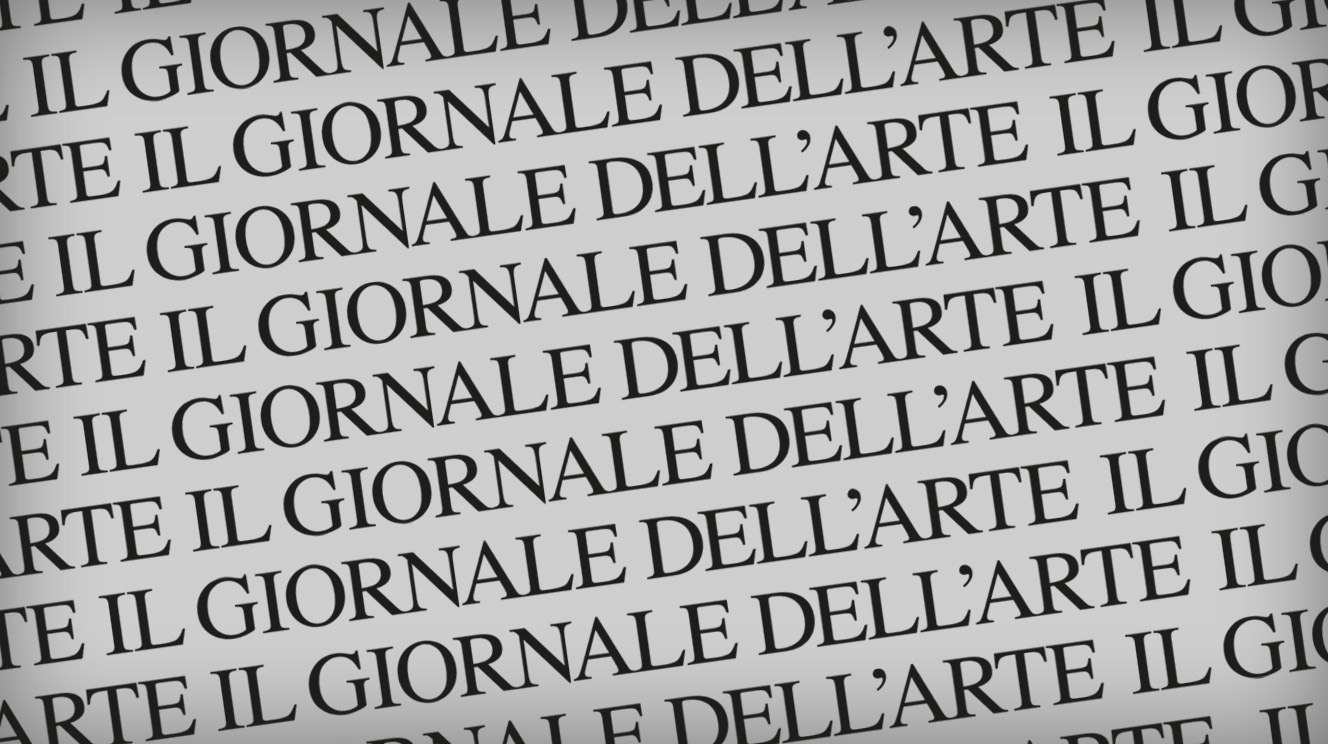Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Federico Castelli Gattinara
Leggi i suoi articoliA Palazzo Altemps vestigia antiche e contemporanee
La parola «rovine» rimanda alle acqueforti del Piranesi, ai capricci settecenteschi di Pannini, di Canaletto e Guardi, opere bellissime quanto straviste in mostre e rassegne. Di tutt’altro genere è «La forza delle rovine» curata da Marcello Barbanera, docente presso La Sapienza di Roma che sul tema ha pubblicato più di uno studio (Metamorfosi delle rovine è uscito per Electa nel 2013), e Alessandra Capodiferro, direttrice del museo di Palazzo Altemps che ospita la mostra dall’8 ottobre al 31 gennaio.
Una collocazione certo non facile data l’impegnativa connotazione tanto del contenitore cinquecentesco quanto del contenuto, una delle più celebri raccolte del mondo di statuaria classica, la collezione Boncompagni Ludovisi. Poi c’è l’attualità, il disastro che tutti i giorni raccontano i mezzi di comunicazione, le «rovine» che vengono prese a picconate o fatte saltare in aria, a Mosul, Nimrud e Hatra in Iraq, poi anche a Palmira in Siria, dove il magnifico Santuario di Bel è svanito in una nuvola di polvere.
Non è un caso se la mostra prende le mosse proprio dall’attualità, dalle rovine moderne e contemporanee, dalle catastrofi naturali o artificiali più o meno recenti, per esplorare il tema a fondo da punti di vista anche meno scontati. C’è la Beirut distrutta nello scatto di Gabriele Basilico, l’Ucraina in quelli di Larry Towell e Jean Gaumy, la Gibellina dipinta da Guttuso e fotografata da Cristaldi, tele ancora di Guttuso, Mafai e Carl Hofer.
La rovina si presta a chiavi interpretative anche opposte, sempre in bilico tra simbolo di caducità di ogni opera umana ed estremo baluardo di resistenza di civiltà e culture del passato, in ultima analisi della nostra identità. Inoltre la mostra tiene conto del luogo in cui si svolge, praticamente l’opposto dell’idea contemporanea del «cubo bianco», anche perché attraversa il museo praticamente in tutte le sue sale. «La forza delle rovine» del resto dialoga fitto con i marmi Ludovisi, basti pensare alla pratica sei-settecentesca dei restauri dei pezzi antichi, le integrazioni (e le aggiunte) d’autore alle parti mutile delle sculture della raccolta a opera di Bernini, Algardi e Cavaceppi, per citare solo i più noti.
Certo poi non possono mancare le incisioni del Piranesi, né i dipinti con rovine che per secoli sono stati un genere di successo mai scaduto (Monsù Desiderio, Viviano Codazzi, Ippolito Caffi, Hubert Robert, Marco Ricci, Arturo Nathan), accanto ai molto contemporanei «paesaggi rovinati» nelle foto di Luigi Ghirri, Martin Parr, Lori Nix, Marchand e Meffre, Basilico e altri.
«Definire l’oggetto della mostra, scrivono i curatori nel catalogo Electa, è quasi impossibile, dato il suo aspetto proteiforme. Walter Benjamin infatti vedeva nelle rovine l’allegoria del pensiero stesso». La loro esplicita intenzione «è stata fin dall’inizio porre il visitatore non in una condizione contemplativa ma di esortazione alla riflessione, facendo nostra la riflessione di molti artisti del dopoguerra, come Joseph Beuys o Anselm Kiefer, che sulle rovine hanno fondato molta della loro poetica».
Altri aspetti, tradotti in sezioni della mostra, sono: il «Torso: dal desiderio di integrità al culto del frammento», con studi e opere di Martini, foto di Mapplethorpe, sculture di Rodin e Mitoraj, tele di Gérôme, von Maron, Gossart, Kauffmann e Fortuny, oltre al calco del Torso del Belvedere in prestito da Villa Medici e affiancato al cosiddetto «Polifemo» della collezione Altemps; «L’errore di Diderot», sulla percezione delle rovine nell’antichità; «(Ri)costruire la rovina», sulla relazione tra archeologia e modernità dall’Ottocento ai nuovi scavi.
Altri articoli dell'autore
Tra Foro Romano e Palatino sono stati ritrovati i resti di una lussuosa dimora con una sala per banchetti a forma di grotta e uno straordinario mosaico impreziosito con conchiglie, vetri e tessere blu egizio
Si inizia con l’enigmatico scultore ateniese. Altre due monografiche saranno dedicate a Prassitele e a Skopas
Stéphane Verger nel chiostro di Michelangelo ha fatto eseguire interventi su sette teste di animali antiche (quattro di età adrianea e tre rinascimentali) e ne ha commissionata un’ottava a Elisabetta Benassi
Lo scavo condotto dalla Soprintendenza speciale di Roma ha riportato alla luce strutture in laterizio e un sontuoso apparato decorativo riconducibili a una committenza di altissimo rango, quasi sicuramente imperiale