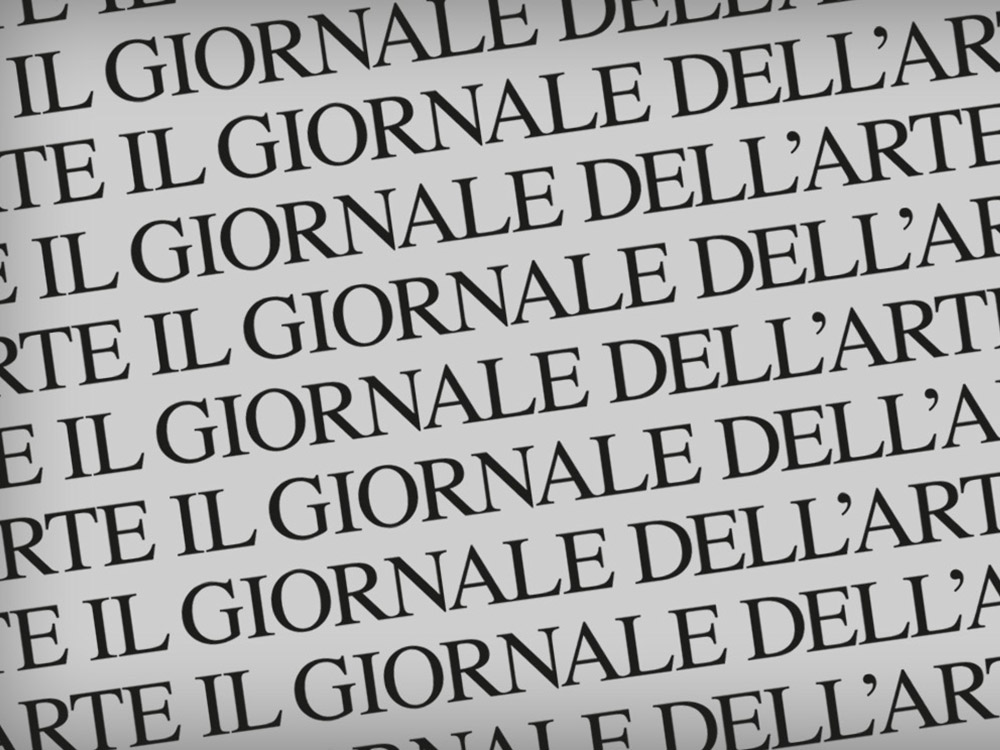Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Federico Castelli Gattinara
Leggi i suoi articoliUn’estesa rappresentazione della Collezione Torlonia mai vista finora nella sua totalità: dopo quarant’anni di abusi e «prigionia» diventerà un museo
Non è mai persona colta, la quale non conosca, o di vista o di fama, il museo Torlonia, presso la porta Settimiana. Dopo circa 40 anni di larghissimi dispendi e di cure, il principe Alessandro Torlonia, seguendo le gloriose tradizioni di altri magnanimi patrizi romani dei secoli passati, è pervenuto a formare una sì vasta collezione di antiche sculture, che superando a gran pezza qualunque altra raccolta privata, può essere paragonata soltanto coi più nobili e celebrati musei pubblici, che si ammirano in Roma, o in qualche altra delle più cospicue e potenti metropoli di Europa».
Così scriveva Carlo Lodovico Visconti il primo giugno 1885 in prefazione a I monumenti del Museo Torlonia riprodotti con la fototipia da lui curato, quarta edizione del catalogo della raccolta (la prima del 1876 era stata curata dallo zio Pietro Ercole Visconti) affiancata questa volta dalla novità di un impeccabile corpus di illustrazioni di ogni singolo pezzo. Certo è triste pensare che da un livello così alto di passione e intelligenza per l’arte classica, parliamo di 620 opere d’arte greca e romana, la più vasta e importante raccolta del genere ancora in mani private, circa un secolo dopo non rimanesse più nulla.
Delle 77 sale del palazzo presso la porta Settimiana in cui era allestita la raccolta, i discendenti Torlonia fecero 93 miniappartamenti abusivi, un’incredibile «distruzione del Museo e di quanto esso rappresentava per gli studiosi», come scrisse la Corte di Cassazione il 27 aprile 1979, che denunciò il trasloco delle opere «in locali angusti, insufficienti, pericolosi (...) stipate in maniera incredibile, addossate l’una all’altra senza alcun riferimento storico o di omogeneità». Da quel fatto increscioso per l’intera Nazione sono passati circa quarant’anni di tormenti per trovare una soluzione.
Oggi tutto il mondo festeggia l’accordo tra gli eredi e lo Stato firmato lo scorso 15 marzo al Collegio Romano, e specificatamente tra la Fondazione Torlonia Onlus da un lato e le Direzioni generali per l’Archeologia e per le Belle arti e il Paesaggio e la Soprintendenza speciale per il Colosseo dall’altro. Ma è solo l’inizio di un percorso, la guardia va tenuta alta perché sulla collezione ci sono ancora molte decisioni da prendere.
Che l’amministrazione Torlonia già prima non fosse di manica larga con le visite è cosa nota, ma agli studiosi in genere venivano concesse, almeno fino a una certa data. Per quanto, lo ricorda Antonio Cederna (1921-96), nell’immediato dopoguerra uno specialista come Ranuccio Bianchi Bandinelli, allora direttore generale delle Antichità e Belle arti, preferì travestirsi da spazzino e «attaccare bottone» col custode per riuscire a vedere la collezione dal vivo.
Cederna non si stancò mai di gridare allo scandalo per la speculazione edilizia in via della Lungara, con mutui concessi dalle banche e il cavallo di Troia di una licenza per la riparazione del tetto, e per il conseguente confino delle sculture «l’una sull’altra in tre umidi scantinati, come rifiuti e detriti di magazzino». Lottò invano insieme a Italia Nostra per l’acquisizione da parte dello Stato della collezione tutelata da un vincolo fin dal 1910 (rinnovato nel 1948), denunciando pubblicamente la vergogna della situazione dalle colonne del «Corriere della Sera» e di «la Repubblica» e in ogni sede, subendo una causa per diffamazione, lanciando un appello all’Unesco, presentando da deputato una proposta di legge nel 1990. Seguita nel 2002 da un secondo disegno di legge dei senatori Sodano, Malabarba e Togni che prospettava l’acquisizione della collezione al Demanio dello Stato e il suo allestimento nel Palazzo dei Musei in via dei Cerchi. Tutto inutile. Come inutili furono i tentativi di Walter Veltroni da sindaco di Roma e di Silvio Berlusconi da premier, quando nel 2003 cercò di comprare la raccolta di tasca propria per poi «regalarla» agli italiani.
Negli anni si è parlato di esporla a Palazzo Torlonia (già Giraud) in via della Conciliazione, alle Scuderie del Quirinale, all’ex Mattatoio di Testaccio, all’Arsenale Pontificio di Porta Portese, a Palazzo Rivaldi, nella stupenda Villa Albani sulla Salaria, in quest’ultimo caso previo rilascio alla famiglia di una concessione per la costruzione nel parco storico di un parcheggio interrato per 600 posti macchina. A guastare i rapporti ci si mise anche il brutto episodio dell’«Hestia Giustiniani», uno dei pezzi più celebri della raccolta Torlonia e tra i rarissimi prestiti concessi dalla famiglia: durante l’allestimento di una mostra al Colosseo nel 2008, la scultura in marmo subì un danno (forse non così grave) a un braccio, divenendo così l’oggetto di un aspro contenzioso, tra perizie e controperizie, per il risarcimento plurimilionario preteso dai Torlonia, che voci di corridoio dicono abbiano chiuso la trattativa «accontentandosi» di un milione di euro.
Oggi finalmente si è tracciato un percorso che porterà prima a un’importante mostra nel Palazzo Caffarelli di Roma nella seconda metà del 2017, curata da Salvatore Settis e Carlo Gasparri che da decenni si occupa della collezione, poi a due sue tappe probabilmente a Londra e a New York, infine alla nascita di un museo ad hoc, in una sede romana ancora da decidere. La raccolta Torlonia è importante per almeno tre motivi: è ricchissima di capolavori, è una collezione delle collezioni, avendo assorbito in sé raccolte precedenti di inestimabile valore, ed è uno specchio del gusto antiquario, di come è stata vista, interpretata e restaurata la classicità a partire dal Cinquecento.
I grandi capolavori
Ci sono opere notissime come l’«Hestia Giustiniani», copia romana di un originale greco di metà V secolo a.C., la «Fanciulla Torlonia» dagli scavi della città etrusca di Vulci, l’«Ulisse che esce dall’antro di Polifemo» già Albani, la galleria dei 107 busti della Roma repubblicana e imperiale con pezzi rari come il «Galba da Otricoli» e l’«Eutidemo di Battriana», le copie da Policleto, Mirone, Lisippo, vari sarcofagi tra cui quello con «Le fatiche di Ercole» e il «Sarcofago Savelli», l’«Afrodite Anadiomene», il bassorilievo con la veduta del porto ostiense di Claudio e molto altro ancora.
Collezione di collezioni
La raccolta mostra anche uno straordinario spaccato di storia del collezionismo italiano. La prima fondamentale acquisizione Torlonia fu quanto lasciato nel 1799 dallo scultore e restauratore di antichità Bartolomeo Cavaceppi per via testamentaria e «fino all’ultimo chiodo e minima scaglia» all’Accademia di San Luca, che mise subito tutto all’asta. Tra queste opere figurano pezzi importanti provenienti da collezioni più antiche, tra cui la Savelli, la Cesi e la Pio da Carpi.
La parte del leone però la fa la collezione di Vincenzo Giustiniani, uno dei più grandi conoscitori d’arte di primo Seicento, acquisita nel 1816 (il catalogo del Visconti gli assegna circa 130 sculture, ma sappiamo che furono almeno il doppio a finire in mani Torlonia). Un altro nucleo importante proviene dalla Villa Albani, ceduta nel 1866 dai Castelbarco insieme alla collezione di antichità ordinata a suo tempo da Winckelmann, che del cardinale Albani era bibliotecario e principale consigliere.
Da lì viene, per esempio, il celebre «Vaso Cesi», riprodotto in molte vedute cinquecentesche del giardino di Borgo. Ci sono poi anche pezzi dalle collezioni Cesarini, come il famoso «Nilo» in basalto, e Caetani, finita ai Ruspoli che la dispersero. Molte opere infine sono frutto dei tanti scavi ottocenteschi nelle proprietà Torlonia, da Vulci, Cerveteri e Anzio, dalle ville dei Quintili e di Massenzio sull’Appia, dalla Villa dei Gordiani sulla Prenestina, dalla Valle della Caffarella, da Porto e da svariate altre località, compreso quel lago del Fucino di cui nel 1877 il principe banchiere Alessandro riuscì a portare a termine la bonifica: sua la celebre frase «O Torlonia asciuga il Fucino, o il Fucino asciuga Torlonia».
La visione della classicità
Il catalogo di Visconti, di cui riproduciamo in queste pagine alcune tavole, fu un’opera straordinaria per la fine dell’Ottocento, ma con alcuni vistosi limiti: sia per l’inaffidabilità circa provenienza e storia dei pezzi, sia per l’assenza di indicazioni su stato conservativo e integrazioni delle opere.
Ci sono infatti restauri d’autore firmati Algardi, Bernini e Duquesnoy, a volte più interessanti dei frammenti originali; integrazioni di tutti i tipi, in alcuni casi anche frutto di errate interpretazioni; rifacimenti talmente ben fatti che a fatica gli studiosi riescono a distinguere le parti antiche da quelle moderne: è il caso dell’Eros su biga tirata da cinghiali, di cui solo uno dei due animali è originale.
E ancora marmi di scavo non integrati, come la Fanciulla Torlonia; tanti ritratti antichi montati su busti moderni, rifacimenti in pieno stile classicista, revisioni di vecchi restauri e persino veri e propri «pastiche».
Altri articoli dell'autore
Tra Foro Romano e Palatino sono stati ritrovati i resti di una lussuosa dimora con una sala per banchetti a forma di grotta e uno straordinario mosaico impreziosito con conchiglie, vetri e tessere blu egizio
Si inizia con l’enigmatico scultore ateniese. Altre due monografiche saranno dedicate a Prassitele e a Skopas
Stéphane Verger nel chiostro di Michelangelo ha fatto eseguire interventi su sette teste di animali antiche (quattro di età adrianea e tre rinascimentali) e ne ha commissionata un’ottava a Elisabetta Benassi
Lo scavo condotto dalla Soprintendenza speciale di Roma ha riportato alla luce strutture in laterizio e un sontuoso apparato decorativo riconducibili a una committenza di altissimo rango, quasi sicuramente imperiale