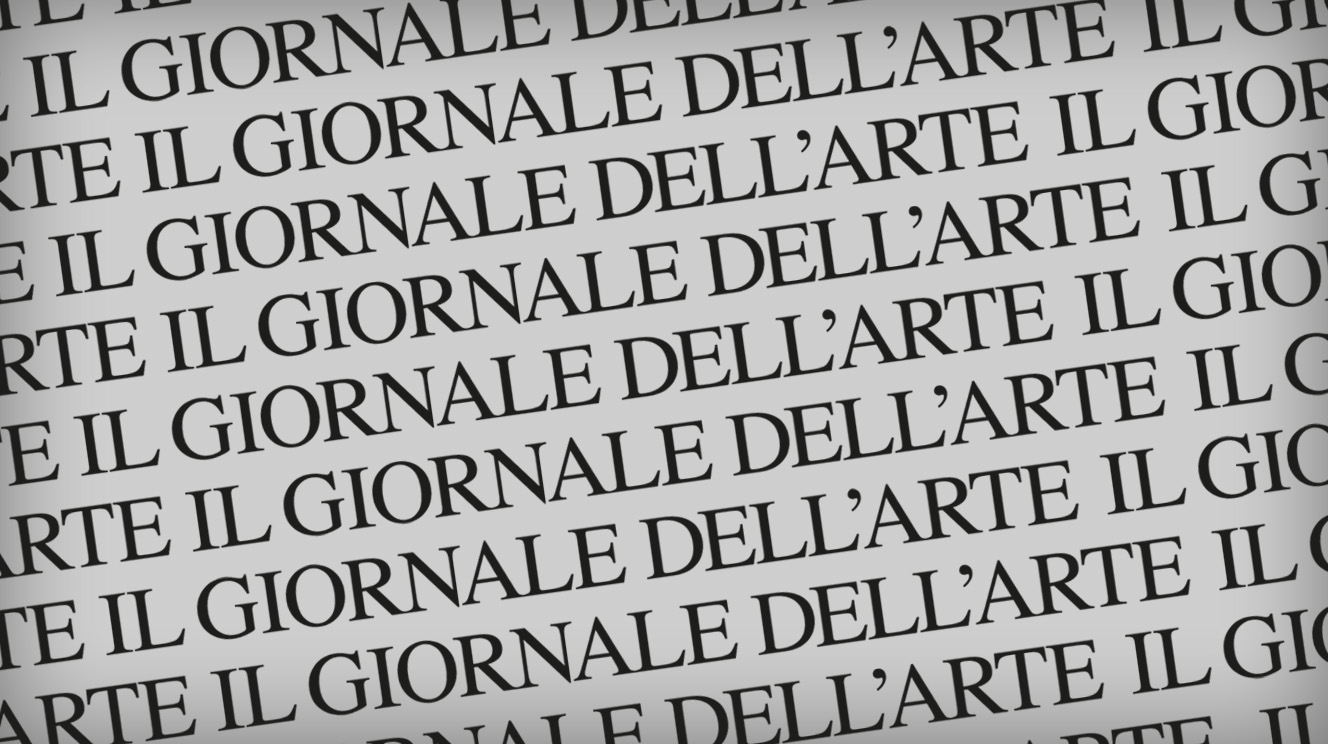Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Laura Lombardi
Leggi i suoi articoliIl «Ritratto di gentildonna» detto «La Muta», opera del periodo fiorentino di Raffaello (1505-07), proviene probabilmente dall’eredità di Vittoria della Rovere. Nel 1710 il dipinto è in Palazzo Pitti; poi trasferito nella villa medicea di Poggio a Cajano vi rimane fino al 1926, anno in cui è documentato agli Uffizi, per poi passare l’anno successivo nella Galleria Nazionale delle Marche in cui è attualmente conservato. Ora torna in questa sede dopo l’intervento dell’Opificio delle Pietre Dure che, svolto sotto la direzione di Marco Ciatti con la consulenza di Cecilia Frosinini, ha evidenziato i riferimenti ai modi di Leonardo cui rimanda anche la posa del ritratto simile alla «Gioconda».
Rispetto allo sfondo paesistico di quest’ultima tuttavia, Raffaello pone la figura a contrasto con un fondo scuro e uniforme, creando un risalto della figura che l’attuale pulitura da vernici, patinature e ridipinture, esalta. La leggibilità dell’opera è accresciuta in ogni parte: dalla finezza delle pennellate nelle pieghe delle vesti alla catena d’oro che proietta l’ombra sull’incarnato, dai capelli che sfuggono dall’acconciatura alla stesura sottilissima del volto. Nel bianco dell’occhio si intravede la traccia di un primo disegno (poi non seguito) per le pupille e per le ciglia, mentre la radiografia rivela un altro pentimento nella posa della mano destra.
La maestria espressa nelle velature, davvero unica, sembra confermare la paternità raffaellesca, in passato messa in dubbio dalla critica che aveva suggerito nomi quali Ridolfo del Ghirlandaio o Bugiardini. «La Muta» (la cui identità rimane ignota, ma tra le proposte vi è quella che si tratti di Giovanna Feltria, figlia di Federico da Montefeltro andata in sposa a Giovanni della Rovere) era divorata dai tarli. Attraverso una Tac messa a punto dal Cnr di Bologna sono stati individuati e riempiti i buchi più profondi che rischiavano di causare uno sfarfallamento del colore.
L’intervento, svolto con i fondi del Mibact e dello sponsor giapponese Yomiuri Shinbun, rientra negli intenti sperimentali dell’Opificio che conduce ogni restauro anche come progetto di ricerca. Gli esiti saranno pubblicati nel volume Edifir a cura di Maria Rosaria Valazzi e Marco Ciatti, numero 43 della collana dedicata ai restauri dell’Opificio.
Altri articoli dell'autore
Nel cinquantenario della sua fondazione, l’istituzione gli ha intitolato la sala dedicata all’esposizione del suo patrimonio storico
La Cappella fa parte del Complesso di Santa Maria Maddalena dei Pazzi nella cui chiesa, all’epoca dei Cistercensi, le donne erano ammesse soltanto due volte l’anno
Il moderno Opd, erede dell’omonima manifattura granducale di fine Cinquecento, compie 50 anni. La Cappella Bardi in Santa Croce è l’ultimo di una serie di restauri capitali condotti dall’istituzione attualmente diretta da Emanuela Daffra che illustra difficoltà ed eccellenze
Il nuovo segretario generale della Biennale Internazionale dell’Antiquariato di Firenze punta a rafforzare il legame con la città, ampliare il pubblico della manifestazione, integrare arte antica e contemporanea e collaborare con gli artigiani locali