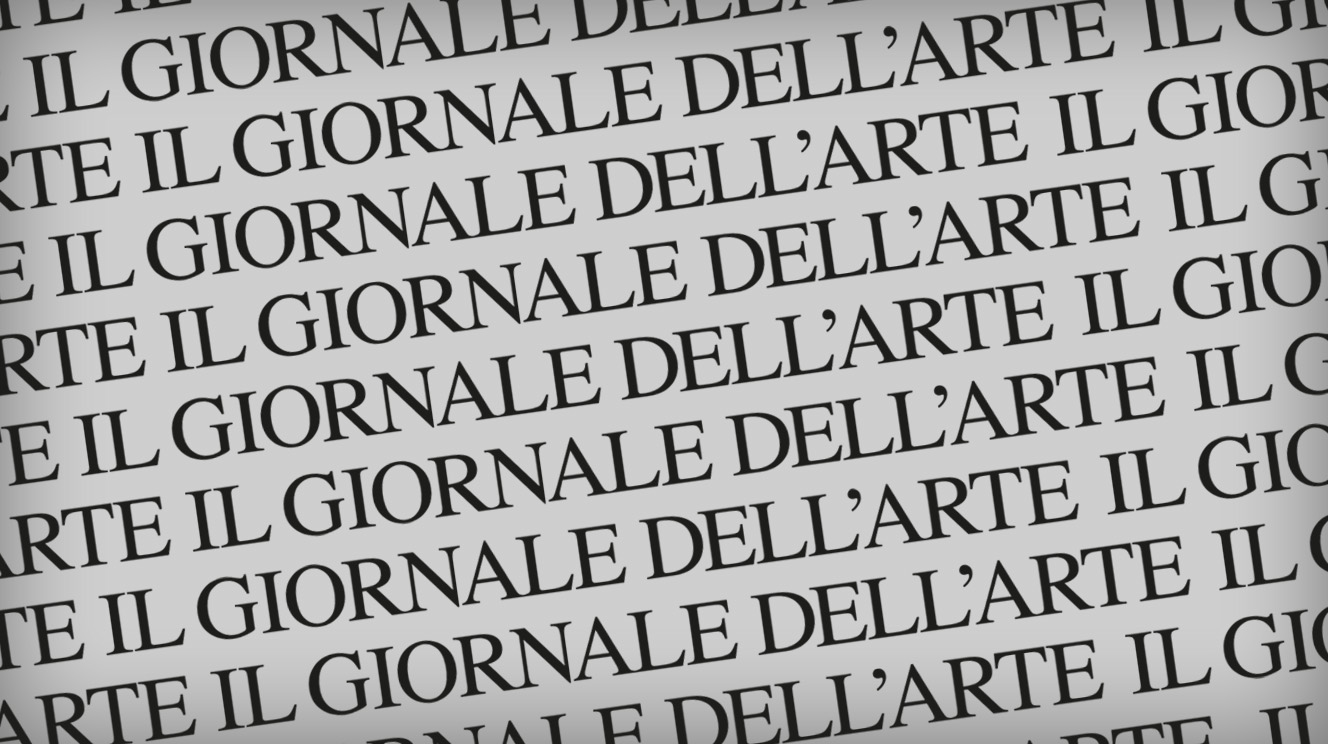Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Marco Riccòmini
Leggi i suoi articoliUna nuvola copre il sole, e all’improvviso è notte. La luce dura poche ore in Russia a quest’epoca dell’anno. Ma è con la fine dell’estate che, quasi in sordina, il Museo Pushkin ha tirato fuori dalle cantine 120 «nuovi» quadri italiani, da una Crocifissione del riminese Giovanni Baronzio fino a due testine del conte Pietro Antonio Rotari.
La novità è che nessuno sapeva che fossero a Mosca, e Mosca ha sempre negato di averli. Trafugati a Berlino a guerra appena finita nei primi mesi di occupazione sovietica, le macerie ancora fumanti, parapiglia e confusione, questi giunsero in Russia senza altra indicazione che quella del numero del treno e del vagone su cui avevano viaggiato. Per decenni storici dell’arte del secolo scorso, gingillandosi con vecchi bianchi e nero delle fototeche di Berenson e Longhi, si sono lambiccati per capire che fine avessero fatto, se distrutti dalle bombe oppure scomparsi chissà dove. Stavano a Mosca, oltre la cortina di ferro, protetti da sguardi e domande indiscrete.
Oggi il mondo è cambiato, o così devono pensarla al Ministero della cultura russo se, dopo un’esitazione durata due anni (nell’introduzione al catalogo si legge che il volume era pronto già nel 2012), i quadri sono esposti al pubblico, seppure senza alcuna forma di pubblicità. Ma a differenza del catalogo dei dipinti italiani stampato dal Pushkin nel 2002, questo dei «ritrovati» dipinti italiani (Italian Paintings 14th - 18th Centuries), a cura di Vittoria Markova, è eccezionalmente bilingue, russo e inglese (salvo la copertina, solo in cirillico). Una parte delle opere trasportate a est dell’Oder dal 1945 in poi venne restituita dai russi alla Gemäldegalerie Alte Meister di Dresda già negli anni Cinquanta, quando era ancora Ddr. Ma i dipinti oggi esposti, di cui un quarto prima della guerra arricchiva i palazzi reali di Berlino e altri palazzi in Prussia, restarono celati a Mosca.
Alcuni sono di provenienza Giustiniani (sia del cardinale Benedetto sia del più giovane fratello, marchese Vincenzo), altri appartennero a Edward Solly (1776-1848), che nel 1812 cedette oltre 3mila quadri allo Stato prussiano per pagare i propri debiti. Altri ancora sono frutto di razzie naziste, come le opere «acquistate» ad Amsterdam nel 1941 dalla vedova di Otto Lanz (1865-1935), tutte rese dopo la guerra tranne il «Lot e le figlie» di Rutilio Manetti (cat. 68) e il «Ritratto di Giovanni Grassi» di Alessandro Longhi (cat. 118), oggi in mostra al Pushkin. Molti dei quadri esposti sono rinascimentali, e alcuni sono già noti agli studiosi grazie a foto d’archivio.
Vi sono però alcune scoperte di rilievo, come le due aggiunte al catalogo di Paolo Veronese, la «Santa con una clessidra» (Maddalena? cat. 56) e il «Compianto sul Cristo» (cat. 57), variante della tela all’Ermitage, già di Olimpia Aldobrandini, contessa di Rossano, poi dello storico dell’arte Hermann Voss (Lüneburg, 1884 - Monaco di Baviera, 1969). La maggior parte dei dipinti barocchi apparteneva alla raccolta segretamente accumulata dal grande storico dell’arte tedesco.
Se non fosse per quei 16 disegni che Voss vendette nel 1954 al Los Angeles County Museum of Art (tra i quali un Rutilio Manetti, un grande foglio di Solimena e uno di Gaetano Gandolfi di soggetto mitologico), nessuno avrebbe avuto contezza fino ad ora della sua passione collezionistica, forse in conflitto col suo impiego nei musei statali.
Grande conoscitore della pittura italiana, Voss è noto soprattutto per il suo Die Malerei des Barock in Rom del 1924 (La pittura del Barocco a Roma del 1925). Cominciò la carriera nei musei tedeschi come curatore della collezione grafica di Lipsia (1913), poi divenne capo dipartimento della pittura italiana del XVII e XVIII secolo del Kaiser Friedrich Museum di Berlino, quindi lavorò presso la collezione municipale di arte di Wiesbaden (1935), fino ad assumere la dirigenza nel 1943 della Gemäldegalerie di Dresda su nomina diretta del führer. Fu proprio la sua (forse inevitabile) collusione col regime nazista a creargli qualche problema a guerra finita. Nel marzo 1943, alla morte di Hans Posse, Hitler lo nominò direttore della Commissione Linz (Sonderauftrag Linz), ossia del costruendo Führermuseum su faraonico progetto di Albert Speer.
Pare che nel breve periodo del suo mandato Voss riuscì ad assicurare al museo circa 3mila opere, sulla cui legittima provenienza si potrebbe speculare. Tornando alla sua raccolta, che sul finire della guerra e con l’intensificarsi dei bombardamenti alleati ricoverò prima nelle miniere di sale di Altaussee poi presso lo Schloss Weesenstein, questa venne interamente confiscata dai russi nel 1946 alla moglie Marianna, rimasta a Dresda, mentre il marito nel 1945 cercava rifugio a Monaco di Baviera. I suoi quadri arrivarono a Mosca tre anni più tardi rispetto a tutti gli altri, nell’agosto 1948.
Tra questi c’è anche il «Baccanale» attribuito a Castiglione (cat. 77) in copertina del catalogo (che sia piuttosto di Andrea de Lione?), il «Lot e le figlie» di Sebastiano Mazzoni (cat. 79), i «Sarmati alla tomba di Ovidio» di Johann Heinrich Schönfeld (cat. 90), artista su cui lo storico pubblicò la prima monografia nel 1964, dove ammetteva che quel quadro un tempo era stato suo. Tornando al catalogo, ben illustrato e ricco di documentazione (al fondo si trova un’utile raccolta fotografica dei timbri e dei cartellini sul retro dei dipinti, così da facilitare il riconoscimento della provenienza), questo testimonia di un impegnativo lavoro di ricerca sulle provenienze dei dipinti e sulle loro possibili attribuzioni, tenendo a mente che si partiva spesso da zero. Occorrerà solo aggiustare il tiro su qualche attribuzione. La «Testa di donna con turbante» (cat. 87) di scuola bolognese è della poco nota Ginevra Cantofoli, come pure l’altra fanciulla chiamata col nome di Cignani (cat. 92). Al romano Andrea Casali va resa la «Carità» detta di Francesco Trevisani (cat. 106) e a Jan Frans van Bloemen il «Paesaggio» attribuito ad Andrea Locatelli (cat. 114).
Altri articoli dell'autore
Parte quarta • Città, moschee e sinagoghe in 5 Paesi a portata di mano (Italia esclusa), dall’Albania all’Algeria, da Cipro Nord alla Tunisia
Parte terza • Città, moschee e sinagoghe in 5 Paesi a portata di mano (Italia esclusa), dall’Albania all’Algeria, da Cipro Nord alla Tunisia
Parte seconda • Città, moschee e sinagoghe in 5 Paesi a portata di mano (Italia esclusa), dall’Albania all’Algeria, da Cipro Nord alla Tunisia
Parte prima • Città, moschee e sinagoghe in 5 Paesi a portata di mano (Italia esclusa), dall’Albania all’Algeria, da Cipro Nord alla Tunisia