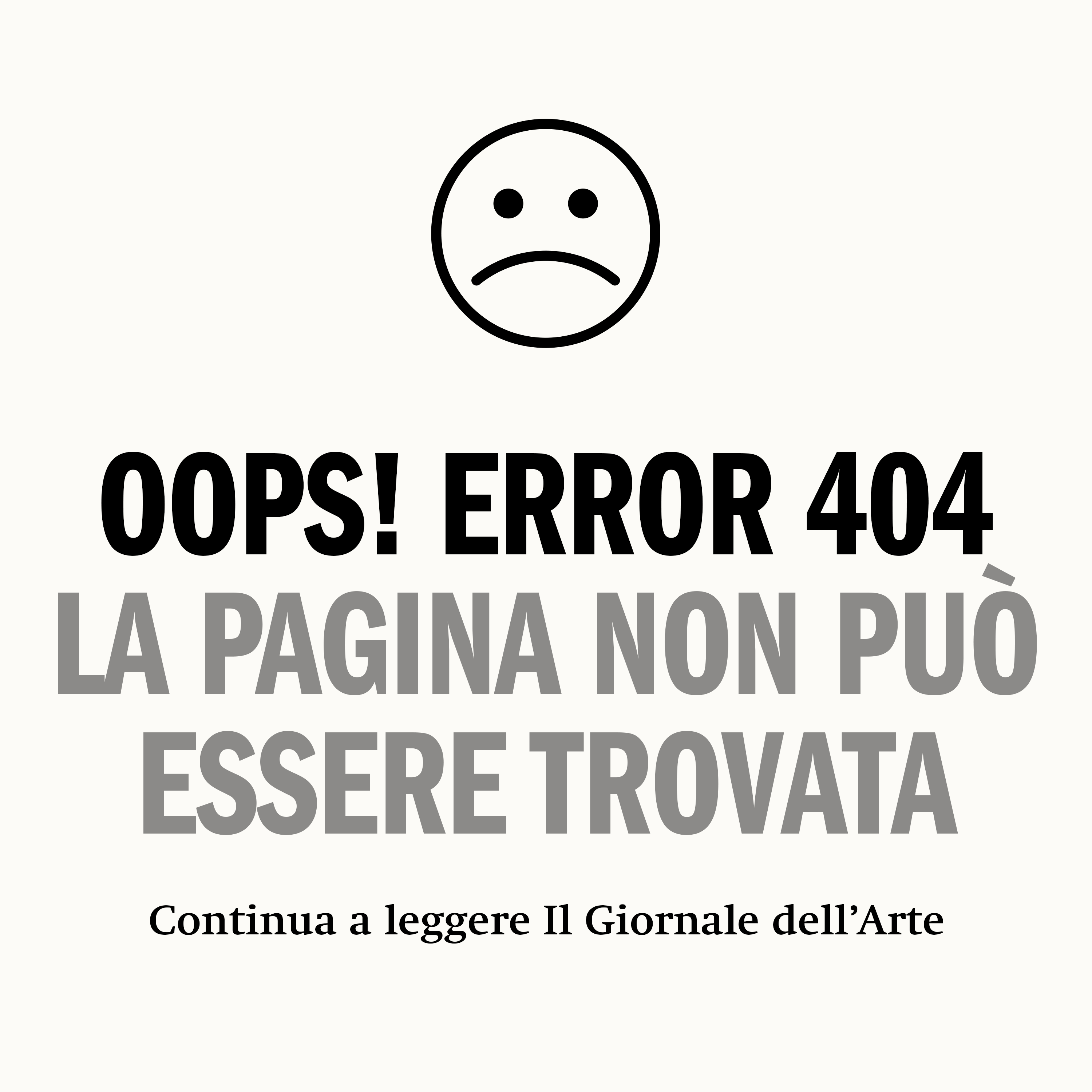IL NUMERO DI GIUGNO 2025 in edicola
In allegato:
Il Giornale dell'Arte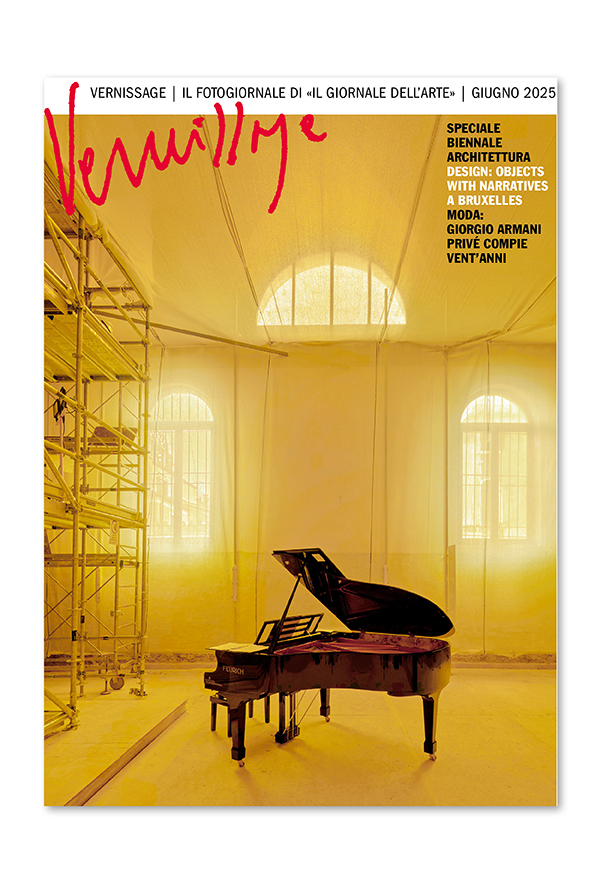
IL NUMERO DI GIUGNO 2025 in edicola
In allegato:
Vernissage
IL NUMERO DI GIUGNO 2025 in edicola
In allegato:
Il Giornale dell'Economia
IL NUMERO DI GIUGNO 2025 in edicola
In allegato:
Il Giornale delle Mostre
IL NUMERO DI GIUGNO 2025 in edicola
In allegato:
Il Giornale di Art Basel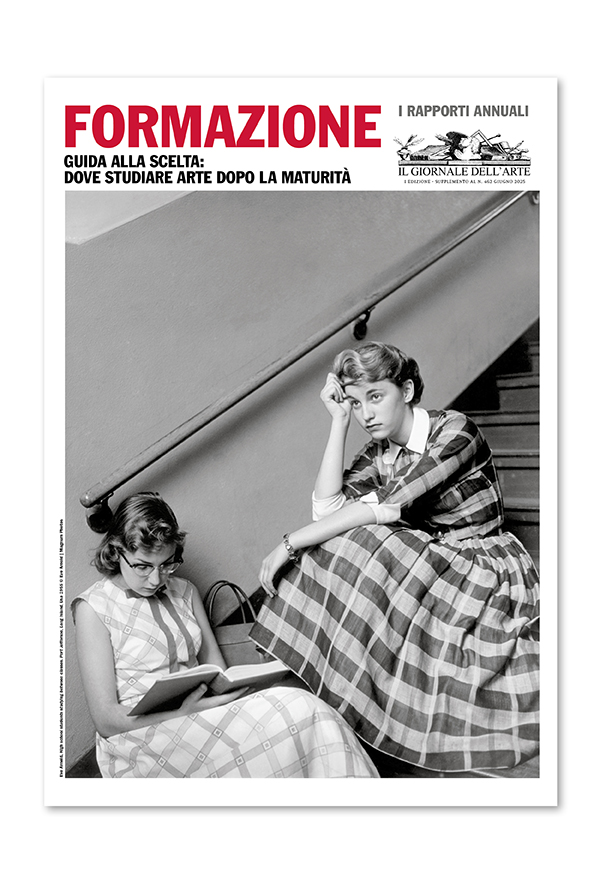
IL NUMERO DI GIUGNO 2025 in edicola
In allegato:
RA Formazione
IL NUMERO DI GIUGNO 2025 in edicola
In allegato:
Il Giornale dell'Arte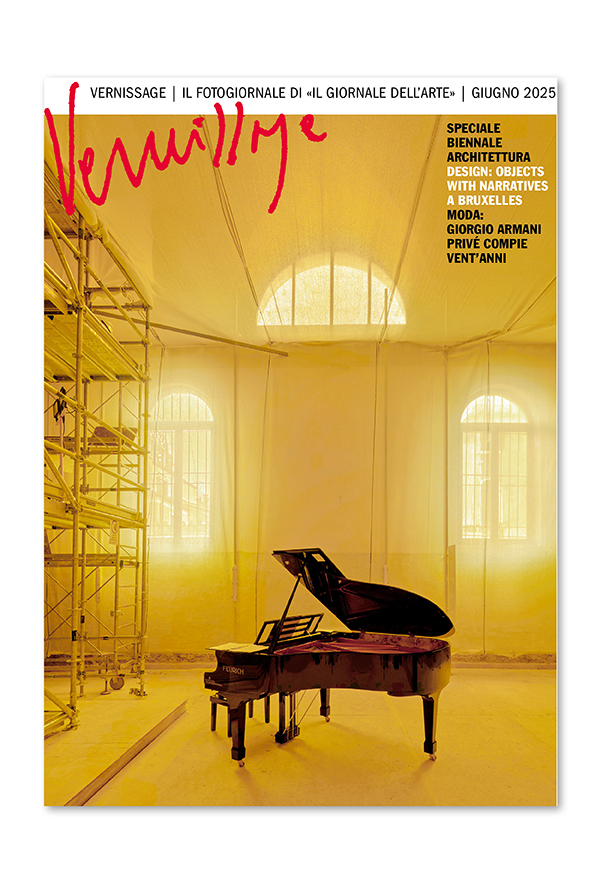
IL NUMERO DI GIUGNO 2025 in edicola
In allegato:
Vernissage
IL NUMERO DI GIUGNO 2025 in edicola
In allegato:
Il Giornale dell'Economia
IL NUMERO DI GIUGNO 2025 in edicola
In allegato:
Il Giornale delle Mostre
IL NUMERO DI GIUGNO 2025 in edicola
In allegato:
Il Giornale di Art Basel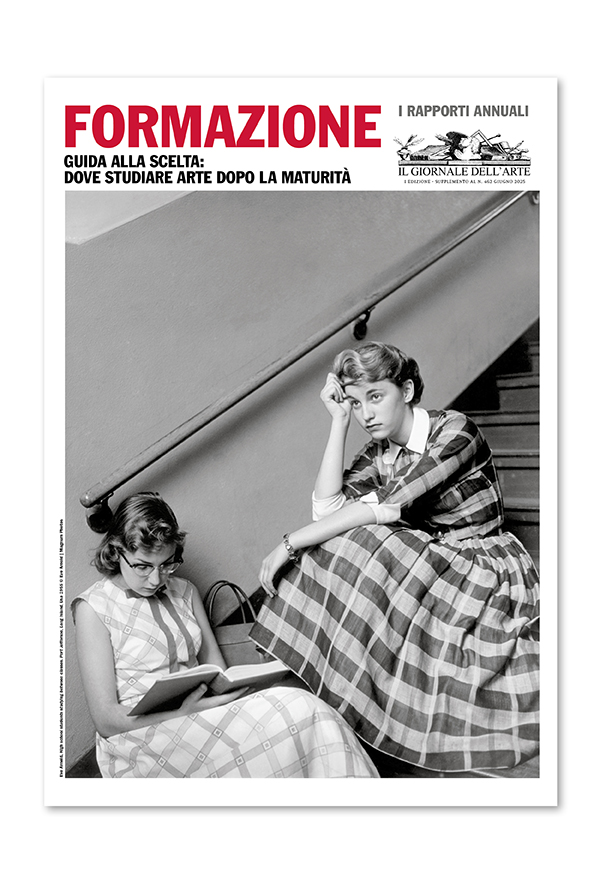
IL NUMERO DI GIUGNO 2025 in edicola
In allegato:
RA Formazione
Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine