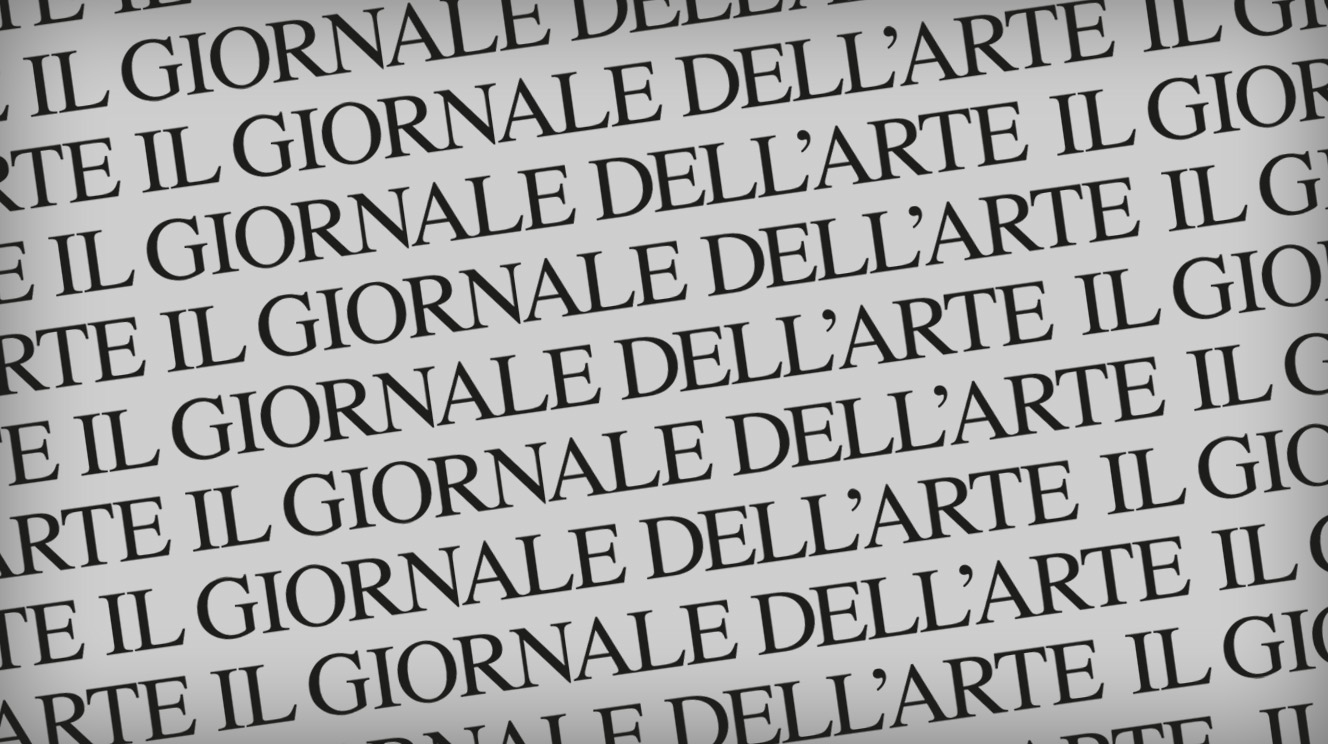Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
.jpeg)
Flaminio Gualdoni
Leggi i suoi articoliAntonio Riello ha trasformato un gesto orrendo, bruciare testi cari, in un artistico atto d’amore
Se uno dice «Bücherverbrennung» suona subito una cosa sinistra, gli vengono in mente i «decreti del fuoco» di Goebbels e i rituali trucidi assurti a quintessenza dell’odio per i libri, e dei roghi come forma di eliminazione fisica. Ma se uno pensa all’operazione «Libricida» che Antonio Riello ha presentato qualche settimana fa a Torino (nella Galleria Paolo Tonin, Ndr), giusto in parallelo al Salone del Libro, e forse evocando il fatidico 10 maggio 1933 in cui ebbero inizio le performance naziste, si consola: un’operazione che suonerebbe orrenda viene trasformata nel suo contrario, in un atto d’amore estremo e suggestivo. Dunque, che s’è inventato Riello? Ha scelto accuratamente dalla sua biblioteca personale alcuni libri che ha molto amato, li ha bruciati in una sorta di cerimoniale, e ne ha posto le ceneri in apposite urne in vetro trasparente, con tanto di didascalia che riporta il nome (autore e titolo) e le date di nascita, l’edizione, e di morte, la combustione.
Devo dire che lo straniamento comincia dal titolo: «libricida» è termine inventato, anche se con assai maggior sagacia del «libroteca» che affligge certe insegne odierne, in concorrenza con l’ancor più desolante e sintomatico «non solo libri». Indica una forma di sacrificio rituale perché personalizza il libro, lo riconosce interlocutore prezioso più di molte persone inutili con cui ci tocca aver a che fare. Ed è una faccenda antica, come insegna la grande studiosa Colette Sirat in Du scribe au livre: «I testi in caratteri ebraici non dovevano essere distrutti, ma sepolti. I libri fuori uso e i documenti divenuti inutili erano dunque portati al cimitero», proprio come parenti della comunità.
L’operazione di Riello, che mette in scena una teoria di teche trasparenti in cui riposano le ceneri dei suoi congiunti più cari, quelli che davvero hanno edificato la sua identità, è dunque una faccenda insieme importante e sottile. E ciò vada a maggior disdoro di tutti coloro che considerano quel «prisma a sei facce rettangolari composto di sottili lamine di carta», giusto per citare Borges, un ingombro inutile: siam qui a lamentarci continuamente dei soldi lesinati ai musei e ci dimentichiamo che le biblioteche, storiche e no, versano spesso in condizioni ben più disperate, tanto che, è cosa nota, quello che ai Girolamini i libri se li fregava e li rivendeva ai bibliofili era pure uno assai riverito, mica tanto tempo fa, al Ministero.
Siam qui a metter su supersaloni e festival del libro per ogni dove, e abbiamo una percentuale di lettori da terzo mondo che si appassionano giusto a robe come le sfumature. Eccetera. Poi ci sono le suggestioni storiche, che l’iniziativa di Riello evoca e distilla in memorie di genocidi.
La sequela di libri messi pubblicamente al rogo ha una storia plurisecolare: Fernando Báez ne ha fatto un elenco impressionante in Storia universale della distruzione dei libri, qualche anno fa (il volume è uscito presso Viella nel 2007, Ndr), accomunando la democraticissima Atene, in cui vien dato alle fiamme il Peritheon di Protagora di Abdera, e Caligola che se la prende con le opere di Omero, Virgilio e Livio; Lutero che fa un falò dei libri papalini e i bibliotecari statunitensi bigotti che se la prendono con Darwin.
A Baghdad, luogo dai molti destini, succedono nei secoli due cose uguali e diversissime: quando la invade Tamerlano, decide che col caldo che fa è meglio lasciar stare le fiamme e liberarsi delle inutili biblioteche annegandole nel Tigri, mentre quando arrivano gli americani nel 2003, forti della loro aria condizionata, lasciano che i manifestanti diano alle fiamme la Biblioteca Nazionale, assistendo impassibili.
Magari alla scuola militare avevano insegnato anche a loro che «l’uomo del futuro non sarà più un uomo fatto di libri, ma un uomo fatto di carattere», e si sono comportati di conseguenza. E sicuramente i loro illetterati istruttori non sapevano che questa era una delle frasi predilette proprio da Goebbels. Dunque evviva Riello: non so se sia uno di carattere, ma mi va bene così.
Altri articoli dell'autore
Il Criptico d’arte • Conosciuto anche come Vasco dei Vasari, l’architetto italiano fu un personaggio anomalo: nonostante il suo contributo al Futurismo, indagò il modo in cui l’anarchia influenza l’arte
Il Criptico d’arte • La vicenda della Banana di Cattelan: da provocazione sul mercato a oggetto di gesti insensati e fuorvianti
A Milano una collettiva di 12 artisti omaggia in altrettante puntate il capoluogo culla della tecnica artigianale e artistica in grado di passare da generazione in generazione
La grande mostra sul movimento artistico voluta dall’ex ministro Sangiuliano in realtà arriva dopo settant’anni di studi specialistici sull’argomento. Ma l’Italia non è futurista