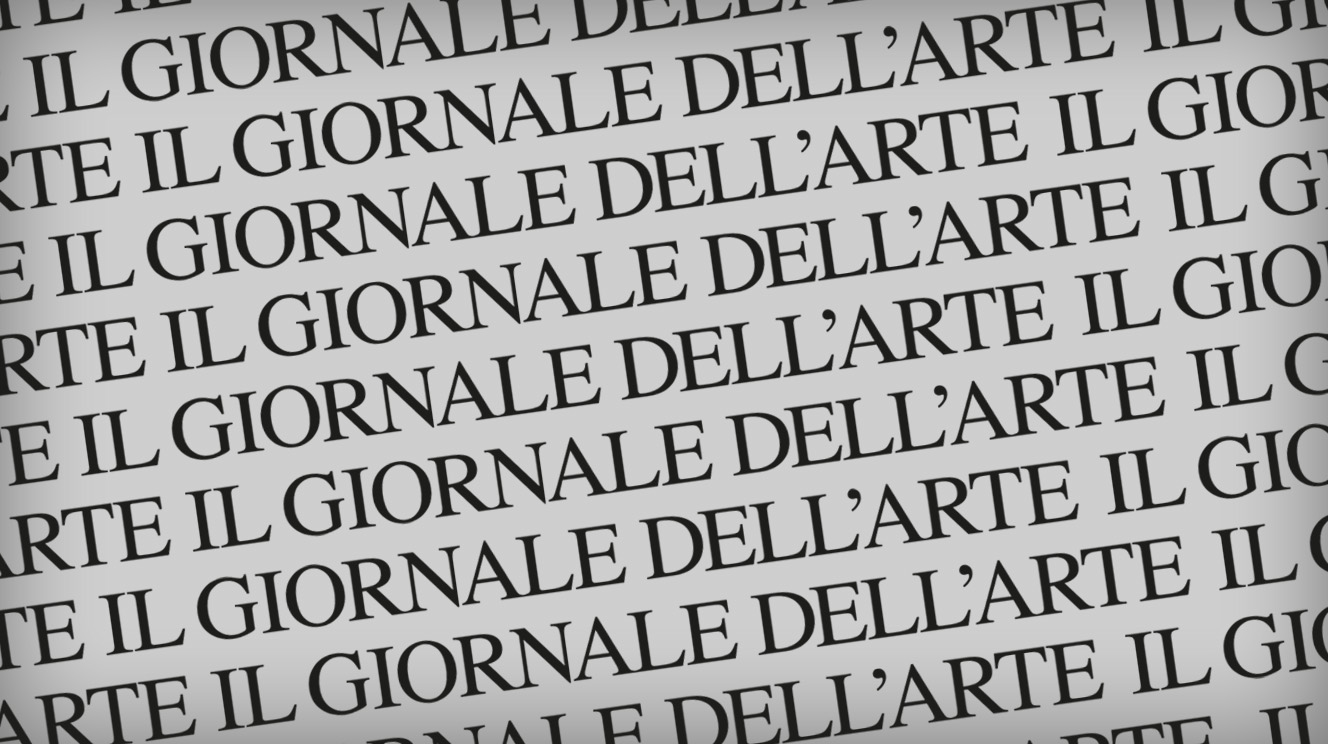Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Silvia Mazza
Leggi i suoi articoliCorreva l’anno 1479 quando il conquistatore di Costantinopoli, il sultano Mehemet II, contravvenendo ai dettami dell’Islam che sconsigliavano la riproduzione di fattezze umane, volle commissionare, riferisce Vasari, un suo ritratto a un artista veneziano. Il «Maometto II» di Giovanni Bellini, ora alla National Gallery di Londra, è testimonianza tra le più conosciute di un mondo di contaminazioni invece tanto capillare e poco esplorato, su cui un recente volume di Olschki getta luce nuova. Incontri di civiltà nel Mediterraneo raccoglie, a cura di Alireza Naser Eslami, nove saggi che sembrano dar corpo a un’osservazione di Salvatore Settis, originariamente rivolta al mondo classico, che il curatore parafrasa nella sua introduzione: gli artisti del Rinascimento «non furono indaffarati a fondare la coscienza dell’Europa moderna per distinzione dall’Oriente, ma anzi nell’Oriente si mossero con gioia e disinvoltura e ansia di scoperta, cercandovi merci e miti e saggezza, imparando e insegnando […] sempre aperti agli influssi e vogliosi di confrontarsi, sempre pronti a “ibridizzarsi” con le civiltà e i popoli che incontravano, ponendone e ricevendone domande, creando oggetti culturali poco classici». Il libro, che raccoglie e amplia i contributi sviluppati in un convegno svoltosi nel novembre 2013 a Genova, delinea innanzitutto il quadro di riferimento (saggi di Giovanni Ricci, Gabriella Airaldi e Franco Cardini) di una fase storica caratterizzata tra il XV e il XVI secolo da intensi scambi diplomatici tra gli Stati italiani e l’Impero Ottomano e invece sfociata in quella sorta di «ultima crociata» che contraddistinse il periodo tra l’assedio di Vienna del 1683 e la pace di Passarowitz del 1718, con in mezzo la guerra turco-veneziana del 1714 e la riconquista di Belgrado da parte della «Lega Santa» pontificio-veneziano-imperiale del 1717.
A partire dal saggio di Marco Spallanzani (Ceramica ottomana in un palazzo fiorentino del tardo Rinascimento) la permeabilità tra le due culture emerge subito grazie ad Anna Contadini che individua proprio nel felice assorbimento dei canoni orientaleggianti una delle principali ragioni del successo internazionale dei modelli italiani e di come a loro volta gli artigiani italiani avessero influenzato i prodotti ottomani oggetto d’importazione. Tappeti ottomani nella pittura, contributo di Giovanni Curatola, spiega poi l’introduzione di tale elemento iconografico in tele di artisti come Gentile da Fabriano, Piero della Francesca, Domenico Ghirlandaio, Giovanni di Paolo, Paris Bordon, Holbein il giovane, Pier Francesco Pucci, Vittore Carpaccio e Gentile Bellini, fino all’esempio sorprendente di Tiziano che nella sua «Deposizione» (1559, Madrid, Museo del Prado) fa indossare a Giuseppe di Arimatea un caffetano ornato dal «cintamani», un decoro tipicamente turco. De Il giardino ottomano, l’Italia e la cultura europea si occupa poi Luigi Zangheri, mentre Aygül A?ir conduce il lettore alla scoperta de La cultura architettonica veneziana e genovese nella Istanbul ottomana. Di ampio respiro, infine il contributo dello stesso Alireza Naser Eslami: qui i processi di contaminazione inducono a confronti suggestivi, uno fra tutti quello tra alcune architetture ottomane e certi dettagli di San Pietro in Roma e della Sacrestia Nuova di Firenze.
Incontri di civiltà nel Mediterraneo. L’Impero Ottomano e l’Italia del Rinascimento. Storia, arte e architettura, a cura di Alireza Naser Eslami, 180 pp., ill., Olschki, Firenze 2014, € 25,00
Altri articoli dell'autore
La proposta di legge Orlando-Franceschini è passata alla Camera
Pronta la nuova agorà del Museo Salinas in restauro da dieci anni
Cronaca e progetti a cinquant’anni dal sisma
Polemiche per la trasferta di una tavoletta del pittore messinese, tra le 120 opere scelte dal critico d'arte per il Castello Ursino di Catania.