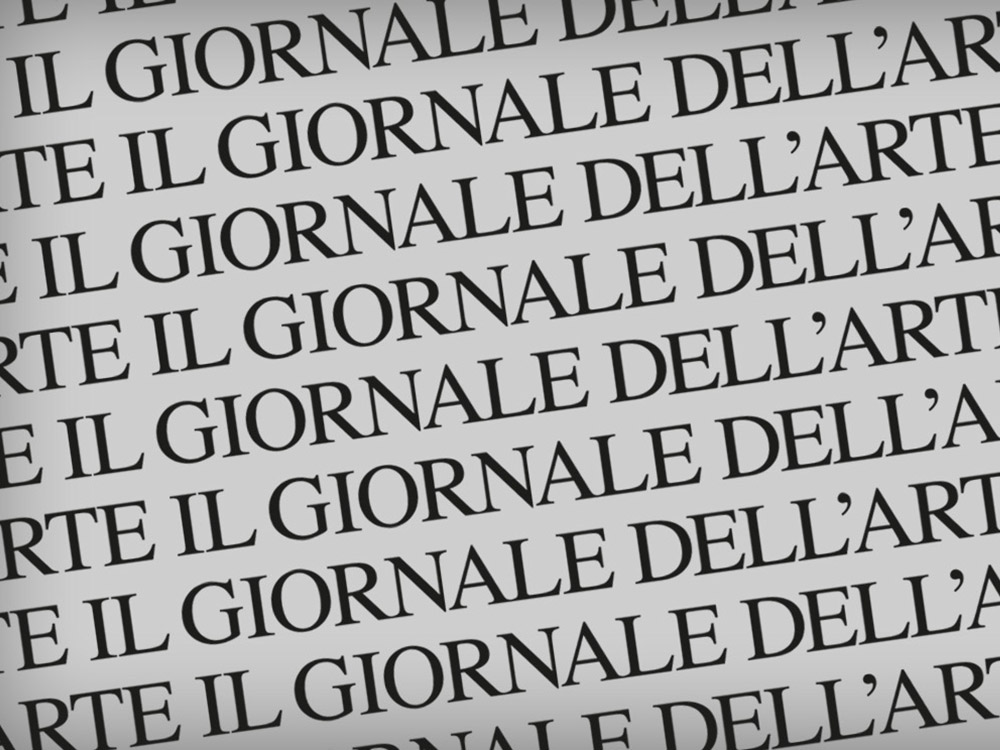Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Silvia Mazza
Leggi i suoi articoliUna carrellata su alcuni errori, travisamenti di fatti e leggi, oltre a una discutibile interpretazione degli stessi, rintracciabili nel libro di Mariarita Sgarlata, L’eradicazione degli artropodi. La politica dei beni culturali in Sicilia (Edipuglia, 2016).
Giuliano Volpe e la sua visione olistica del patrimonio, sì o no? Che in un libro pubblicato in una collana diretta da un illustre accademico vengano espresse da parte dello scrittore posizioni divergenti rispetto a quelle di quest’ultimo sarebbe un positivo esempio di libertà critica. Quando, invece, si condivide in maniera contraddittoria il proprio pensiero per non apparire «scortesi» nei confronti di chi ci ospita, forse, la questione assume un diverso valore. Dunque, secondo la Sgarlata le criticità nei beni culturali siciliani sono da imputare al «modello organizzativo» «impostato su una visione olistica della tutela» (p. 30). Sebbene l’archeologa si auguri che «magari in Italia sarà un’altra storia» (p. 29), se è il modello teorico causa delle degenerazioni quando viene tradotto in pratica, come in Sicilia da trent’anni (l’attuazione delle due leggi fondamentali del ’77 e ’80 si attua concretamente a partire dal 1 gennaio 1987), perché dice di riconoscere i «meriti di chi, come Giuliano Volpe, lo sostiene»? (p. 30). Dato che il passaggio non è ulteriormente esplicitato, significa, forse, che allora lei sia proprio certa che in Italia si scriverà una storia diversa? Altrimenti, quale sarebbe questo merito? di sostenere un modello fallimentare? Perché il punto è che anche per lo scenario nazionale non riconosce presupposti tanto migliori. Non ha, forse, appena scritto che «non si può certo affermare che l’Italia sia un paradiso per la cultura e che tutto sia rose e fiori» (ivi)? Insomma, riconosce meriti a chi sostiene una tesi da lei non condivisa e per il solo fatto di sostenerla? ce n’è abbastanza per restare interdetti, almeno di prenderla per quella che ha tutta l’aria di essere solo una piaggeria nei confronti del «padrone di casa». Un tale riguardo, però, ce lo saremmo aspettato a maggior ragione quando, volendolo citare, non avrebbe dovuto dimenticarsi del necessario virgolettato: «dalla frammentazione alla visione globale» e «un centro agile e forte, periferie interdisciplinari e solide» (pp. 31 e 32), sono, infatti, i titoli di altrettanti paragrafi di Un patrimonio al futuro (p. 27 e p. 42; già nella Lettera al giornale abbiamo segnalato un altro passaggio «ispirato» da questo libro di Volpe; ma varrebbe, forse, la pena verificare anche le citazioni di Montanari, Manacorda, Settis, Montella etc.). E, ancora, laddove cita di nuovo il «modello siciliano», apprendiamo che le soprintendenze che in Sicilia sono interdisciplinari, per lei non lo sarebbero (p. 32). E quale esempio porta, allora, di una soprintendenza che «ha realmente applicato un’impostazione olistica della tutela»? (p. 33). Quella dell’unica soprintendenza tematica in Sicilia! La Soprintendenza del Mare. Lo dice la stessa denominazione: la varietà tipologica dei beni archeologici antichi e moderni, paesaggistici e demoetnoantropologici di cui si occupa questo istituto, che non ha corrispettivi nel resto del Paese, ha un comune denominatore, la loro inerenza all’unica tematica del mare. Una soprintendenza, inoltre, la cui competenza territoriale valica i limiti coincidenti con le ex province, come per le altre soprintendenze uniche siciliane, per estendersi all’intera regione.
Anche la Chiesa nel mirino dell’archeologa. «Una percentuale piuttosto alta» (quale?) dei fondi europei, tra il 2000-2006 e il 2007-2013, sarebbe stata utilizzata «per il restauro degli edifici di culto cristiano» (la cosa dovrebbe sorprendere data la fitta consistenza di questa categoria di edifici?) che «hanno sempre una marcia in più rispetto al resto» (p. 161). Affermazione singolare da parte della persona che, dal 1995 al 2015, ha ricoperto il ruolo di Ispettore per le Catacombe della Sicilia Orientale, simile alla funzione di Ispettore onorario nelle Soprintendenze statali, per conto della Pontificia Commissione di Archeologia Sacra (organo della Santa Sede), la quale, in virtù dei successivi Concordati con lo Stato italiano, è incaricata della tutela e della valorizzazione delle catacombe cristiane sul territorio italiano, in collaborazione con le Diocesi locali. Forse la faccenda appare meno strana se si considera che il suo costituisce un caso con pochissimi precedenti in altre regioni d’Italia, e che in Sicilia gli illustri archeologi che hanno rivestito questa funzione onorifica prima di lei hanno mantenuto il ruolo fino alla pensione o alla morte. Qual è la ragione di questa sostituzione anzitempo? Quale che sia, la Sgarlata non deve averla presa bene.
I giornalisti e l’aritmetica culturale. Il paragrafo «Mio Dio, mi si è ristretto il bilancio!» (ma davvero è convinta che sia solo una sua doglianza e non che anche i suoi predecessori avrebbero gradito maggiori fondi per l’Assessorato BBCC?) è tutto uno sciorinare numeri, stanziamenti, capitoli di spesa, grafici e tabelle. Allora a qualcosa serve quell’ «aritmetica culturale» che sembra essere «la passione preferita» di giornalisti affetti da «feticismo delle cifre»! gli stessi per i quali «a fronte dell’ampia gamma di inchieste spinose e pericolose che la Sicilia offre (…) scrivere di cultura è a costo zero, non ha controindicazioni e non provoca insonnia» (pp. 73-76). E, ancora: «non c’è stato giornalista, delle maggiori come delle minori testate siciliane, che non mi abbia chiesto numeri» (p. 75). Sicuramente non noi nell’intervista che le facevamo sulla faccenda dei prestiti di opere siciliane ad alcuni musei americani oggetto all’epoca di un braccio di ferro col suo Assessorato. Deve avere apprezzato la cosa, dato che è l’unico articolo di chi scrive che citi in nota (p. 202: allora ci legge!). Ma quale sia la sua percezione della carta stampata lo si legge anche nel paragrafo dedicato alle concessioni d’uso dei siti monumentali, dove l’autrice si dilunga in considerazioni sulla «volubilità dei giudizi dei giornalisti che passano dalla condanna all’entusiasmo senza soluzione di continuità» (p. 231). «Nessuna critica», osserva scandalizzata, al banchetto del Google Camp ai piedi del Tempio della Concordia: si è già, di nuovo, dimenticata di noi, che all’argomento, eccome, se avevamo dedicato ampio spazio in un lungo servizio (cfr. ed. online 7 sett. ’15, e n. 361, feb. ’16, p. 9). Dove, tra l’altro, per prima chi scrive aveva anche introdotto una riflessone tra il «modello siciliano» dell’autonomia dei parchi e la riforma Mibact che a quello si è ispirata (su questi argomenti ero stata anche invitata da Legambiente a tenere un intervento ad Agrigento il 27 febbraio 2016; invito rinnovato quest’anno per il dibattito a Palermo, del 21 febbraio, sulle criticità dei BBCC in Sicilia). Basta rileggerselo, insieme alle riflessioni che abbiamo consegnato di recente all’articolo Gucci tra il Partenone e il Tempio della Concordia, per misurarne la distanza qualitativa dalle sbrigative osservazioni dell’autrice del libro. Rassegniamoci, ci ignora… ad orologeria: nessun cenno a una delle nostre più importanti inchieste, quella sul «nodo Siracusa» (speculazioni edilizie in aree in cui vige il massimo livello di tutela e spoils system alla Soprintendenza, cfr., tra i numerosi articoli dedicati anche sul giornale, ed. online, 27 novembre 2014, ed. online, 3 novembre 2015) che, pure, aveva riguardato la vicenda della sua piscina; nemmeno quella sui fondi comunitari Poin (e dire che l’avevamo pure citata!), dove avevamo approfondito le ragioni delle fallimentari programmazioni di spesa. Del recupero di questi fondi europei si attesta il merito nell’intervista che ha rilasciato al GdA sul n. di marzo, quando invece va ricondotto (cfr. n. 335, ott. ’13, p. 10) all’allora ministro della Coesione territoriale Carlo Trigilia (governo Letta), in continuità col predecessore Fabrizio Barca (governo Monti), che aveva messo a punto un piano per il rilancio di questi fondi UE, attraverso la semplificazione del modello di governance. Nel libro la Sgarlata ricorda Trigilia e Barca (pp. 242 e 248), ma per chi legge non è immediatamente evidente che è grazie all’azione di questi attori che si riescono a sbloccare questi fondi destinati ad alcune regioni del Sud, tra cui la Sicilia.
Riorganizzazione siciliana-riforma Mibact. «Separare tutela da valorizzazione comporta i rischi che tutti conosciamo e scorporare quanto attualmente rimane nell’alveo delle competenze della soprintendenza sembra andare esattamente nella direzione opposta all’impostazione olistica dei beni culturali che orienta, oggi più di prima, le scelte del Mibact» (pp. 36 e 37). Questa separazione è, invece, esattamente proprio quella che è avvenuta in ambito ministeriale. Alla pagina successiva, inoltre, un capovolgimento dei termini di precedenza cronologica fa sostenere all’autrice che la «riforma» siciliana sarebbe stata «motivata dalla velocità di alcuni processi innovativi innescati in Italia dal Ministro Franceschini» (p. 38), quando, invece, i due passaggi qualificanti la riforma statale – soprintendenza unica e autonomia di musei e parchi – sono proprio esemplati sul «modello siciliano» delle soprintendenze uniche del ’77 e su quello che noi abbiamo ribattezzato il «nuovo modello», ossia quello degli istituti autonomi introdotto in Sicilia nel 2000 (parchi archeologici) e nel 2002 (musei autonomi, limitati al solo caso del RISO a Palermo). E, ancora, non è corretto sostenere che con la «riforma» s’intendesse «rendere autonomi i musei nel bilancio» (p. 42), perché era stato lo stesso assessore Purpura a risponderci che era da escludere la sottrazione di queste entrate dal bilancio regionale. Né ci sembra pertinente la questione della difficoltà che si creerebbe, in caso di concessione di autonomia finanziaria, nel trovare risorse per gli stipendi dei dipendenti regionali (ivi). Anche nell’autonomo Parco della Valle dei Templi restano a carico della Regione, così come dello Stato quelli dei musei e parchi autonomi in seno al Mibact. È noto che musei, aree archeologiche, siti monumentali e biblioteche non sono attività in grado di autofinanziarsi integralmente.
C’è, poi, il passaggio in cui afferma che la riforma siciliana avrebbe dovuto essere occasione per snellire il Centro Catalogo e il Centro per il Restauro (Crpr), il quali a suo avviso, rimasti a digiuno di progetti, «possono tranquillamente rinunciare ad alcune unità operative utili solo a garantire posti su Palermo» (p. 36). Ma non sarebbe stato meglio da parte sua invocare la ripresa delle rispettive attività statutarie? Quando, andando in tutt’altra direzione, al Crpr sono state tagliate le attività che riguardano la conservazione programmata, la lettura e mitigazione dei rischi. E così, infatti, che si è scritta l’ultima parola anche per la Carta del Rischio del Patrimonio, il cui Sit era stato già chiuso nel 2010 (cfr. nostro documento scaricabile in calce all’articolo online del 17 ottobre 2016, realizzato in occasione dell’invito al dibattito promosso da Legambiente nel settembre 2016). Per cui, in caso di emergenza, questa regione non sarebbe in grado di intervenire per la messa in sicurezza del suo patrimonio: altro argomento al centro delle nostre denunce, e ben prima del sisma nel centro Italia (cfr. l’inchiesta in ed. online, 1 aprile 2015 e n. 352, ‘apr. ’15, p. 14). Della Carta del Rischio la Sgarlata sembra, invece, ricordarsene solo nell’intervista rilasciata al GdA, e solo perché il collega Stefano Milani le pone la domanda. Nel libro nessuna menzione di questo progetto e del «tentativo di riattivare il server che gestiva la Carta». Le stava così a cuore questo progetto strategico e indispensabile da dimenticarsene proprio nel libro in cui magnifica il proprio mandato politico? E perché a Guido Meli che cita nell’intervista, storico direttore del Crpr, all’epoca transitato al servizio Musei del Dipartimento, la Sgarlata assegnò questo compito, e non all’allora direttrice del Crpr, l’archeologa Enza Cilia? Forse che non la reputasse all’altezza? Qui non si tratta solo di valutare se davvero fosse lo specialista più adatto a dirigere un istituto che si occupa di restauro, ma della discussa gestione che ne è seguita, oggetto della nostra inchiesta, su citata, sul Crpr. E chi aveva deciso questa nomina? Il presidente Crocetta, di cui la Cilia era stata capo di gabinetto? o il dirigente generale, come dovrebbe essere per legge, ma che così non è perché la politica, in realtà, condiziona sempre queste nomine? o l’assessore ai Beni culturali? La Sgarlata, in definitiva, la rivendica o no questa nomina? Sembra proprio di no, mentre all’epoca rivendicò, eccome («sono stata libera di scegliere i migliori, ma con il presidente Crocetta non poteva accadere diversamente», dichiarava nel 2013 a «Live Sicilia »), quelle di due archeologhe a capo delle «soprintendenze archeologiche» di Siracusa ed Agrigento. Soprintendenze archeologiche? Le chiama proprio così (p. 285, ma anche a p. 30). In Sicilia, l’abbiamo già ricordato, è dalla legge 77/80 che ci sono le soprintendenze uniche. In chiave di una concezione olistica dell’approccio alle questioni inerenti il patrimonio, il soprintendente può, pertanto, essere benissimo un architetto, uno storico dell’arte come un archeologo, purché a capo delle singole unità operative sia garantita la presenza dei rispettivi specialisti. Tornando alle due nomine all’insegna della meritocrazia, vi va fiera anche nel libro, dove, solo, più cautamente, si associa in questa decisione l’allora dg Gelardi, a cui, abbiamo appena detto, spettavano unicamente. La vicenda dimostra che non è così vero che si era inaugurata una nuova stagione che metteva fine alla «tradizionale» lottizzazione politica nell’assegnazione degli incarichi.
Vale la pena, però, tornare ancora sul Crpr per sottolineare l’ennesima approssimazione con la quale si sostiene che il Centro sarebbe nato «per emulare», oltre l’Iscr, anche l’Opificio delle Pietre dure di Firenze (p. 36). Quando, invece, nacque nel 1982 perché la Regione, col trasferimento dallo Stato della competenza esclusiva in materia di beni culturali (1975), dovette dotarsi di istituti e organismi omologhi a quelli statali. Era, in qualche modo, la prima risposta alla visione con cui Cesare Brandi nel ’39 fondò a Roma l’allora Icr, che in quel «centrale» della sua originaria denominazione, venuto meno con quella nuova di Istituto «superiore» per la conservazione e il restauro, conteneva implicitamente la previsione, rimasta inattuata, di una successiva filiazione di «sezioni» regionali (cfr. ed. online, 1 aprile 2015 e n. 352, ‘apr. ’15, p. 14). Inattuata fino alla «succursale» della Scuola di Alta Formazione (Saf) inaugurata dall’Iscr il 4 marzo scorso a Matera. Intanto, però, la denominazione dell’Istituto romano ha fatto in tempo ad essere modificata. Dipendente dalla Regione siciliana e non, naturalmente, dall’Istituto romano, il Crpr ha proprio tra i suoi compiti istituzionali la collaborazione con quest’ultimo. Anche se da troppo tempo ormai sembrano ignorarlo i suoi direttori e gli assessori regionali. Sgarlata compresa.
Strumentalizzazione di fatti e persone. Chiamato in soccorso nell’intervista, l’architetto Meli ci suggerisce anche un’altra riflessione, indicativa della corrente alternata che accende o spegne la considerazione con cui alcune personalità evocate nel libro siano tenute dall’ex assessora. Questo dirigente è anche lo stesso a cui si riferisce quando dice, a proposito della «battaglia» per il biglietto integrato Villa del Casale-Morgantina-Aidone, «chi rema contro è spesso più vicino a te di quanto tu creda» (p. 150). Sul punto Meli ci ha spiegato: «non ho condiviso il biglietto unico cumulativo obbligatorio per i due siti, avendo proposto in alternativa un biglietto unico opzionale, considerata la situazione logistica e temporale delle visite; per comprendere le ragioni della scelta bisognerebbe spiegare il tipo di flusso turistico dei visitatori». Questo dirigente è, però, anche quello a cui si intestano azioni di cui, al contrario, la Sgarlata va fiera, come l’introduzione del POS nei siti monumentali o il principio di «reciprocità anticipata» nella politica dei prestiti.
A una vera e propria damnatio memoriae «condanna», invece, il più longevo assessore siciliano ai BBCC del nuovo Millennio (4 anni, più due al Turismo). Quel Fabio Granata sotto il cui assessorato si ebbero la legge 20/2000 sui parchi archeologici; quella del 2002 che introduce in nuce (limitato solo al museo Riso a Palermo) l’autonomia finanziaria pure per i musei; il primo Distretto culturale d’Italia, quello del Sud-est; i due riconoscimenti Unesco, quello delle Città tardo-barocche del Val di Noto (2002, con il primo Piano di Gestione al mondo di un sito della WHL) e quello di Siracusa e Pantalica (2005); l’importazione in Sicilia della Carta del Rischio e l’istituzione della Soprintendenza del Mare. E l’elenco è per difetto. Per non ricordare anche che Granata ha proseguito e avviato concretamente (invece che azzerare il precedente corso, come avviene di solito al cambio di legislatura) le premesse del predecessore Salvatore Morinello (PRC), risalenti a qualche mese prima del suo insediamento, avviando l’applicazione delle Linee guida per il Piano Paesaggistico regionale (il primo PP territoriale adottato è quello delle Egadi nel 2002, cfr. n. 353, mag.’ 15 e online) e tagliando il nastro della prima concessione in Sicilia di un sito a un privato, i giardini della Kolymbetra, da lui inaugurati nel 2001 (dimenticando questo storico precedente, per l’ex assessora, invece, le sue concessioni avrebbero addirittura anticipato di un anno quelle di Franceschini). Dov’è, invece, che l’autrice si ricorda del predecessore? Per dirlo fautore del prestito del Satiro di Mazara all’Expo di Aichi, a cui, invece, come ci ha dichiarato, «mi opposi da assessore ai BBCC, mentre la trasferta fu autorizzata nel 2005, dal mio successore Alessandro Pagano»; e per sostenere che si sarebbe «guardato bene» dall’applicare lui stesso la propria legge sui parchi (pp. 125). Arriva persino a non riconoscergli l’istituzione di quello della Valle dei Templi, dovuta proprio alla legge che porta il suo nome, mentre per l’archeologa sarebbe avvenuta addirittura «5 anni dopo la Legge del 2000» (p. 23). Non resta, allora, che sorprendersi del fatto che riesca a contraddirsi da sola, quando, appena qualche pagina dopo, ricorda il contrastato impegno, nel 2003 (Granata assessore), dell’allora soprintendente di Siracusa, Giuseppe Voza, per definirne la perimetrazione del parco archeologico (p. 136). Allora non è vero che lui stesso si stesse «guardando bene dall’applicarla negli anni del suo mandato e particolarmente nella sua città» (pp. 125-126)! Il dubbio che non abbia letto il libro di A. Varrica (2010), che pure cita in un paio di note, acquista consistenza se si considera che vi è scritto chiaramente che «all’indomani dell’approvazione della leggere regionale 20/2000 venne avviato l’iter di costituzione del sistema dei parchi archeologici regionali: attraverso una circolare dell’allora Assessore competente Fabio Granata si richiedeva alle varie soprintendenze di presentare le proprie proposte per l’individuazione delle aree potenzialmente in grado di essere istituite in parco» (p. 191).
Decidono i burocrati o l’Assessore ai BBCCIS? Legambiente Sicilia il 21 marzo scorso ha promosso un dibattito (al quale ha preso parte anche chi scrive), presso la Real Fonderia a Palermo, sui Beni Culturali in Sicilia, nel quale soprintendenti, direttori di musei, parchi archeologici sono stati chiamati a fornire proposte per cercare di invertire il corso di un sistema ormai al collasso. La risposta dell’assessore in carica Carlo Vermiglio si è dimostrata sostanzialmente sorda ai dirigenti-tecnici. Niente di nuovo, la politica tira dritto come sempre. La Sgarlata, invece, inverte il «rapporto di forza» tra assessore e funzionari (ma altrove non parla di «ingerenza straripante di una certa politica», p. 29?), per lei il primo «viene guardato» dai secondi «come quello in grado di dare solo l’indirizzo di casa» (pp. 18-19). Alla casta dei «burocrati» dedica l’intero secondo capitolo, arrivando a scrivere persino che ci sarebbe «un progressivo indebolimento della volontà politica scendendo lo stivale» (p. 44). Così debole questa politica nel Meridione che il Rapporto sulla corruzione politica del Paese, realizzato dalla Fondazione Res (Istituto di Ricerca su Economia e Società in Sicilia) assegna il primo posto alla Campania e il terzo alla Sicilia!
Concorso del 2000 per dirigenti tecnici nei BBCC. Gli amministratori sono il potere forte: è questo il messaggio che passa al lettore. In questa distorsione delle questioni, qui arriva addirittura a far passare come un «beneficiato» (p. 54) dalla burocrazia (la definisce un’«ambigua reazione accondiscendente», ivi) chi («le sei “eccellenze”», li ribattezza sarcasticamente, p. 55), tra gli 80 vincitori del concorso, ha legittimamente vinto, attraverso tre gradi di giudizio, il ricorso contro l’Amministrazione.
Autonomia e competenza esclusiva in materia di beni culturali. Quella stessa competenza specifica di cui gode la Regione dal 1975, che le ha permesso di anticipare la stagione riformistica ministeriale è sbrigativamente e comodamente additata come la causa di ritardi e criticità di ogni sorta che nulla hanno a che vedere con la specialità siciliana. È un’autonomia rimasta sostanzialmente lettera morta il problema o la cattiva declinazione che se n’è fatta finora? E se d’un colpo la si abrogasse, la Sicilia si ritroverebbe il parlamento migliore d’Europa? Facciamo un esperimento: riportiamo subito, con questi parlamentari, le competenze in capo allo Stato. Vediamo cosa succede. Piuttosto bisognerebbe chiedersi, contro sbrigative letture «deformanti» di fatti storici capitali per la Regione, l’autonomia senza «responsabilità» fiscale che autonomia è (cfr. Gaetano Armao, Marcello Sajia, Settant’anni di Autonomia siciliana 1946-2016, Rubettino 2017)? E, per altro verso, l’autonomia in mano a una classe politica «irresponsabile», mediocre, corrotta e affarista dove ha condotto la Sicilia? La Sgarlata non sa che le leggi (la 80/77 e la 116/80 e poi alla «più recente» legge 20/2000) a cui oggi lo Stato ha guardato per riformare il suo assetto in materia di beni culturali, la Regione se l’è potute dare perché gode di potestà legislativa primaria? Norme giuridiche. Ma non solo. È in virtù della competenza esclusiva che sono state scritte le Linee Guida per il PP Regionale del 1999 (il primo PP adottato nel 2002, quello delle Egadi), mentre è solo da qualche anno che si hanno i primi Piani paesaggistici nel Paese, quelli di Puglia, Toscana e, dal 14 marzo scorso quello del Piemonte; la prima sponsorizzazione (2003), la prima concessione d’uso a un’associazione no profit (1999). Primati, questi e altri, i cui sviluppi sono stati soffocati dalla mala politica, la vera causa della situazione di paralisi che da troppo tempo ha condannato la Regione all’immobilismo, o peggio, all’involuzione. Come emerge pure dall’intervista, cosa c’entra l’autonomia con l’ingerenza politica nei BBCC siciliani? Se anche nelle altre regioni gli scenari sono questi, e non altro denunciavano i dipendenti Mibact nell’appello del 24 agosto 2015 al presidente Mattarella, cioè che nella riorganizzazione ministeriale altri erano stati i criteri delle nomine, invece che tenere debitamente conto delle competenze di carattere tecnico. E cosa c’entra, ancora, l’autonomia con il «ritardo nell’uso dei fondi Ue 2007-2013, con solo il 21% (10-11 milioni circa) della spesa possibile» (come ha dichiarato nell’intervista, cfr. n. 373, mar. ’17, p. 9), se almeno fino al 2013 era l’Italia nel suo insieme a scontare, con appena il 40% di fondi comunitari complessivamente spesi fino ad allora, un ritardo che la piazzava tra gli ultimi posti in classifica, terz’ultima nazione in Europa, meglio soltanto di Bulgaria e Romania. Tra l’altro, fra le regioni del Sud, la Sicilia è stata in buona compagnia della Campania, regione a statuto ordinario. Regione in cui un’ inchiesta condotta da un pool di pm della Dda ha fatto finire ai domiciliari, tra gli altri, anche la sovrintendente ai Beni culturali di Napoli Adele Campanelli. Giusto per ricordare solo uno dei fatti di cronaca più recenti di prossimità tra politica, malaffare e beni culturali in una regione «ordinaria». Le basse percentuali di spesa, poi, va precisato, si registrano in Sicilia proprio nei Beni culturali, mentre complessivamente in questa stessa regione il Po Fesr 2007-2013 si è chiuso con una spesa del 96% . Insomma, non sembra essere proprio l’autonomia a determinare il buon uso o meno dei fondi comunitari.
Correlato alla questione dell’autonomia, il concetto di «identità» è ridotto alla sola derivazione interpretativa legata alla dimensione della retorica. Quello dell’identità non è un termine da bandire perché se ne travisa strumentalmente il significato. È, invece, un tema centrale nel Codice 2004 e nella Convenzione Europea sul Paesaggio, che eleva quest’ultimo a «fondamento dell’identità». Ma nel titolo del libro che cita di Maurizio Carta (al quale riconosce diversi meriti per aver coordinato il gruppo di lavoro per il «disegno di legge sul governo del territorio in Sicilia», «redazione di numerosi piani strategici, urbanistici e paesaggistici», ecc. p. 97, nota 11) non si parla di «patrimonio culturale come matrice di identità e strumento di sviluppo» (Franco Angeli, 2002)? E lei stessa, poi, non auspica che «i valori identitari dei luoghi della cultura si trasformino in ricchezza, bellezza e benessere condivisi» (p. 293)?
Musei regionali siciliani. Perla Sgarlata «all’interno della piramide amministrativa siciliana, nessun museo ha profili di autonomia gestionale e funzionale» (p. 145), quando, invece, i musei siciliani sono autonomi amministrativamente, gestiscono in proprio la programmazione, insomma non sono uffici delle soprintendenze, come lo erano i musei statali prima del dicembre 2014, quando è entrata in vigore la riforma Franceschini. Uno status, questo dei musei regionali, sancito dalla lontana legge regionale 80/1977.
Parchi archeologici e Consiglio regionale BBCC. Il libro conferma l’idea «confusa» (per usare un termine che vi ricorre) che l’ex assessore continua ad avere dei parchi archeologici siciliani. Le contraddizioni in cui incappa talvolta sono incredibilmente ravvicinate: «Segesta ha aperto il varco per la piena realizzazione di altri sei parchi, perimetrati tra il 2013 e i primi quattro mesi del 2014 (…)» (p. 128). Delle due l’una, si decida: o sono pienamente realizzati o solo perimetrati. Tra «gli unici veramente istituti» inserisce pure quello di «Himera del 2010» (p. 23, confermandolo a p. 139), che, invece, è solo perimetrato. Ma sappiamo che i parchi e la lettura dei loro decreti non sono, decisamente, il forte dell’ex assessore, malgrado ne abbia fatto un vanto della sua missione politica. «Caos» è, invece, il termine che abbiamo voluto assegnare al quadro dei parchi archeologici, con decreti da lei firmati variamente carenti e che presentano arbitrarie disparità procedurali (a noi è bastato qualche giorno per leggerli, è possibile che in un anno non se ne fosse accorto l’assessore-tecnico?) che li rendono annullabili, come ha spiegato nella nostra inchiesta l’avvocato di Legambiente, Corrado Giuliano. Che il decreto (carente) di sola perimetrazione del Parco della Neapolis a Siracusa (discorso valido per tutti gli altri parchi) sia ininfluente a mutare la situazione giuridica preesistente e, quindi, inefficace ai fini della tutela è un’ordinanza del Tar di Catania del 24 settembre 2014 a stabilirlo. Benché lei si ostini ad affermare il contrario, sia nel libro che nella nostra intervista. E se nell’inchiesta ci chiedevamo: «data l’accelerata impressa, in poco più di una anno del suo mandato, in direzione dell’istituzione del sistema dei parchi archeologici siciliani, fino ad allora praticamente inattuato, perché in cima all’azione dell’allora assessore Sgarlata non c’è stato proprio il reinsediamento del Consiglio?». La risposta nell’intervista rilasciata al collega Milani è una prova di più del suo procedere arbitrario e caotico. La Sgarlata spiega che «la composizione elefantiaca del Consiglio rendeva difficile recuperarne le funzioni». E in sua assenza cosa propone? Che la Giunta, ossia l’organo di governo della Regione, si facesse carico di alcuni pareri tecnici! In ogni caso tiene a rivendicare la riduzione dei componenti del Consiglio, da 53 a 15, confluita nell’art. 61 della Finanziaria 2015. Di nuovo, non ci resta che constatare che proprio nel libro dedicato a magnificare il suo operato da assessore, non tenga affatto, invece, ad attribuirsi questa riduzione (p. 138). Rimasta, neanche a dirlo, lettera morta. In ogni caso c’è ben poco da vantarsi di una riforma dell’organo solo in termini quantitativi e non qualitativi: la ricomposizione limitata a 15 membri, proposta anche dall’attuale assessore Vermiglio, consegna un Consiglio smaller, eppure più «pesante» dell’ultimo, niente affatto garanzia di uno snellimento della componente politica. È vero, anzi, il contrario, considerato il rapporto numerico di quest’ultima in proporzione al numero complessivo dei membri, è stata addirittura accresciuta: 5 su 15 sono politici, un terzo (Cfr. n. 373, mar. ’17, p. 8 e ed. online, 2 febbraio 2017). E già che la Sgarlata cita quell’art. 61, vale la pena osservare che la modifica introdotta dal comma 2 è una chiara riduzione delle prerogative e autonomia che la storica legge 77/80 attribuiva al Consiglio. Mentre, da questa, infatti, era previsto che «elaborasse» lo schema del piano regionale per la tutela e la valorizzazione dei BBCC, il comma modificato stabilisce che «fornisce indicazioni sul». Se queste erano state le «buone» intenzioni dell’assessora, resta il fatto che durante il suo mandato il Consiglio non si reinsediò mai. Ma lei dritta, noncurante di scoprire il fianco all’Amministrazione in caso di contenziosi, andò avanti con le sue decretazioni carenti.
Prestiti di opere d’arte. Che l’ex assessore fosse «allergico» al Consiglio BBCC ebbe modo di dimostrarlo anche in altra occasione. Quando si trattò di prevedere un autorevole parere per il prestito fuori dal territorio regionale delle opere d’arte identificative dell’intera Regione siciliana, l’assessore-tecnico (non un «volgare» politico) nel suo decreto preferì a quello del Consiglio, quello della Giunta, l’organo di governo della Regione: forse che gli assessori alle Risorse agricole, alla Salute, alla Famiglia o quello alle Infrastrutture siano in possesso degli strumenti per valutare le ragioni conservative e i profili culturali e scientifici sottesi alla richiesta di prestito di un’opera d’arte? Nell’intervista, come dicevamo, torna sul punto: «in assenza (del Consiglio, ndc.), avevo proposto che fosse la Giunta regionale a farsi carico di alcuni pareri». Diciamo pure che sembra mettercela tutta per peggiorare la faccenda. Cos’altro starebbe sostenendo, infatti, se non che tanto poco credeva lei per prima nel reinsediamento del Consiglio da non ritenere di prevederne il parere in un atto normativo, che resta in vigore finché non venga abrogato. Anche se domani venisse finalmente insediato in Sicilia il nuovo Consiglio, il parere sui capolavori da prestare fuori dal territorio regionale, lo dovrebbe dare, grazie al suo decreto, appunto, la Giunta! Non si esplica con queste modalità l’invadenza della politica in questioni tecniche che non le dovrebbero competere? E non è questo che va denunciando ad ogni piè sospinto nel libro? E, poi, sempre l’assessore-tecnico non si è accorto che in Sicilia manca una chiara disciplina dei prestiti? Il punto di riferimento normativo resta, naturalmente, il Codice, ma per definire criteri, procedure e modalità, l’art. 48 c. 3 rinvia all’emanazione di un decreto ministeriale a cui nella Sicilia autonoma dovrebbe corrispondere un decreto assessoriale, mai emanato (nemmeno da lei che pure aveva firmato la lista «blindata» di opere che non possono, salvo eccezioni, lasciare la Sicilia). Per cui la normativa esistente è parziale e contraddittoria, mentre finora è invalsa una prassi che non trova, appunto, appigli legislativi, consentendo il massimo arbitrio agli assessori al ramo. (cfr. ed. online, 22 agosto 2016). Vale la pena, infine, ricordare la gaffe per cui fece riferimento al suo decreto «blinda prestiti», come appiglio normativo per sostenere la propria contrarietà al prestito dell’Antonello da Messina di Palazzo Bellomo: peccato, però, che la mostra si dovesse allestire in un paese a soli 40 km da Siracusa e che l’opera, quindi, non dovesse affatto uscire dal territorio regionale, oggetto della disciplina del decreto.
L’altro Consiglio che non s’ha da insediare! Ma c’è anche un altro organo consultivo per la cui ricostituzione non sembrò interessata in modo particolare: ancora un Consiglio, ma questa volta del Parco della Valle dei Templi. Nel dicembre 2013, invece di reinsediarlo, essendo decaduto dal 2011, nominò un nuovo commissario, cosicché al Parco tutto veniva deciso da una consolidata diarchia operativa sottratta a qualunque valutazione di merito: quella direttore-commissario (il nuovo consiglio è stato rinominato appena da qualche giorno, cfr. ed. online, 30 marzo 2017). Perché anche lei nominò l’ennesimo commissario e non insediò il legittimo Consiglio del Parco?
Colpa delle leggi o di chi non le applica? Ma il cattivo rapporto dell’ex assessore con la normativa regionale, non si limita alla legge 20/2000 sui parchi archeologici. Lo ha spiegato più volte il già menzionato avvocato Salerno, non è vero, come lei sostiene che la «Legge 10 del 2000 ha azzerato il ruolo tecnico» e «ha quindi azzerato anche merito e competenze» (p. 30). È’ vero, invece, che è stato interesse di tutti i Governi regionali non attuare la legge laddove stabilisce che si doveva emanare un regolamento per «disciplinare le modalità di costituzione e tenuta del ruolo unico articolato in modo da garantire la necessaria specificità tecnica e/o professionale anche ai fini dell’attribuzione degli incarichi in relazione alla peculiarità delle strutture» (art. 6, c. 2). Altro che cattiva legge, andava solo attuata, invece che fare carta straccia di alcuni passaggi!
Riserve naturali: ancora un’interpretazione soggettiva delle sentenze. La giurisprudenza non è davvero il forte dell’ex assessora, lo dimostra una volta di più nella sua lettura della sentenza 212/2014 della Corte Costituzionale (p. 108 e segg.) Riportiamo qui quanto le faceva notare ancora l’avvocato Salerno, dirigente della Regione (insieme all’ irrilevanza del suo decreto di perimetrazione della Neapolis ai fini della tutela, in quanto «il vincolo di inedificabilità assoluta scatterà solo con il decreto istitutivo del parco»), a proposito dell’istituenda Riserva Naturale Orientata «Capo Murro di Porco e Penisola della Maddalena» (alias Riserva della Pillirina, cfr. ed. online, 3 novembre 2015): «Sgarlata dice “il consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale ha ritenuto di andare avanti nella procedura per l’ istituzione della riserva solo dopo aver ascoltato il parere del sindaco di Siracusa”. Insomma, secondo lei, il prossimo passo è la convocazione di Garozzo (sindaco di Siracusa, ndc) da parte del consiglio regionale. No! Attenzione, la sentenza della Corte Costituzionale 9 luglio 2014 n. 212, della quale ci siamo occupati pochi giorni fa, ha stabilito chiaramente quali sono gli ambiti del CRPPN (ambiti tecnico-professionali), infatti, questa parte della Legge siciliana n. 98/1981 sui parchi e riserve non è stata incisa dalla Corte, mentre è stata dichiarata incostituzionale quell’altra parte della legge siciliana che non garantisce la partecipazione del Comune al processo POLITICO decisionale che istituisce la Riserva. Detto altrimenti, come zucchero non guasta bevanda, va pure bene che Garozzo sia convocato dal CRPPN a dare il suo parere (ma che tipo di parere di profilo naturalistico può dare il Sindaco ?!). Ma il vero onerato ad associare il Sindaco nel procedimento istitutivo è l’Assessore, in quanto la decisione è politica ed involge anche la concertazione di quegli interessi socio-economici di cui il Sindaco è il referente istituzionale. Ergo toccava all’Assessore convocare il Sindaco e, a quanto pare, non lo fece. Quindi qui è la lacuna dell’Assessorato! E non confondiamo i piani (CRPPN e Assessore), per favore!». Lascia poi davvero perplessi che l’ex assessore, nella sua irremovibile convinzione che grazie al suo decreto di perimetrazione del parco archeologico di Siracusa «siano scattate le norme di salvaguardia a tutela del bene e questo è certamente un successo» (p. 111), equipari lo step di un iter amministrativo tutto ancora da completare al decreto assessoriale che nel 2015 ha inserito la Riserva della Pillirina nel piano Parchi e Riserve dell’isola (ivi).
Custodi. Di un argomento su tutti, però, la Sgarlata ha fatto il proprio cavallo di battaglia. D’accordo, la questione della distribuzione dei custodi è un problema reale, ma è talmente in cima alle «preoccupazioni» anche dell’Assessorato, che nel luglio scorso ha addirittura rivoluzionato il suo assetto organizzativo quasi con l’unico scopo di regolarne la presenza tra i vari siti. Ci si è inventati degli irrazionali Poli museali (cfr. ed. online 10 ottobre 2015, e n. 358, nov. ’15, p. 12; e ed. online, 31 luglio 2016), praticamente solo per consentire una maggiore mobilità (entro il limite di 50 km, come previsto pure dalla normativa nazionale) da un sito all’altro all’interno di uno stesso polo del personale di custodia, prima inamovibilmente incasellato nel singolo istituto. A caccia di custodi in sovrannumero la crocettiana pentita li vede moltiplicarsi come i pani e i pesci anche nel caso in cui proprio la loro mancanza, al contrario di quel che afferma (pp. 63-64), stava per pregiudicare l’apertura del più antico museo pubblico di Sicilia, il Salinas. Come ci riferì la direttrice, fu proprio la nuova misura che consentì di trasferire al museo il personale di custodia da altri siti dello stesso polo (cfr. ed. online, 27 luglio 2016 e art. 31 lug. ’16 cit.). In un libro in cui l’errore e l’imprecisione è sempre dietro l’angolo, leggiamo pure che il museo sarebbe «stato riaperto al pubblico per la visita dell’esposizione permanente» (p. 64), quando si è trattato, invece, dopo sette anni di restauro, di un’apertura limitata al solo piano terra, mentre le salette del piano terra già disponibili avevano ospitato negli anni precedenti delle mostre. Tornando, quindi, alla questione custodi, il punto è che, si vorrebbe far passare per «un’anomalia siciliana» quanto è stato denunciato pure dal soprintendente Massimo Osanna, dichiarando che «i sindacati autonomi tengono sotto ricatto Pompei». Mentre giusto per fare un altro esempio nel resto del Paese, Flaminia Gennari Santori, direttrice della Galleria Nazionale d’Arte antica (Gnaa) a Roma, ha definito «drammatico» il problema dei custodi (cfr. numero 366, lug. ‘16, p. 8). Un problema, dunque, di rilievo nazionale, al quale il GdA ha dedicato uno speciale approfondimento (titolo «Custodi o padroni?», n. 357, ott.’ 15, pp. 1 e 4). Altro che caso siciliano da buttare in pasto alle Iene (puntata del 13 mar. ‘17, a cui ha risposto il sindacato). E all’epoca, lei, l’assessore come intendeva risolvere il problema, peraltro senza riuscirvi? Semplicemente portando il limite del 30% dei festivi al 50%. Ne doveva andare fiera quando, passando in rassegna in una conferenza pubblica alcuni tra i suoi provvedimenti più importanti, includeva anche questo. Chissà perché poi nel libro (come tante altre cose di cui abbiamo detto) non se n’è più ricordata.
Sponsorizzazione, mecenatismo e crowdfunding. La confusione tra le diverse modalità le fa definire «il modello Tod’s» e «il modello Packard» «due modi diversi, direi antitetici di intendere il mecenatismo» (pp. 212 e 213), quando, invece, si tratta nel primo caso di uno sponsor e nel secondo di un mecenate, mentre il restauro della Nike di Samotracia, reso possibile grazie a un crowdfunding, lo introduce con un «a proposito di sponsorizzazioni» (p. 216). Ma poi, «per salvare la patria» (p. 213), dovendo optare tra mecenatismo e sponsorizzazione, visto che per la scrittrice la «risposta è presto fatta» (ivi) a favore del primo, non è vero, forse, che nell’unico caso (nuovo allestimento per l’Auriga di Mozia) in cui fece appello a un privato seguì la seconda modalità? Un solo caso e presto, presto… la Sgarlata non trova un puro filantropo? E, allora, non sarà forse da considerare che in un contesto come quello siciliano, così povero di realtà private disposte a intervenire munificamente in favore dei beni culturali, non ci si possa tanto permettere di snobbare l’istituto della sponsorizzazione? Piuttosto, il punto è che l’amministrazione pubblica dovrebbe equilibrare contratti pendenti a favore del privato, come è stato nel caso di un’azienda vinicola per Selinunte, che è stata, peraltro, occasione proprio per regolamentare la materia delle sponsorizzazioni con la circolare che l’ex assessore ignora (cfr. edizione online, 10 dicembre 2015 e n. 362, mar. ’16, p.2).
La valorizzazione… del virtuale. Quale sia, invece, la sua idea della valorizzazione la si può condensare in questo interrogativo: «chi può dire che una volta usciti dalla mostra, non si abbia voglia di andare a vedere gli originali?» (p. 261). Solo che con «mostra» si sta riferendo a quelle con riproduzioni virtuali di capolavori d’arte i cui originali si trovano praticamente dietro l’angolo. Invece che non avere dubbi sul fatto che le nuove tecnologie virtuali non possano che giocare un ruolo complementare, non in grado di sostituirsi alla visione dell’originale, s’interroga: «ma l’emozione è veramente la stessa? Reagiamo tutti allo stesso modo guardando un’opera d’arte o la familiarità che soprattutto le nuove generazioni hanno con la tecnologia rende preferibile un viaggio sensoriale all’esperienza autentica della visione diretta di un’opera?» (ivi).
Il senso di un libro. Tolti argomenti denunciati con ricorrenza sulla stampa, come il «nepotismo e il clientelismo», biglietti omaggio, numero irrilevante dei visitatori dei siti monumentali, custodi, musei al buio perché non si hanno nemmeno i soldi per cambiare le lampadine - e anche dimenticando errori, letture parziali e strumentali, che in via del tutto esemplificativa abbiamo segnalato, - cosa resta in grado di motivare la scelta, invece che consegnarsi all’oblio, come più saggiamente hanno fatto le altre «comparse» crocettiane, di raccontarci la storia del suo breve assessorato «illuminato», fatto di tanti buoni propositi sacrificati sull’altare della mala politica e del caos amministrativo, mentre lei, per citare la premessa del libro, sarebbe uno di quei tecnici che «hanno mostrato di sapere coniugare la competenza all’agire per il bene comune» (p. 7)? Un «avrei voluto, ma non ho potuto» che potrebbe a buon diritto condividere con tanti altri assessori di cui negli anni abbiamo registrato virtuosi annunci, poi miseramente naufragati in un nulla di fatto. «Confusione» è il termine più ricorrente sotto la penna dell’ex assessora-scrittrice, solo che ha dimenticato di riservarlo anche a se stessa. Altro che «essere competenti ti aiuta a raggiungere in poco tempo obiettivi mai centrati» (p. 14). Quali? Voleva fare i parchi archeologici ed è tutto da rifare perché i decreti sono annullabili; voleva riattivare la Carta del Rischio, ma a capo del Centro del Restauro durante il suo mandato c’è un’archeologa non all’altezza del compito; voleva inaugurare una stagione della reciprocità nei prestiti delle opere, ma alla fine la reciprocità con British, Getty o Cleveland è stata «difettosa» (cfr. ed. online, 31 marzo 2016, e n. 363, apr. ’16, p. 23) e ancora si attende il Caravaggio dal Cleveland. Insomma, se andiamo effettivamente a vedere come si mosse lei quando ebbe le leve decisionali, ben pochi appigli ci consentono di ritagliarle un giudizio che la faccia emergere sugli altri «colleghi». Con l’aggravante che nel suo caso si è trattato di un «tecnico», un’archeologa (la premessa del libro si intitola proprio «Un tecnico a palazzo») e non di un «rozzo» politico. Ma lei sembra esserne proprio convinta: è stata «finalmente la persona giusta al posto giusto» (p. 13)! Ciò di cui siamo convinti anche noi, invece, si legge nelle ultime righe, quelle con cui chiude il libro: «il compito della buona politica è sempre quello di mettere a fuoco quanto meglio possibile quella “punta illuminata” alla quale saldare tenacemente il nostro futuro» (p. 298). Ecco, proprio questa messa a fuoco le è decisamente mancata.
Altri articoli dell'autore
La proposta di legge Orlando-Franceschini è passata alla Camera
Pronta la nuova agorà del Museo Salinas in restauro da dieci anni
Cronaca e progetti a cinquant’anni dal sisma
Polemiche per la trasferta di una tavoletta del pittore messinese, tra le 120 opere scelte dal critico d'arte per il Castello Ursino di Catania.