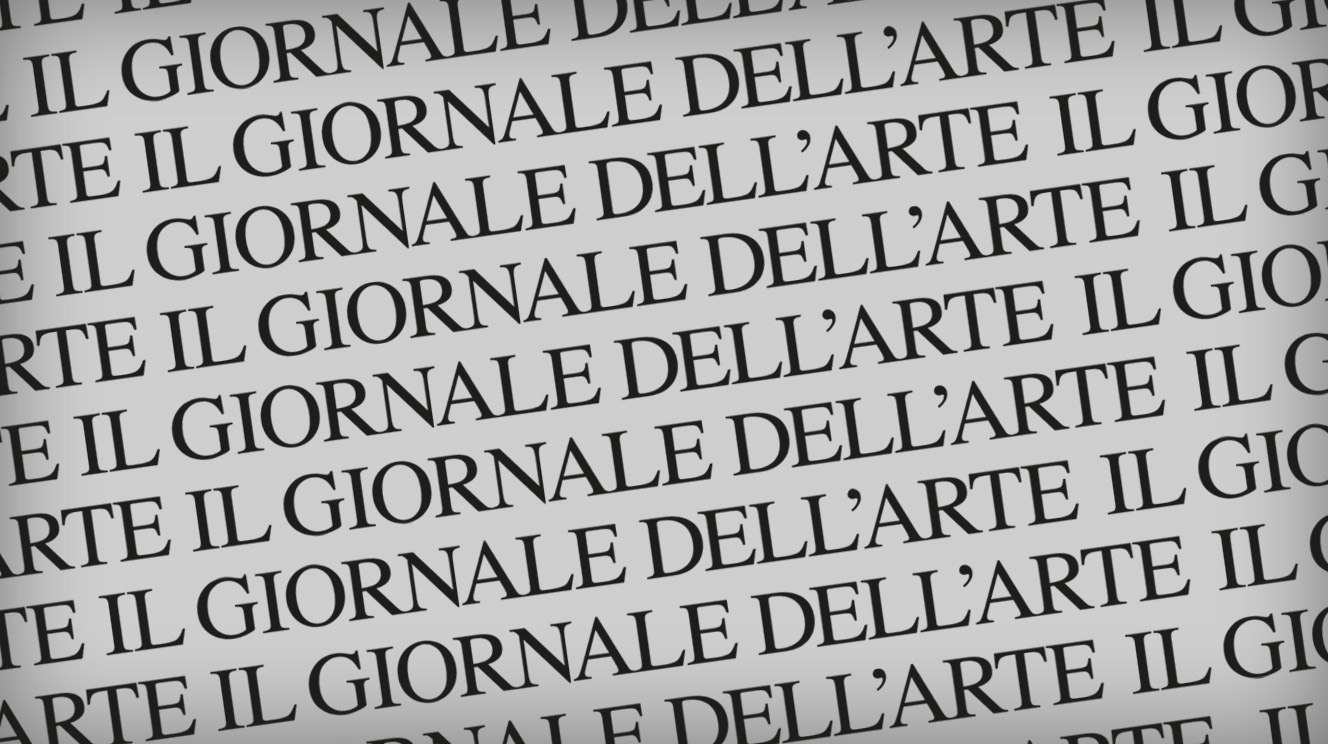Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
.jpeg)
Flaminio Gualdoni
Leggi i suoi articoliLa bambolina yankee nel Mudec è una faccenda ellittica e misteriosa, direbbe Ellroy
«Cos’è la meraviglia?». «Non so, forse quel quid di meraviglioso, ellittico, misterioso che non conosceremo mai del tutto». Viene in mente, per forza, la frase memorabile del Clandestino di James Ellroy, appena scopri che il nuovo Museo delle Culture di Milano, quello che ci annunciavano pomposamente come dedicato alle culture altre rispetto all’eurocentrica classica, sta per dedicare una mostra nientemeno che a Barbie, ovvero la bambolotta bionda che incarna quanto di più stronzo l’immaginario occidentale sia riuscito a concepire da molti decenni a questa parte.
L’effetto notevole è che la prima reazione che ti monta dentro non è di indignazione, non è neanche il solito vaffa sgorgante dai precordi, ma una forma di fatua ilarità. Maccome, si è appena conclusa «Africa. La terra degli spiriti», bellissima anche se aveva un titolo da documentario anni ’50 e vantava, per gli standard da mostra museale d’oggi, il record di iniziativa meno pubblicizzata del decennio. Sta risolvendosi la faccenda, a proposito di meraviglia, per cui forse si può dire che il nuovo edificio, notevole, l’ha progettato David Chipperfield o forse non si può perché lui per il momento è arrabbiato come un cinghiale con chi ha eseguito i lavori e non vuole.
Ti aspetti che dunque, finito il rodaggio, adesso il Mudec faccia il botto, e ti becchi Barbie. La quale ha a che fare con le culture variamente definite primitive, extraeuropee, modernamente plurali eccetera a seconda dei gradi di politicamente corretto, più o meno come Donald Trump con un documentario sugli slum di Città del Messico, o Salvini con un’adunanza plenaria dei Lincei.
Dunque, ricapitoliamo. Barbie è la roba più americana che c’è, cocacola a parte, e dal 1959 inquina le fantasie di intere generazioni d’umanità planetaria facendo danno quasi quanto le emissioni di gas a effetto serra, con la sua filosofia (!) da pupattola fashion già profeticamente photoshoppata quando ancora negli Stati Uniti c’erano in tutto tre-quattromila di quegli accrocchi che oggi chiamiamo computer, e rifattona quando ancora Ivo Pitanguy non aveva inaugurato la sua mitica clinica.
A meno che, vuoi mai, la ricchezza delle differenze culturali che il museo è vocato a esplorare risieda nel fatto che negli anni i produttori si son dovuti inventare anche versioni di colore, ispaniche, giapponesi, indiane eccetera, e che nell’Oriente islamico impazzi la concorrente Fulla, bambola con tanto di abaya e velo che, devota, «onora il padre e la madre» e non manifesta, dicono i produttori, gli «atteggiamenti disonorevoli» della più nota versione yankee.
Certo, Barbie in effetti appartiene a una cultura «altra». È una specie di Ufo, infatti. Ma che ci azzecchi con quella che nasceva come «sede espositiva delle civiche Raccolte etnografiche» e luogo di un’identità museale «tra ricerca scientifica, testimonianza storica, interpretazione della contemporaneità e visione sul futuro» (cito dal sito ufficiale), è proprio una faccenda ellittica e misteriosa, come dice il maestro Ellroy. E pensare che quando l’hanno inaugurato un po’ di mesi fa Alessandra Mottola Molfino, il direttore generale dei musei milanesi che avviò il progetto del Mudec, aveva dichiarato che «oggi non era pensabile realizzare un museo “coloniale”, come quelli che ancora esistono nelle grandi capitali europee». Porca vacca, ma se c’è un simbolo del colonialismo moderno è proprio la bambola bionda, con tutti gli annessi e connessi del suo way of life da telefilm hollywoodiano di serie B: solo che i colonizzati siamo noi.
Poi, vabbé, lo so bene che quelli che gestiscono il museo devono fare anche i bilanci del botteghino e che, per stare sul volgarotto, tira più un capello di Barbie che tutte le dee d’Africa e d’Asia messe insieme. Per dire, prima si nasceva incendiari e si moriva pompieri, oggi si nasce intellettuali sussiegosi e si muore contabili.
Altri articoli dell'autore
Il Criptico d’arte • Conosciuto anche come Vasco dei Vasari, l’architetto italiano fu un personaggio anomalo: nonostante il suo contributo al Futurismo, indagò il modo in cui l’anarchia influenza l’arte
Il Criptico d’arte • La vicenda della Banana di Cattelan: da provocazione sul mercato a oggetto di gesti insensati e fuorvianti
A Milano una collettiva di 12 artisti omaggia in altrettante puntate il capoluogo culla della tecnica artigianale e artistica in grado di passare da generazione in generazione
La grande mostra sul movimento artistico voluta dall’ex ministro Sangiuliano in realtà arriva dopo settant’anni di studi specialistici sull’argomento. Ma l’Italia non è futurista