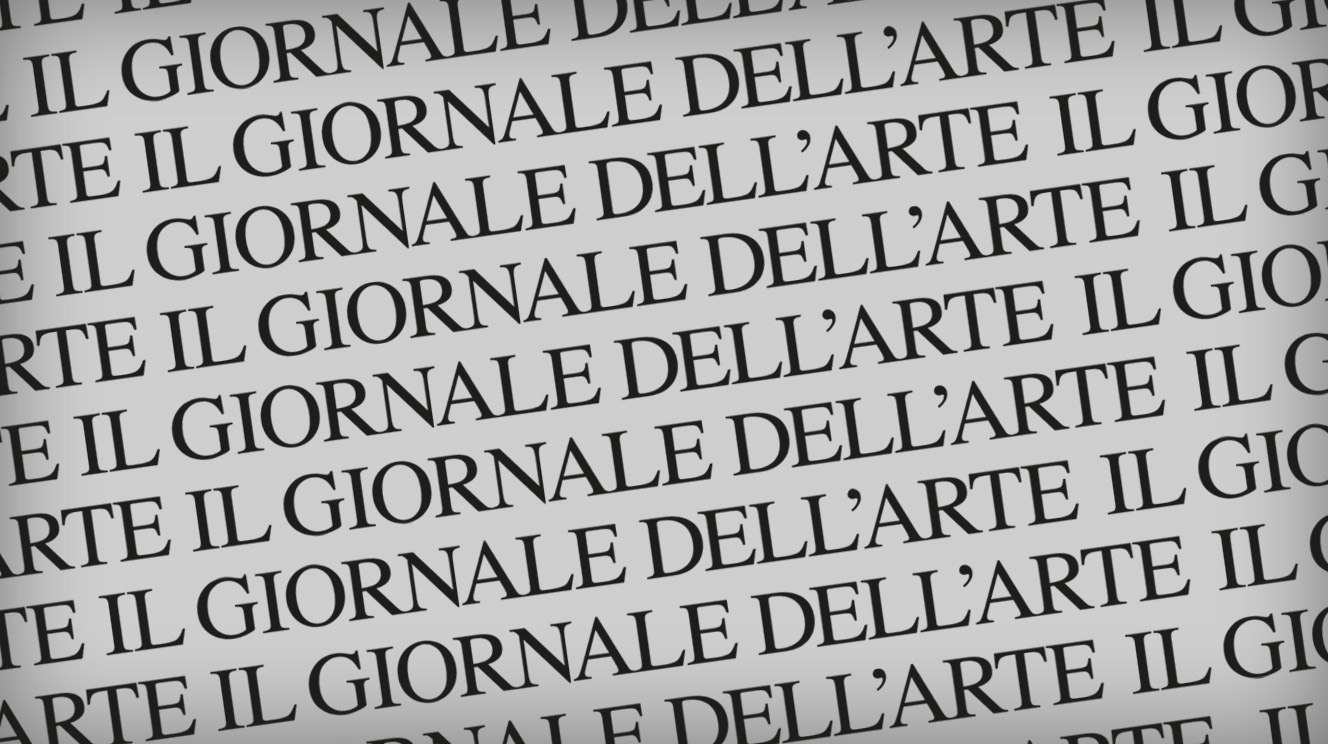Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Massimiliano Cesari
Leggi i suoi articoliLa cosiddetta Legge Delrio, n. 56 del 7 aprile 2014, prevede la trasformazione delle attuali Province in «enti territoriali di area vasta», con l’individuazione di nove città metropolitane (Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria), più Roma Capitale. Dinanzi a questo riordino amministrativo (che dovrebbe snellire la macchina burocratica e, soprattutto, ridurre la spesa pubblica, tagliando enti ritenuti «inutili») si pone un grande punto interrogativo: quale sarà il destino di centinaia di strutture museali (e bibliotecarie) che fino all’altro giorno erano gestite dalle Province, e che non avranno la fortuna di rientrare nei nove Enti metropolitani?
Maurizio Braccialarghe, delegato Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiana) alla Cultura e assessore comunale a Torino, sottolinea: «La situazione sta per collassare in tutta Italia e il fenomeno potrebbe essere addirittura “terminale” nelle regioni del Mezzogiorno». Tuttavia, se la questione non sarà presto chiarita, potrebbero chiudere i battenti anche importanti Musei del Nord, come il Castello Estense (Ferrara) o il Museo di Torcello (Venezia). Ma è al Sud che il problema desta maggiore preoccupazione, dove spesso tali strutture sono veri e propri avamposti di cultura e di conoscenza, e pochi sono i Musei civici (di proprietà dei Comuni), più diffusi nel Nord Italia.
Ad esempio, nella sola Provincia di Salerno, come evidenziato da #achicompetelacultura (la campagna nazionale di raccolta firme partita dalla Campania), rischierebbero il Museo archeologico, il Castello Arechi, la Pinacoteca di Salerno, la Biblioteca Provinciale e Villa Guariglia, con annesso il Centro di Studi Salernitani.
Anche in Puglia da qualche mese associazioni di cittadini, studiosi e diversi operatori culturali stanno lottando per evitare la chiusura della Biblioteca Provinciale di Foggia e della Biblioteca e del Museo Archeologico «F. Ribezzo» a Brindisi.
Emblematico, è il caso del Museo Provinciale «Sigismondo Castromediano» a Lecce, uno dei più importanti musei non statali della Puglia, certamente il più antico, fondato nel 1868. Una struttura che racconta il territorio attraverso una collezione archeologica di circa 6mila pezzi, in maggior parte di epoca messapica (probabilmente altri 4mila sono conservati nei depositi); ma anche con numerosi manufatti (pitture e sculture) di epoca moderna e contemporanea; senza dimenticare la collezione di ceramiche medievali e moderne di varie fabbriche pugliesi.
Un museo che si è fatto promotore, anche grazie all’azione dell’ex direttore Antonio Cassiano, scomparso in luglio, di importanti mostre didattiche extraregionali. Il museo ha al suo interno personale specializzato, conservatori (storici dell’arte e archeologi) e un laboratorio di restauro che ha spesso servito il territorio con il recupero di beni culturali: ultimo, ad esempio, il restauro e la musealizzazione del Crocifisso ligneo dello scultore tardomanierista Vespasiano Genuino (catalogo Allemandi, 2014).
Contro la «cancellazione» del museo si sono mossi diversi studiosi e docenti universitari del locale Ateneo che, attraverso l’Associazione Vivere Lecce, hanno inoltrato un appello al ministro Franceschini, al direttore generale Archeologia Gino Famiglietti e ai componenti della VII Commissione del Senato e della Commissione Cultura della Camera, nel quale si chiede che «sia valutata la possibilità di inserire il Museo Archeologico Provinciale di Lecce fra i Musei statali e di interesse nazionale all’interno del Polo Museale Regionale dello Stato».
Le strade da battere però potrebbero essere anche altre, come l’inserimento nella rete dei Musei Archeologici della Città di Lecce. In questo senso, l’archeologo Francesco D’Andria (Università del Salento) suggerisce «una riflessione collettiva sul “Sistema museale di Lecce”, con la partecipazione di tutte le forze intellettuali della città». Una soluzione che potrebbe essere la più logica, se non fosse per la natura e la storia, non solo archeologica, del museo; come aveva evidenziato lo stesso fondatore Sigismondo Castromediano (1811-95), che desiderava non restringere i contenuti «puramente agli avanzi più vetusti, di sotterra venuti», ma «ampliare ancora la nostra raccolta con quanto i men lontani padri nostri nelle arti belle, nelle loro industrie ed arti minori lasciarono» (1871).
Comunque sia, non si conosce la sorte del Museo di Lecce (come degli altri Enti), e si attende una risposta dal Ministero.
Altri articoli dell'autore
Un itinerario tra natura, arte e storia: cattedrali, trulli, castelli, mosaici e paesaggi in una regione cerniera tra Oriente e Occidente
Nell’istituzione fondata nel 2018 oltre 200 opere del ’900 e un percorso di Pino Musi tra luce, architettura e sguardo
Nuovi progetti di tutela, valorizzazione e turismo esperienziale nei luoghi dell’arte sacra
È stato da poco rinnovato il protocollo triennale tra la Fondazione Archeologica Canosina e il Tribunale di Trani che mira a ricucire lo strappo causato dalla depredazione del patrimonio