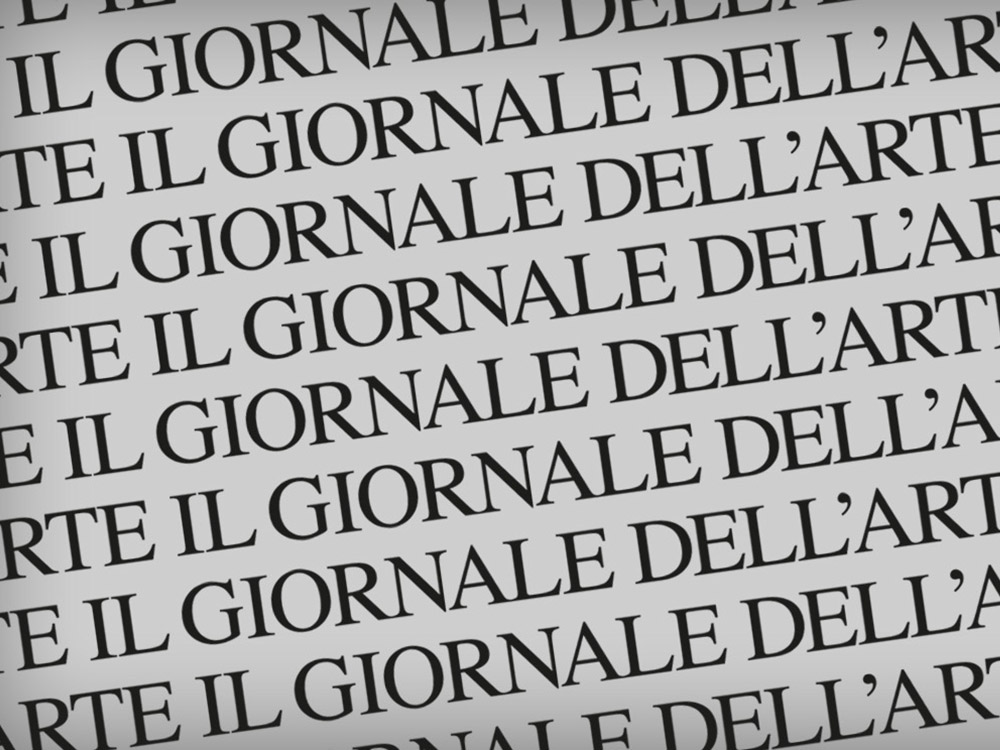Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Micaela Deiana
Leggi i suoi articoliNasce a San Sperate la Fondazione Pinuccio Sciola, a pochi mesi dalla scomparsa dello scultore (1942-2016) noto soprattutto per le sue suggestive «pietre sonore». Gli eredi Chiara, Tomaso e Maria raccolgono così la volontà del padre, creando un’istituzione per l’arte e la ricerca che risponde a uno spirito di apertura, ospitalità e condivisione verso la comunità e la natura in cui questa vive.
Lo fanno a partire dalla casa paterna (parte del patrimonio della Fondazione, insieme a una selezione di opere) che continua così a essere vivo centro culturale proprio come voluto già dallo stesso Sciola, con l’auspicio di farne presto una sede museale monografica.
La fondazione, senza fini di lucro, si propone di divulgare il nome e l’opera dell’artista, organizzando mostre, convegni, eventi culturali e sostenendone la pubblicazione editoriale. Particolare attenzione sarà rivolta, inoltre, alla promozione della scultura e dell’arte in Sardegna, e alla costruzione di un ponte fra il megalitismo nuragico e le tendenze contemporanee, un tema centrale nella produzione dello scultore.
Altri articoli dell'autore
La 16ma edizione della mostra propone un approccio metodologico al mondo che rifiuta lo sguardo patriarcale per riflettere sui concetti di identificazione, oggettivazione e capacità di azione di chi si trova in una posizione marginalizzata
Il team curatoriale tutto femminile della 16ma edizione della mostra ha invitato a confrontarsi sul tema del «portare» anche tre artiste italiane: Rossella Biscotti, Adelita Husni-Bey e Raffaela Naldi Rossano
Dal prossimo gennaio la seconda edizione della rassegna dedicata al divino nell’esperienza del mondo materiale: un dialogo tra cultura islamica e linguaggi del contemporaneo. Anche l’italiano Sassolino tra gli autori delle 500 opere di venti Paesi
Si distinguono i Paesi del Sud globale, che davanti alle incertezze geopolitiche e alle tensioni irrisolte della colonizzazione e dello sfruttamento cercano un’identità nella natura e nei luoghi che storicamente hanno ospitato la vita delle comunità. Un ritorno alle radici che spesso guarda al sacro