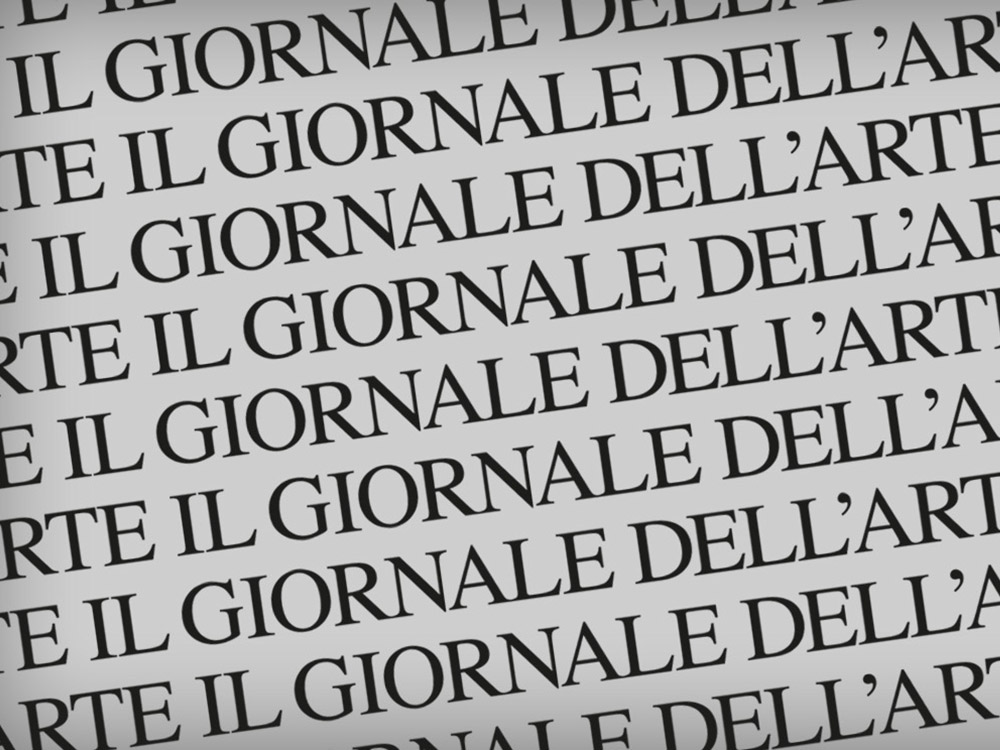Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Fabrizio Lemme
Leggi i suoi articoli
La materia di questo mia riflessione è il diritto d’autore: il contenuto di tale diritto è oggetto di dettagliata disciplina nella fondamentale Legge 633 del 1941, una sorta di «legge uniforme» che trova una sostanziale corrispondenza in tutti gli ordinamenti giuridici civilizzati. È dedicato ad esso il Capo III del Titolo I di tale legge (artt. 12-71 decies) e assumono particolare significatività le norme che prevedono il diritto di pubblicazione (art. 12), il diritto di riproduzione (art. 13), il diritto di esecuzione (art. 15) ecc.
Molti non sanno che, quando acquistano, anche direttamente dall’artista, un’opera d’arte, dovrebbero pattuire autonomamente anche l’acquisto del diritto di riproduzione: diversamente, almeno a stare a un’interpretazione letterale della legge, non potrebbero pubblicare l’opera della quale sono proprietari senza corrispondere all’autore un autonomo compenso, che solitamente è gestito dalla Siae. Si pone, a questo punto, un ulteriore problema: l’autore o i suoi eredi, titolari del diritto di riproduzione, possono, a loro insindacabile giudizio, vietare a un soggetto, proprietario di un’opera, il diritto di riprodurla in catalogo e quindi la possibilità stessa di ricavarne un compenso attraverso la vendita? A stare alla lettera della legge, la risposta dovrebbe essere affermativa: l’autore, per sola antipatia nei confronti di Tizio, attuale proprietario di un dipinto da lui creato (e magari acquistato a prezzo reputato vile, quando l’autore stesso era ancora sconosciuto), potrebbe proibirgli di riprodurre l’opera nella sua interezza, per fini diversi da quelli meramente scientifici (art. 70).
Aggrava la situazione il fatto che gli artt. 23-25 attribuiscano la titolarità del diritto di riproduzione, morto l’autore, «al coniuge, ai figli e, in loro mancanza, ai genitori e agli altri ascendenti e discendenti diretti; mancando gli ascendenti e i discendenti, ai fratelli e alle sorelle e ai loro discendenti»: questo, fino a quando l’opera sia caduta, come suol dirsi, in «pubblico dominio», per essere trascorso il settantesimo anno solare dopo la morte dell’autore. Dunque, a stare alla lettera della legge, chi acquista un’opera d’arte di fatto non la può rivendere, non potendo neppure riprodurla in un catalogo d’asta, per un periodo di tempo che può risultare (quasi) infinito. A me questa conclusione non è mai piaciuta: attribuire all’autore e ai suoi (spesso famelici) eredi un tale «diritto di veto», mi sembra conflittuale con altre situazioni giuridiche, che hanno almeno pari dignità costituzionale. La Costituzione, invero, all’art. 33, 1 co., proclama che «l’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento»; ma, all’art. 42, 2 co., recita anche che «la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge» e che (art. 41/1) «l’iniziativa economica privata è libera».
Facciamo allora una prima constatazione: le tre situazioni giuridiche, ossia il diritto d’autore, il diritto di proprietà, il diritto di iniziativa economica, sono poste sullo stesso piano gerarchico, senza quindi che si possa riconoscere all’una la supremazia sull’altra o sulle altre. Infatti, non vi è nulla nella Costituzione su cui poter fondare un supposto primato o un supposto privilegio di una di tali situazioni rispetto alle altre. È allora necessario procedere a un bilanciamento che assicuri un giusto equilibrio tra le situazioni considerate, quando le stesse vengano potenzialmente in conflitto.
Propongo, pertanto, al riguardo, questa lettura. Innanzitutto, sul diritto di riproduzione: mi sembra che il senso della legge sul diritto d’autore sia quello di circoscriverlo alle forme che realizzino una vera moltiplicazione dell’opera originaria. In altri termini, se io, tramite la stampa realizzo la moltiplicazione dell’opera d’arte, ponendo in vendita i multipli, questo e solo questo ricade nel diritto di riproduzione, indicato dall’art. 13 L.A. Una piccola immagine fotografica, non suscettibile di autonoma fruizione o utilizzazione decorativa, non può ritenersi proibita o circoscritta dalla legge e quindi suscettibile di incorrere anche nel divieto assoluto che eredi famelici potrebbero porre a scopo vessatorio nei confronti del privato proprietario, gallerista o collezionista. Ad laterem di questa lettura, un’altra si può porre in via subordinata: l’autore o i suoi eredi, attribuendo alla Siae la facoltà di gestire il loro diritto di riproduzione, abdicano al potere di veto e quindi alla possibilità di interdirla in toto, a Tizio piuttosto che a Caio. In altri termini, conferendo alla Siae la facoltà di riscuotere un compenso per ogni riproduzione, l’autore o gli eredi rinunziano al diritto di veto e al suo esercizio nei confronti di Tizio o di Caio. Perché questo risulta veramente odioso: riconoscere all’autore o ai suoi eredi la possibilità di far fallire addirittura un mercante d’arte, che abbia legittimamente investito risorse e sostanze nell’acquisto delle opere di un autore.
Altri articoli dell'autore
I beni culturali possono essere dichiarati di particolare interesse solo se la loro esecuzione risalga ad almeno cinquant’anni
La capacità (e l’obbligo) di correggersi della Pubblica Amministrazione
Va introdotta una distinzione tra ricerca significativa e ricerca inutile: la prima aggiunge qualcosa alle conoscenze già acquisite, la seconda si limita a riproporre il «déjà dit»
Il conflitto tra Russia e Ucraina mette in luce un relativismo che parte da Giovanni Battista Vico