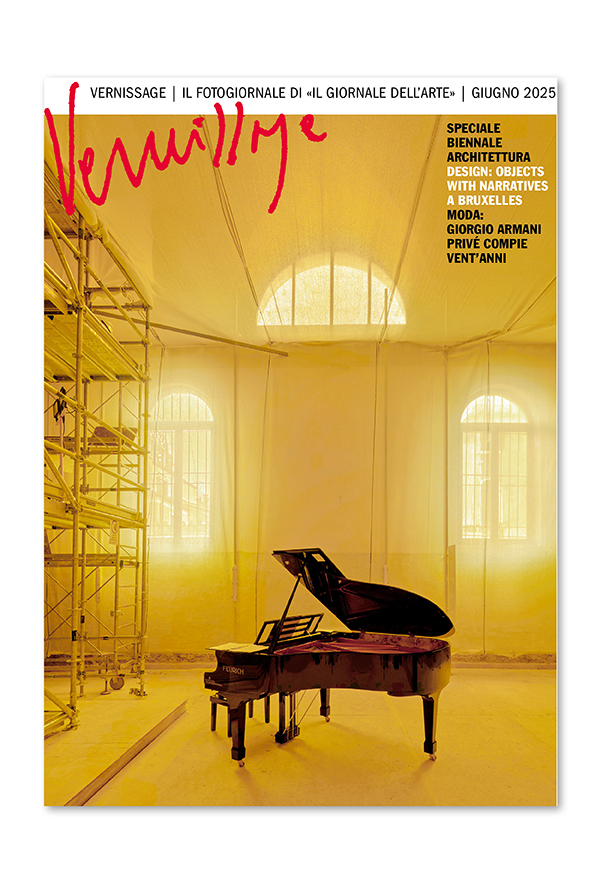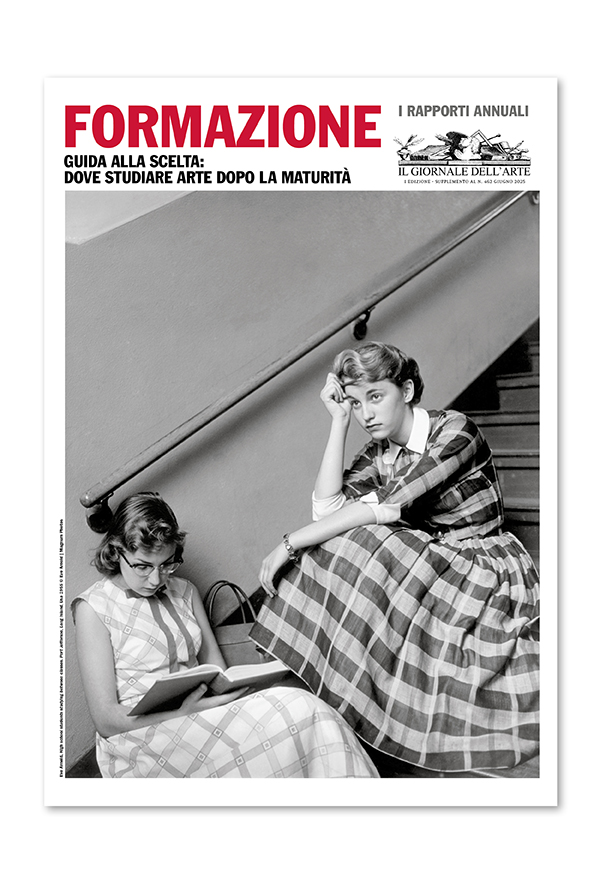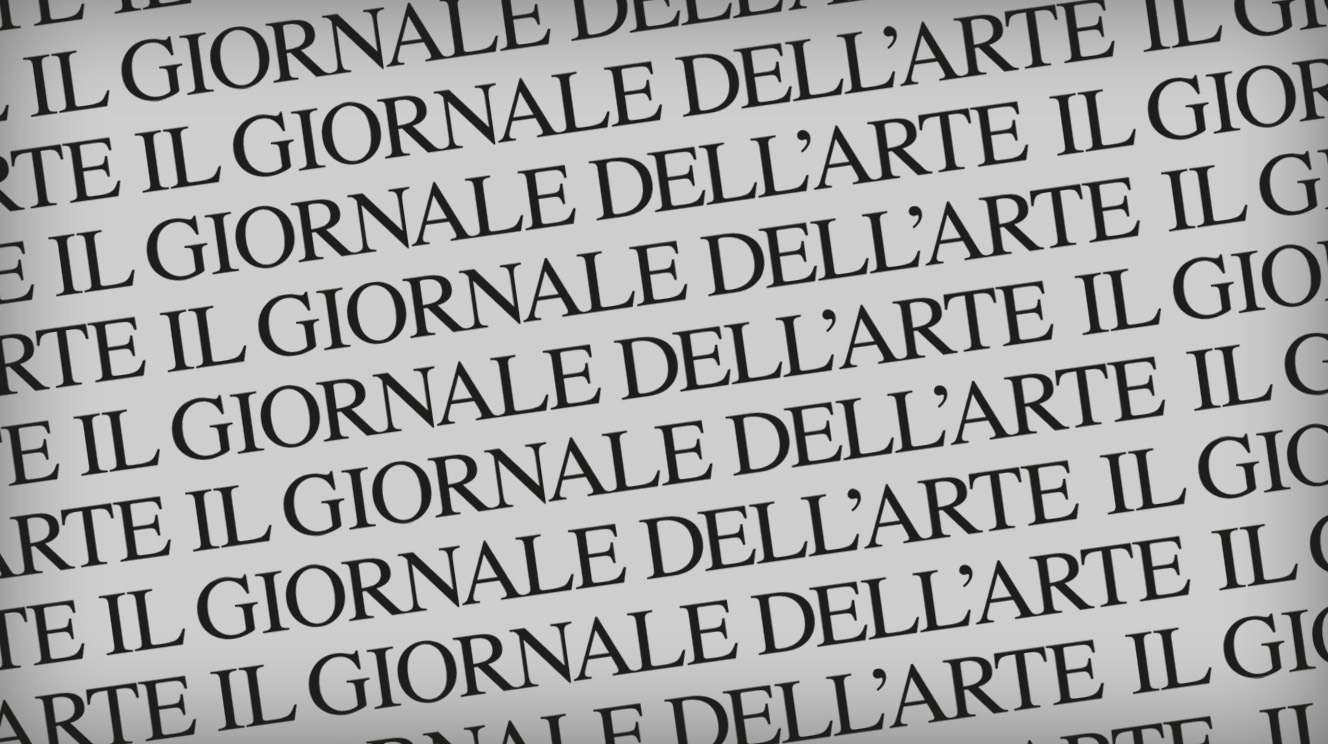Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Lidia Panzeri
Leggi i suoi articoli«Fattori», semplicemente, è il titolo della mostra in programma a Palazzo Zabarella dal 24 ottobre al 28 marzo (catalogo Marsilio). Ulteriore declinazione, ma non l’ultima si lascia intendere, di quella rivisitazione dell’arte dell’Ottocento che la Fondazione Bano persegue da una decina di anni. In mostra 122 capolavori, incluse le icone più note, come «In vedetta» e «La rotonda di Palmieri», ma anche molti inediti da collezioni private e 20 incisioni. La mostra è curata da Francesca Dini, Giuliano Matteucci e Fernando Mazzocca.
Abbiamo intervistato Francesca Dini, figlia d’arte (il padre è Piero Dini, con il quale nel 1997 ha curato il volume Giovanni Fattori: epistolario edito e inedito, Edizioni Il torchio) e autorevole interprete della pittura dell’Ottocento con particolare riguardo a quello toscano, che negli anni ha promosso anche come curatrice di mostre.
Fattori attraversa il movimento dei macchiaioli ma non ne è il caposcuola, ruolo assegnato a Telemaco Signorini. Perché?
Incidono vari motivi: il suo carattere un po’ schivo, oltre a motivi personali, ossia la sua preferenza per il clima di Livorno che, fino all’ultimo, sperava fosse favorevole alla guarigione della moglie Settimia Vannucci. Fattori matura l’esperienza della macchia ma poi, grazie anche alla sua longevità (Livorno, 1825-Firenze, 1908), la traghetta nell’arte del Novecento. Per questo il ruolo del caposcuola l’ha guadagnato ex post.
Venendo alla mostra, quale criterio espositivo si è scelto?
Non un criterio di generi, ma un accorpamento per stagioni poetiche. Si sono così individuate sei sezioni. Nella prima, «Il Risorgimento visto dalle retrovie e la dimensione domestica del ritratto», vi figura il «Campo italiano dopo la battaglia di Magenta» del 1862 di incerta classificazione (quadro di genere o soggetto storico?), che però consacrò Fattori come pittore di battaglie, anzi, per dirla alla Diego Angeli, l’unico pittore di battaglie degno di questo nome.
Dal Risorgimento al ritratto intimo. Non c’è contraddizione ?
No, se si considera che le due icone «In vedetta» e «La rotonda» condividono lo stesso punto di vista ribassato; la stessa capacità di sintetizzare lo spazio e una rappresentazione della figura un po’ sgrammaticata, che dissimula la sua grande cultura figurativa.
La seconda sezione è intitolata «Nella luce di Livorno. Una nuova idea di ritratto».
Il paesaggio come genere dominante, rappresentato dal vero nelle piccole tavolette che Fattori teneva dentro un armadio. C’è una nuova qualità del colore e un modo nuovo di approcciare le figure Ne sono un esempio «Le Macchiaiole», del 1867 che testimoniano la solennità del quotidiano.
Nella terza sezione «Buoi al carro. Nella pace di Castiglioncello» è determinante l’incontro con Giuseppe Abbati.
Che vuole indurlo all’uso del bianco, coinvolgendo in questa ricerca anche Boldini. Fattori però era più interessato alla dinamica. Nasce l’iconografia, più volte ripresa, del bove.
Nella quarta, «Muro bianco. Ritorno ai soggetti militari e ai ritratti» ci sono gli autoritratti.
Due in particolare: quello giovanile (aveva 29 anni) del 1854, in cui affiora la sua consapevolezza di essere pittore, e quello senile del 1894, in cui volta le spalle al cavalletto e rivolge lo sguardo verso il pubblico.
Poi subentra la delusione del «Risorgimento tradito e la fuga in Maremma».
Esemplificato, il primo, da due capolavori, ossia lo «Staffato», ambientato nella desolazione di una campagna fangosa, e ancor più il «Dimenticato», esposto alla Biennale del 1901. È una generazione mandata a morire, priva ormai di ideali.
L’ottimismo riaffiora nell’ultima sezione, intitolata a un famoso verso di Giosuè Carducci «Il divino del pian silenzio verde».
E, infatti, un quadro del 1904 si intitola «Pio bove», espressione di un mondo idilliaco a cui appartiene anche il «Carro rosso», un prestito eccezionale dalla Pinacoteca di Brera. Insieme a deliziosi ritratti di fanciulle come «La scolarina» del 1893. È l’approdo di Fattori alla nuova arte del Novecento.
La rivalutazione dei macchiaioli è ormai un fatto compiuto?
Sì, anche se noi studiosi siamo poco generosi con i pittori italiani, sottovalutando che i soldati ruvidi di Fattori nulla hanno da invidiare a Degas.
Questa rivalutazione è anche merito delle mostre di Palazzo Zabarella?
Assolutamente: per la serietà scientifica, per il prestigio e la disponibilità del committente, la Fondazione Bano è in grado di reperire anche opere rare; si può dire che c’è stato uno «spreco» di capolavori.
Altri articoli dell'autore
Nella Collezione Peggy Guggenheim sculture, dipinti, disegni e performance della figlia di Umbro Apollonio, dimenticata protagonista dell’Arte optical e cinetica
Il restauro si concluderà nel 2027, con un preventivo di spesa di 6,7 milioni di euro. Da dicembre una nuova illuminazione della facciata
Ca’ Rezzonico-Museo del Settecento Veneziano espone 36 miniature su avorio dell’artista italiana più celebre nell’Europa del Settecento
Dopo un lungo oblio ritorna in Laguna, all’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, l’artista che dipinse una Venezia mondana e autentica