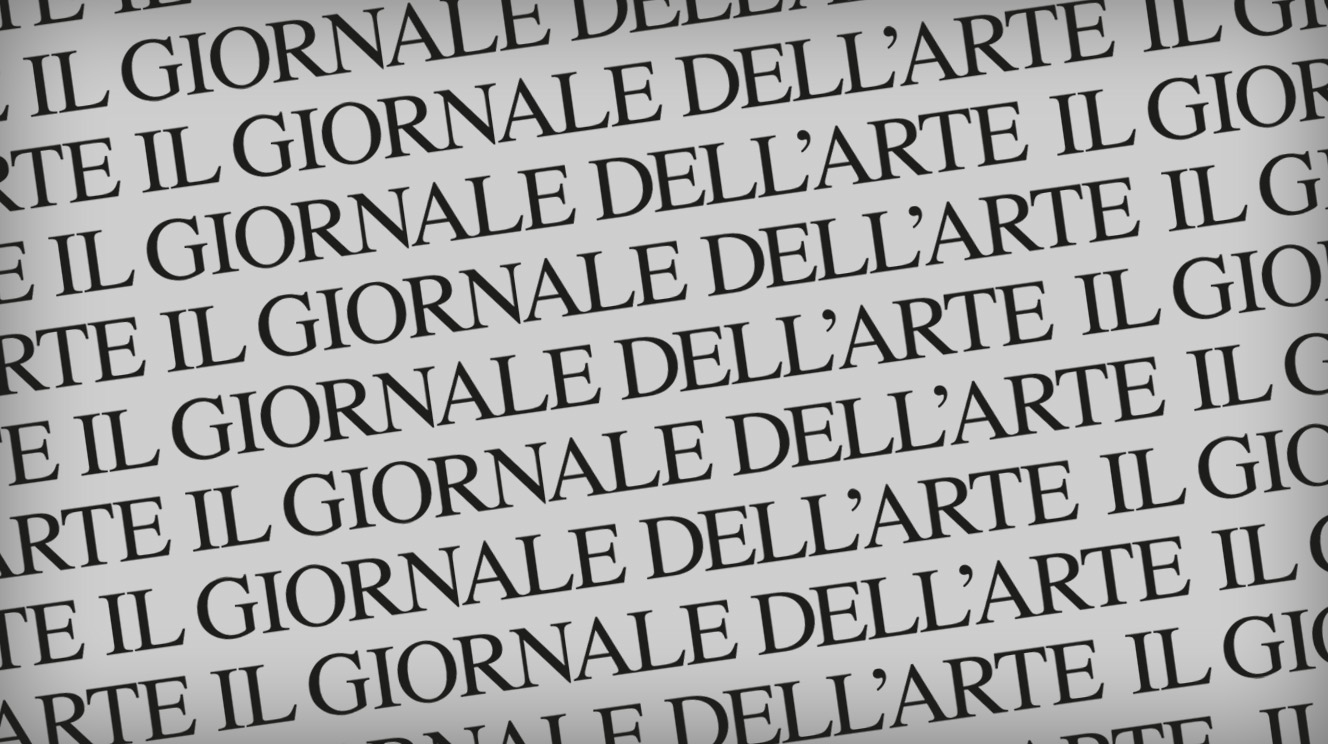Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Fabrizio Lemme
Leggi i suoi articoliL’anacronistica discrezionalità degli uffici esportazione nel rilascio degli attestati di libera circolazione
Negli anni Ottanta Milan Kundera pubblicò quello che è probabilmente il suo capolavoro, L’insostenibile leggerezza dell’essere. Non so perché ma quando l’amico Giovanni Pratesi mi invitò a partecipare a una tavola rotonda in Firenze il cui titolo era «Attestati di libera circolazione: insopportabile discrezionalità», il titolo del capolavoro di Kundera mi è tornato in mente e ho pensato che avesse ispirato anche gli ideatori del convegno. Comunque, ho aderito con entusiasmo e ho partecipato alla tavola rotonda, cui erano stati invitati Anna Palazzi (un legale di Terni che collabora nel mio studio alla materia del Diritto del Patrimonio culturale), Angelo Tartuferi e Angela Acordon (direttori degli Uffici esportazione rispettivamente di Firenze e di Genova), Federico Vannini Gandolfi (dell’Associazione Antiquari d’Italia) e Francesco Ferri (direttore della Fracassi World Wilde Shipping di Firenze). Moderatore, l’antiquario Fabrizio Guidi Bruscoli. Dico subito che da molti anni, parafrasando il famoso discorso di Vittorio Emanuele II al Parlamento subalpino del 1859, «non sono insensibile al grido di dolore che da ogni parte d’Italia si leva», nel mondo antiquario, a doglianza di una discrezionalità talmente lata degli Uffici esportazione, da sconfinare nell’irrazionalità e nell’arbitrio. Autentici capolavori dell’arte italiana ottengono l’attestato di libera circolazione, magari per finire in importantissimi musei stranieri; opere di dubbia qualità, di riconosciuta ripetitività, di modesta e artigianale fattura, sono viceversa vincolate, magari con il vincolo di indivisibilità (il più rigoroso esistente in Italia), in assoluta incoerenza con l’inconsueto liberismo che ha animato l’Ufficio nell’esame di veri capisaldi dell’arte italiana.
Io non ho nulla in contrario a quel liberismo del quale ho parlato: ritengo anzi che l’uscita di testimonianze anche significative della figuratività italiana sia di indubbio giovamento per l’immagine internazionale della stessa e sono convinto, pertanto, che la presenza di tali testimonianze nei musei stranieri, quali ambasciatori della nostra cultura, vada promossa e incoraggiata, limitando il vincolo ai soli «tesori nazionali», ossia agli insopprimibili documenti della nostra identità nazionale. Ma l’incoerenza e l’assenza di qualsiasi razionalità mi arrecano profondo fastidio, come ogni manifestazione del potere avanti alla quale il cittadino non sia tale ma semplice «suddito». Il «grido di dolore», come ho già detto, non mi lascia insensibile ma rilevo l’assoluta inutilità del lamento: non serve a nulla piangersi addosso e chiedere la compassione. Bisogna passare a una fase più costruttiva: una fase di proposte concrete, volte, se non a eliminare, almeno ad attenuare con adeguati rimedi l’arbitrio del Principe.
Nella mia relazione introduttiva, pertanto, dopo aver illustrato gli artt. 35 e successivi della fondamentale legge 1° giugno 1939 n. 1089 (la cosiddetta Legge Bottai), il cui impianto resta sostanzialmente inalterato anche nel diritto vigente (artt. 68 e ss. D. Lgs. 42/04), ho dettagliatamente esaminato le direttive generali in materia, espresse nella circolare 13.5.1974 del Ministero della Pubblica Istruzione-Direzione Generale Antichità e Belle Arti, che recepiscono il parere reso in seduta congiunta dalla I e II Sezione del Consiglio Superiore delle Antichità e Belle Arti il 10 gennaio 1974. Ho quindi messo in evidenza come tale circolare, nonostante specifichi molti criteri di riferimento (il pregio d’arte, la rarità anche iconologica, le qualità tecniche, le difficoltà di ulteriori acquisizioni per le cose «originarie di altra Nazione»), lascia agli Uffici esportazione un ampio, insopprimibile margine di discrezionalità. Conseguentemente, per evitare gli arbitri (sempre possibili quando la discrezionalità del «Principe» si possa liberamente esplicare) ho indicato l’unico rimedio a mio avviso ipotizzabile: il ricorso gerarchico, nel quale è possibile sindacare il provvedimento negativo non solo nella legittimità (ad esempio insufficiente o contraddittoria motivazione) ma anche nel merito (ad esempio l’opera di cui si chiede l’esportazione non ha effettivo interesse nella tutela del patrimonio culturale), non debba essere deciso dal competente direttore generale (com’è attualmente). Quest’ultimo infatti è necessariamente portato a confermare un provvedimento negativo adottato da un organo, certo di grado a lui inferiore ma pur sempre appartenente a quella stessa Amministrazione che vede al vertice lo stesso direttore generale.
Ho quindi suggerito di demandare la soluzione dei ricorsi gerarchici a un organo del contenzioso amministrativo (che non è giudice speciale), costituito da tre membri: uno nominato dal Consiglio Superiore dei Beni culturali, un altro dai sindacati di categoria, il terzo, presidente, dai primi due d’accordo tra loro o, in difetto, dal presidente del Consiglio di Stato. In tal modo il ricorso gerarchico avrebbe una funzione di tutela effettiva e non di tutela meramente nominale: tutela a volte addirittura platealmente soppressa dalla stessa Direzione generale chiamata a decidere, che, non rispondendo nel termine di rito di novanta giorni dalla presentazione del ricorso, determina la formazione del «silenzio-rigetto» e quindi la vanificazione nei fatti dell’unico rimedio che consenta il sindacato di merito. La soluzione proposta può essere introdotta nel nostro ordinamento giuridico solo per via di legge ordinaria (art. 97 Cost.) e quindi ho auspicato che i sindacati di categoria si astengano in futuro da una politica, del tutto inascoltata, di mero lamento e intervengano trovando parlamentari effettivamente disposti a sostenere la modificazione suggerita.
Questa, in sintesi, la mia proposta. Se i sindacati di categoria del mondo antiquariale la accoglieranno, un organo effettivamente imparziale potrà assicurare la razionalità invece dell’arbitrio. Se non la accoglieranno, limitandosi, come è purtroppo da alcuni anni la regola, al mugugno e al lamento, si assumano la responsabilità di simile colpevole inerzia.
Altri articoli dell'autore
I beni culturali possono essere dichiarati di particolare interesse solo se la loro esecuzione risalga ad almeno cinquant’anni
La capacità (e l’obbligo) di correggersi della Pubblica Amministrazione
Va introdotta una distinzione tra ricerca significativa e ricerca inutile: la prima aggiunge qualcosa alle conoscenze già acquisite, la seconda si limita a riproporre il «déjà dit»
Il conflitto tra Russia e Ucraina mette in luce un relativismo che parte da Giovanni Battista Vico