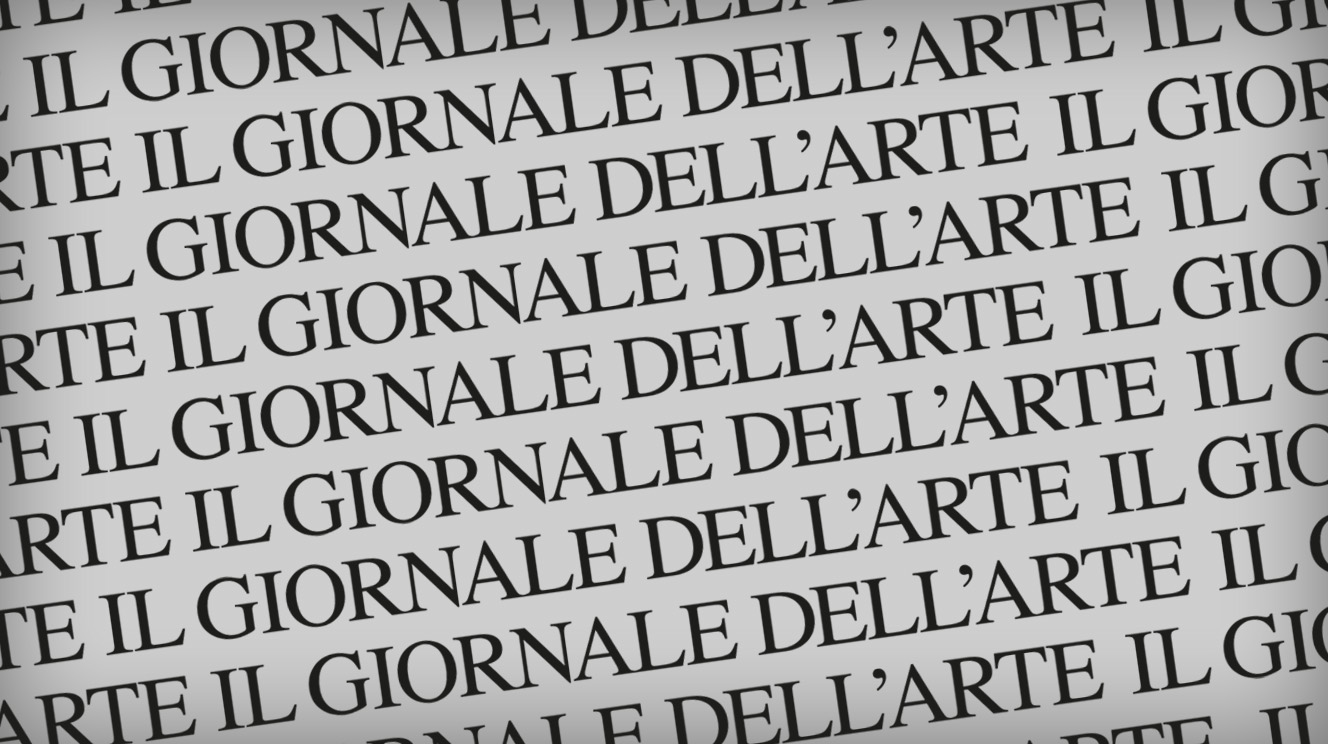Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Stefano Miliani
Leggi i suoi articoli«L’archeologia è fatta di scelte. Negli scavi non tutto va conservato e mostrato. È bene lasciare a vista solo ciò che è valorizzabile e comprensibile perché la manutenzione costa molto; già fatichiamo a conservare in modo decente quello che abbiamo».
A pronunciarsi così è Luigi Malnati che, dallo scorso autunno, è tornato a coprire un incarico già avuto in passato: quello di soprintendente per i Beni archeologici delle Marche. Nato nel 1953, con un vasto curriculum che lo ha visto direttore generale per le antichità al ministero, soprintendente in Veneto, in Emilia-Romagna, ad interim in Lombardia, non gli dispiacerebbe concludere la carriera nella terra marchigiana. Della riorganizzazione del ministero non parla: «Dico solo che abbiamo avuto troppe riforme con il personale che è invecchiato».

Dottor Malnati, in autunno la stampa aveva paventato il rischio che i musei archeologici delle Marche potessero chiudere perché non c’erano soldi per le bollette.
Non hanno rischiato di chiudere, ma il problema della gestione ordinaria è endemico un po’ dappertutto.
Nella pubblica opinione e nei mass media si pensa agli archeologi soprattutto quando ci sono di mezzo lavori urbani.
Tre anni fa promossi a Paestum gli stati generali dell’archeologia e furono calcolati 6mila scavi d’emergenza e archeologia preventiva contro 600 di ricerca. Il rapporto quindi era di uno a dieci. Nelle Marche basti ricordare che a Cupra Marittima è venuta fuori una domus romana, a Urbino i lavori di arrivo di una funicolare hanno rivelato una stratigrafia importante, a Pesaro il cantiere per un parcheggio ha fatto emergere ritrovamenti anche d’epoca preromana. Sull’archeologia preventiva, estesa ai privati dalla Convenzione della Valletta, le amministrazioni marchigiane sono piuttosto all’avanguardia.
Una volta trovati i reperti, che cosa farne?
Se non si restaurano, non si pubblicano e non si espongono, allora è inutile aver scavato. Non basta prevedere l’archeologia preventiva pubblica, bisogna pensare ai finanziamenti per renderla effettiva. Quando ero direttore generale alle antichità previdi in una circolare che la committenza pubblica valorizzasse lo scavo o i ritrovamenti.
Per le soprintendenze la carenza di personale tecnico resta. Nella sua soprintendenza come va?
Il depauperamento riguarda tutti i ruoli intermedi: anche i geometri, gli amministrativi, i restauratori, i disegnatori. Non abbiamo neanche l’auto di servizio per andare nei posti che non sono serviti da mezzi pubblici: penso a luoghi nell’Appennino dove ci sono rinvenimenti preistorici, a zone dei Piceni… Nel 1994 questa soprintendenza aveva un pulmino e due auto d’ufficio, ora ha un’auto in leasing e senza autista. Non la si usa certo per fare la spesa: molti siti fuori mano sono irraggiungibili con il pullman o con il treno. Così non si fa tutela.
Che cosa vorrebbe?
Le soprintendenze devono avere gli strumenti come la Protezione civile o la Polizia. Ci trattano come se avessimo avuto auto di rappresentanza, ma non sono blu e nemmeno grigie. A dei funzionari capita di dover chiedere un passaggio ai responsabili dei cantieri.
Mario Torelli, sul nostro giornale, ha stigmatizzato i tempi lentissimi con cui certi archeologi pubblicano gli esiti dei ritrovamenti o tengono scavi in sospeso.
È vero, molti titolari di scavi non pubblicano. Ma le soprintendenze oltre alla carenza di personale hanno un carico enorme di burocrazia da affrontare. Non vale per i docenti universitari che fanno scavi in concessione e pubblicano solo dopo anni volumi ponderosi. Comunque non tutto va reso visibile. Lasciare buchi aperti che si ridurranno a immondezzaio è sbagliato. Se non si può valorizzare allora è meglio interrare che si conserva meglio. Vanno fatte delle scelte. Che sono difficili e, per questo, in passato molti archeologi non sceglievano. Ma quello che più temo è la tutela rigida sul piano teorico e lassista in pratica.
A che cosa si riferisce?
Temo che una tutela rigida sul piano conservativo ci faccia tornare a trent’anni fa, quando non ci chiamavano proprio, non ricevevamo più segnalazioni. Fermare dei lavori con i reperti già distrutti potrà portare a denunce, ma il bene resterà perduto.
Quanti sono gli archeologi professionisti in Italia?
Circa duemila, visti come Indiana Jones o come dei rompiscatole. Non siamo né l’uno né l’altro: siamo professionisti che lavorano con fatica quotidiana per ricostruire e conservare le testimonianze di una civiltà.
Altri articoli dell'autore
Nuova pavimentazione, nuovi lampioni e una nuova, contestata pensilina: i lavori, costati 7,5 milioni, scatenano discussioni e malumori
Nella Rocca Albornoz e a Palazzo Eroli, a Narni, una settantina di sculture di uno dei maestri del Nouveau Réalisme per riflettere sul rapporto tra alto artigianato e creazione artistica
Il 6 aprile avrà luogo una commemorazione in ricordo delle 309 vittime del terremoto del 2009. Diamo conto della condizione di alcuni monumenti: il Castello spagnolo, le mura urbiche presso porta Brinconia, la Chiesa di San Marco e Palazzo Centi
La «culla» del francescanesimo era a rischio in quanto la soprastante cupola della Basilica di Santa Maria degli Angeli era preoccupantemente fessurata dal terremoto del 2016