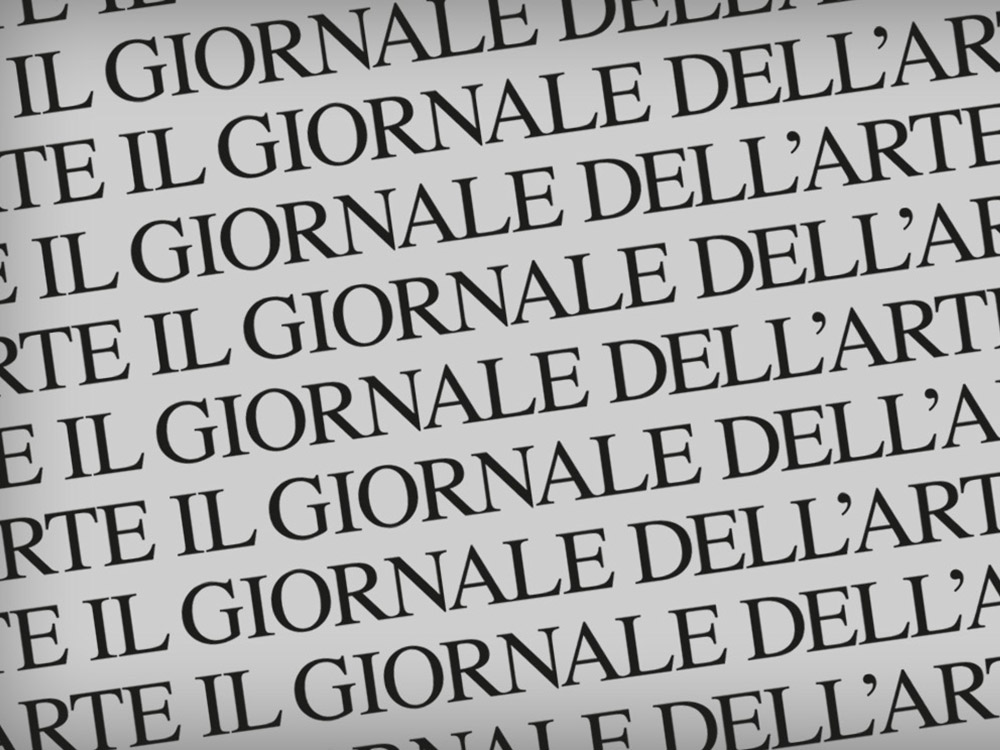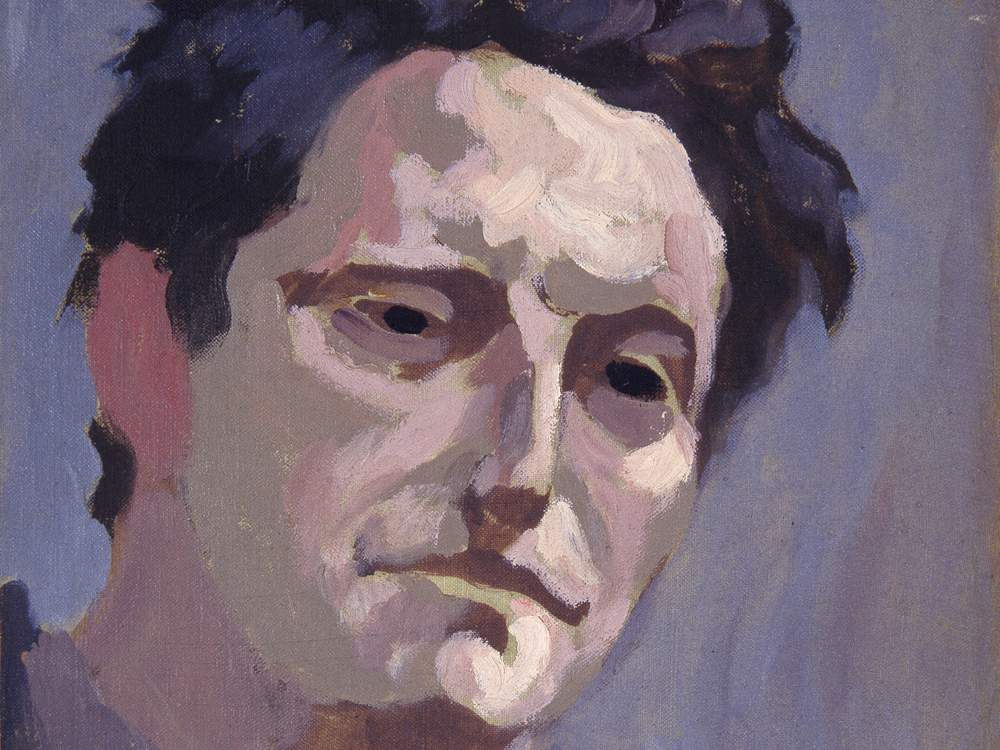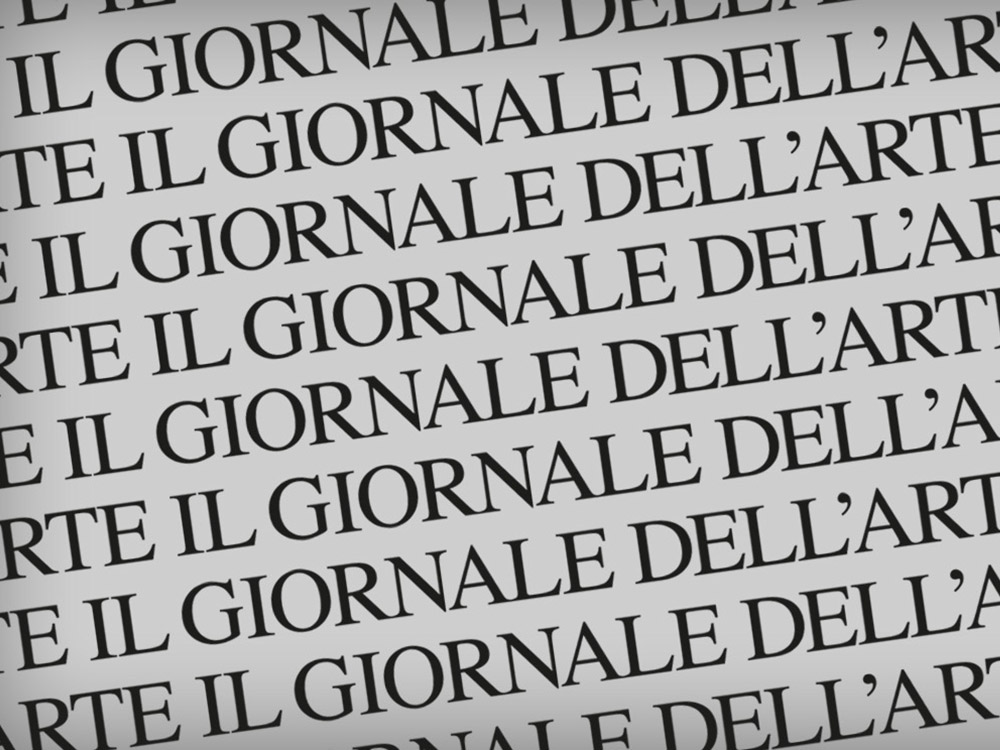Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Daniela Fonti
Leggi i suoi articoliRoma. Ai primi di maggio il Comando dei Carabinieri per la Tutela del patrimonio artistico celebra, con legittimo orgoglio, il suo trentennale di attività. Forse i decenni passati ce l'hanno fatto dimenticare, ma dobbiamo a loro, ai Carabinieri, se opere come «La Flagellazione» o la «Madonna di Senigallia» di Piero della Francesca, o ancora «La Muta» di Raffaello sono ancora nei nostri musei. Dal trafugamento della «Natività» di Caravaggio, rubata dalla chiesa di San Lorenzo a Palermo proprio in quell'anno 1969 alla vigilia dell'istituzione del reparto speciale dell'Arma, fino al 1998 che è stato teatro del clamoroso furto (e ritrovamento) dei van Gogh («L'Arlesienne» e «II Giardiniere») e del Cézanne («Le Cabanon de Jourdan») della Galleria Nazionale d'Arte Moderna, è profondamente cambiata la fisionomia delle aggressioni al patrimonio artistico (pubblico o privato, come nazionale o internazionale), e insieme sono cambiati i sistemi operativi del Comando. Ne parliamo con il generale Roberto Conforti che lo dirige.
Generale Conforti, dai dati che avete diffuso, sembra che sia profondamente cambiata la fisionomia dei furti d'arte in Italia: il 50% in meno di denunce (2.929 nel primo bimestre di quest'anno contro le 5.827 del corrispondente periodo del '98) e un grande numero di ritrovamenti (dal 1978 al 1998 sono stati recuperati ben 326.715 reperti archeologici e 160.356 oggetti d'arte). È cambiato dunque negli ultimi trent'anni anche il modello operativo del Comando?
La nostra attività si è estesa e si è modificata in modo proporzionale all'accrescersi dell'aggressione al patrimonio artistico. Bisogna intanto premettere che l'Italia è stata il primo Paese del mondo a dotarsi di una struttura specifica per il recupero del patrimonio artistico trafugato (un anno prima della Convenzione Unesco emanata a Parigi nel 1970) e che solo successivamente, sulla base della nostra esperienza, le altre nazioni hanno fatto qualcosa di simile. Possiamo dire con orgoglio che siamo un punto di riferimento internazionale in questo settore, così come lo è la nostra Banca Dati che è considerata fra le più ricche e tecnologicamente avanzate al mondo. Vi sono inseriti dati relativi ai 600mila oggetti d'arte trafugati in questi anni in Italia come all'estero (l'Italia è infatti esportatore ma anche importatore d'illeciti), un indispensabile supporto operativo alle nostre operazioni investigative. Infatti bisogna ricordare che il Comando agisce non solo su scala nazionale e che dal 1970 ad oggi sono state recuperate all'estero ben 7.581 opere d'arte (mentre sono 1.108 quelle rubate all'estero e recuperate in Italia).
Come è cambiato in questi anni il coinvolgimento della criminalità in questo settore? È vero che il mercato illecito sempre di più è diventato un campo d'azione della mafia e della camorra?
Si è passati in ambito nazionale da fenomeni di microcriminalità diffusa di tipo «artigianale» (quella di chi operava senza una particolare attenzione al valore dei beni trafugati) all'impegno criminale, assai più competente, delle grandi organizzazioni. Negli anni passati queste organizzazioni sono entrate nel mercato dell'arte riciclandovi denaro sporco proveniente da altre attività criminose. Inoltre l'abbattimento delle barriere doganali ha favorito la connessione internazionale fra gruppi diversi e creato nuovi sodalizi extra nazionali. Se si pensa al fatto che la movimentazione illecita di opere d'arte frutta proventi per miliardi inferiori solo a quelli del traffico di stupefacenti si avrà un 'idea dell'interesse riservato a questo settore dalla grande criminalità organizzata.
Dunque l'abbattimento delle frontiere nazionali ha favorito le attività illecite, come si temeva.
Certamente, e il fatto che oggi sia il Piemonte, una regione di frontiera, la più esposta in Italia alle aggressioni delinquenziali ne è la prova lampante.
Dal punto di vista della tipologia dei beni trafugati, possiamo dire che ancora oggi sia l'archeologia il settore più tartassato dai furti d'arte? L'archeologia detiene tuttora la leadership nell'ambito delle opere trafugate e ancora una volta sono le cifre a confermarcelo: a fronte dei più di 300mila oggetti archeologici recuperati stanno le svariate migliaia che ogni giorno intercettiamo sul mercato internazionale: oggetti la cui sparizione non è stata denunciata perché sono il bottino di un'ininterrotta attività di scavi clandestini condotti nella nostra immensa area archeologica terrestre e marina. Di questi oggetti noi (e la comunità scientifica) veniamo a conoscenza solo quando compaiono sul mercato clandestino.
La vulnerabilità delle raccolte pubbliche (anche religiose) può dirsi diminuita rispetto al periodo nel quale avete iniziato la vostra attività di contrasto?
Certamente sì e di molto. Si va dai 30 furti a danno dei musei denunciati nel 1992 ai 14 di oggi, e quasi sempre dì oggetti dal valore non rilevante. Questo si deve soprattutto all'impegno non indifferente anche in termini economici profuso dal Ministero per i Beni e le attività culturali per attivare misure di sicurezza nei musei e qualificare il suo personale di custodia.
Ancora nel 1995 lei raccomandava ai collezionisti, anche attraverso il nostro Giornale, di conservare sempre una foto delle opere di proprietà per agevolare il lavoro investigativo dell'Arma in caso di furto. Questa raccomandazione è ancora valida?
Sì, perché ancora oggi è troppo bassa la percentuale di opere d'arte fotografate rispetto a quelle delle quali manca una documentazione visiva: siamo al 50% circa ed è troppo poco. Poiché l'esperienza c'insegna che un 'opera d'arte fotografata viene recuperata, in caso di furto, nell'80% dei casi, è evidente il valore dì quella mia raccomandazione.
Dal 1993 il Comando ha attivato una «sezione falsi» comandata dal maresciallo Alessandro Giombetti perché siete passati ad occuparvi, in modo distinto, delle falsificazioni?
Lo abbiamo fatto in relazione a un fenomeno di grande rilevanza qual è quello dell'aumento della falsificazione soprattutto di opere d'arte contemporanea. Purtroppo in un momento di recessione economica i falsi abbondano anche perché la nostra legislazione che è la più chiara in campo internazionale, malgrado preveda interventi anche energici, non si dimostra abbastanza dissuasiva. Nonostante sia alto il numero delle opere supposte false messe sotto sequestro, sono ancora oggi pochissimi i procedimenti che vanno a compimento, anche per una non conoscenza di questo delicato settore da parte della magistratura giudicante. Così molto spesso, anche in caso di condanna, i processi durano così tanto che interviene la prescrizione. Decisamente è questo un settore nel quale c'è molto da fare, anche da parte nostra.
Generale, in trent'anni di attività moltissime cose sono state recuperate ma molte risultano ancora mancare all'appello. Quali illustri autori figurano in cima a questo ideale Gotha dei «sequestrati»?
Certamente il Caravaggio della «Natività», ormai da trent'anni latitante, poi il «Bambino» dell'Ara Coeli, rubato a Roma nel 1994, poi ancora la splendida «Madonna col Bambino» del Bellini trafugata a Venezia dalla chiesa della Madonna dell'Orto nel 1993, e altre illustri vittime. E i nostri pur rilevanti successi non bastano a consolarci di queste perdite che ci ostiniamo a ritenere temporanee.
Altri articoli dell'autore
Guttuso definì la produzione artistica dello scrittore-pittore torinese «assai nota ma poco conosciuta». Lo celebrano quattro mostre, per confermare la sua statura di vero interlocutore dell’arte europea del ’900
Aggiornati gli studi di Maurizio Fagiolo sul Novecento italiano