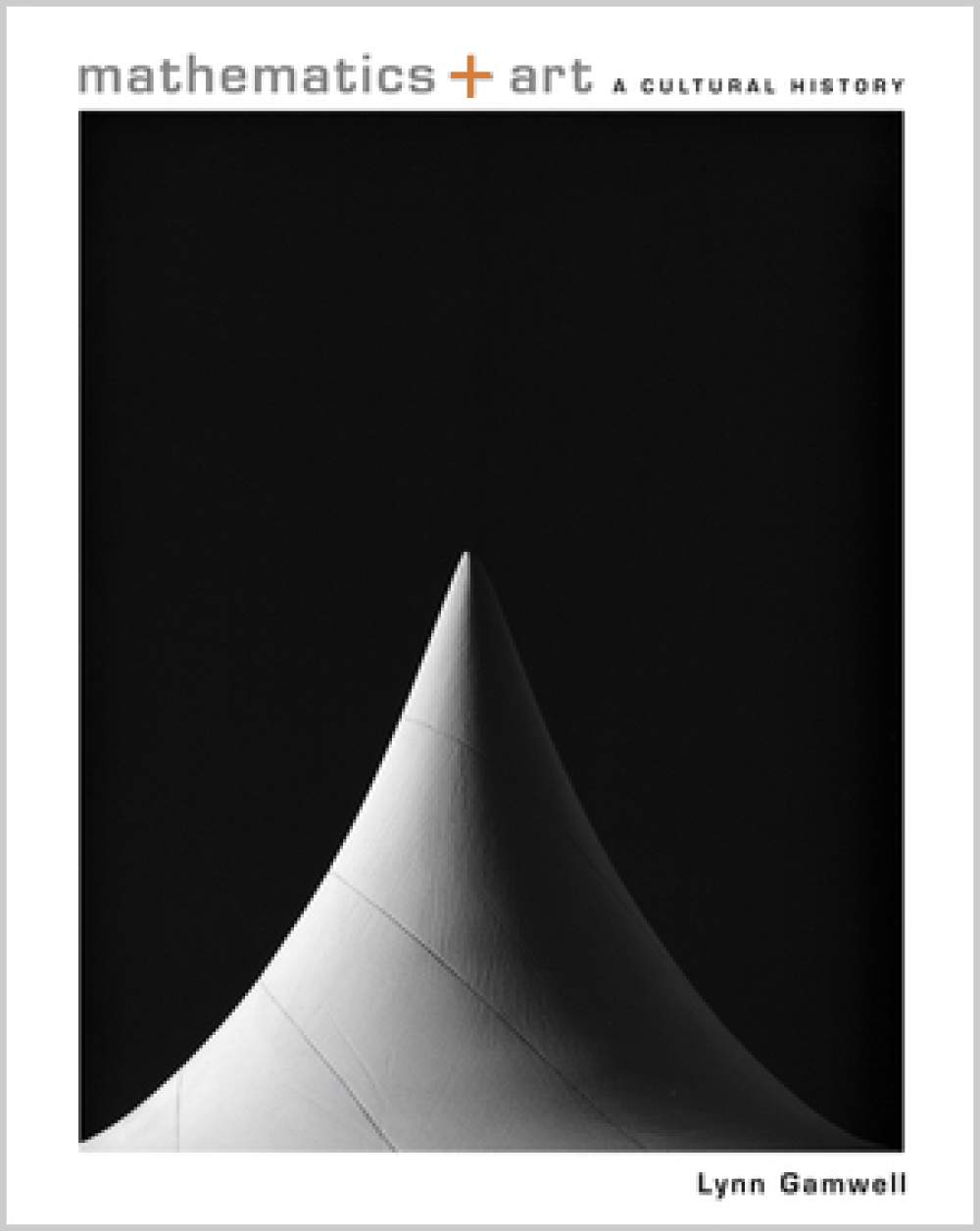Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Loretta Vandi, Pavlos Jerenis
Leggi i suoi articoliIl libro di Lynn Gamwell contiene più di quanto il titolo Mathematics + Art non lasci intendere. Il primo termine, in aggiunta a geometria, aritmetica (teoria dei numeri) e algebra, comprende logica matematica e filosofia del linguaggio, mentre il secondo si riferisce sia all’arte che alla storia dell’arte e all’estetica. Il sottotitolo, A Cultural History, allude a un ampliamento dei contenuti focalizzando l’attenzione sul «formalismo» sia nell’arte stessa che nella storia dell’arte, presentando criticamente l’arte minimalista americana e le discussioni sorte come risposta ad essa.
Il testo presenta più narrazioni storiche che investigano non tanto l’influenza diretta delle matematiche sull’arte quanto il loro impiego da parte di singoli artisti all’interno di «movimenti» e come cemento di questi: Suprematismo e Costruttivismo in Russia (El Lissitsky e Malevic) in rapporto alla teoria degli insiemi di Cantor e al formalismo linguistico; De Stijl (Mondrian e van Doesburg) e intuizionismo brouweriano; Arte concreta in Svizzera (Max Bill) e teoria dei gruppi (Andreas Speiser), fatte tutte confluire nel Bauhaus di Gropius e, infine, Minimalismo americano.
Riferendoci in particolare alla terza narrazione, senza mettere in dubbio la connessione storica tra l’Arte concreta e Andreas Speiser, siamo del parere che occorra distinguere tra il fatto evidente che le simmetrie possano essere descritte dalla teoria dei gruppi e la supposizione, difficilmente sostenibile, dell’esistenza di un filo storico che collega la costruzione delle prime (e, di conseguenza, l’impiego degli algoritmi nell’arte antica, medievale o anche rinascimentale) allo sviluppo moderno della seconda.
Il libro contiene anche diverse narrazioni minori come quella sulla «meta arte». Qui l’autrice prova con alterna fortuna a far collimare una interpretazione del noto brano sul «silenzio» di Ludwig Wittgenstein (ignorando il lavoro della Elizabeth Anscombe sul Tractatus) come se accennasse all’argomento della gerarchia dei linguaggi (di solito attribuito ad Alfred Tarski) con le celebri dimostrazioni di Gödel dell’incompletezza di ogni sistema assiomatico (ricordiamo che solo l’aritmetica è affetta dall’incompletezza e non la geometria e l’algebra) per, poi, mettere entrambi in vago rapporto con Giorgio de Chirico e René Magritte. Riguardo a De Chirico, l’autrice suggerisce che l’artista, poiché leggeva un libro di Giovanni Papini su vari filosofi, aveva un interesse per la filosofia. Chi in Italia si dedicò seriamente alla filosofia del linguaggio fu comunque il brillante e sfortunato Giovanni Vailati, all’inizio assistente di Giuseppe Peano a Torino, piuttosto che Papini. Non risulta invece che De Chirico leggesse i saggi di Vailati, molti pubblicati sulla rivista «Leonardo» diretta da Papini stesso.
In conclusione, Lynn Gamwell ha esemplarmente proposto un formalismo che non sia «meaning-free» e, a nostro avviso, il suo libro andrebbe letto non solo da professionisti e studenti di arte in generale (a cui sembra rivolto) ma anche da critici e storici dell’arte moderna.
Mathematics + Art. A Cultural History, di Lynn Gamwell, 558 pp., ill. col. e b/n, Princeton University Press, Princeton-Oxford 2016, $ 49,50