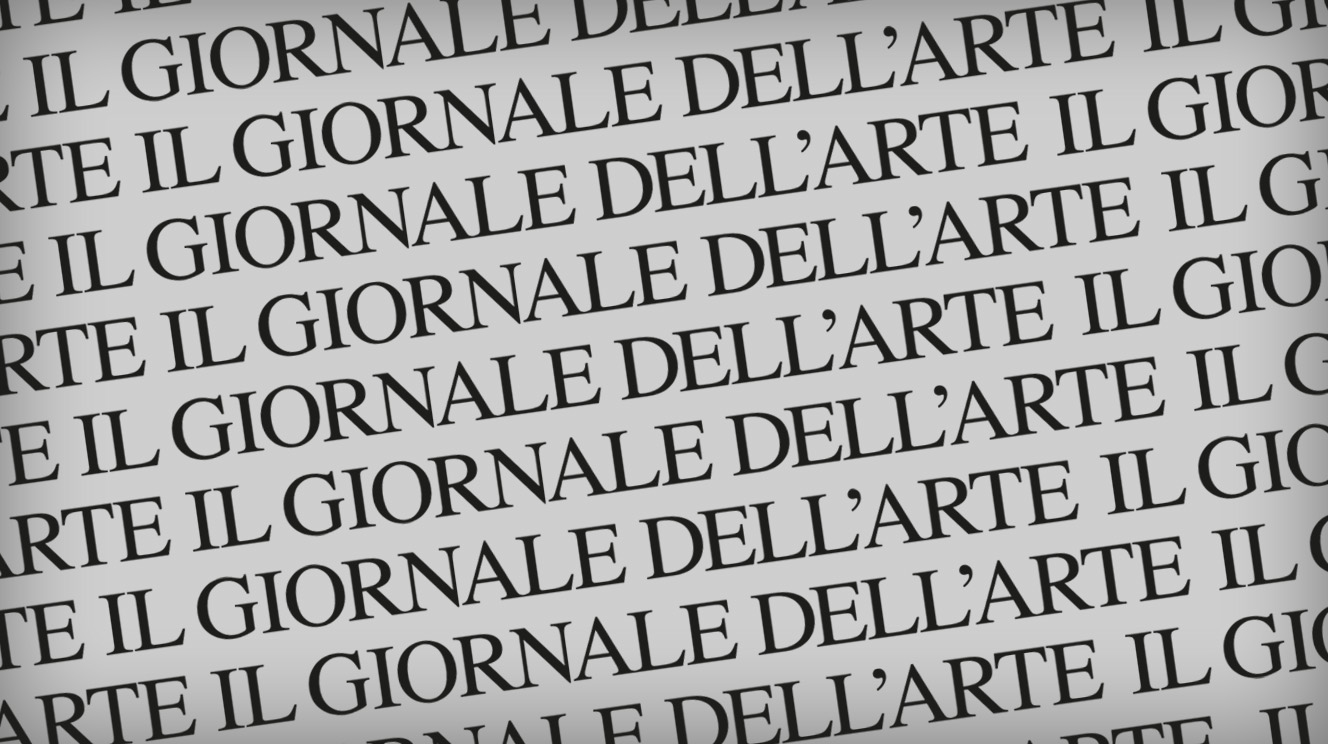Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Fabrizio Lemme
Leggi i suoi articoliViene punito il mendacio nell’esportazione di beni culturali
L’articolo 66 della legge fondamentale 30 giugno 1939 n. 1089 (cosiddetta Legge Bottai dal nome del Ministro proponente) puniva, sia pure con la sola pena della multa, l’esportazione, anche soltanto tentata, di cose di interesse storico e artistico, in difetto di quella che allora si chiamava «licenza di esportazione». All’assenza di licenza di esportazione veniva parificata quella ottenuta «quando la cosa sia presentata con dichiarazione falsa o dolosamente equivoca, ovvero venga nascosta o frammista ad altri oggetti per sottrarla alla licenza di esportazione …».
La norma incriminatrice è stata una prima volta modificata con l’articolo 19 della Legge 1 marzo 1975 n. 44, che aveva introdotto, a fianco alla pena della multa, anche quella detentiva, della reclusione da uno a quattro anni.
Peraltro, intervenendo nuovamente sulla Legge Bottai per renderla coerente con la nuova normativa europea del 1992-93, il legislatore, con la legge 30 marzo 1998 n. 88, aveva soppresso l’ipotesi del mendacio, ritenendo ingiustificato punire l’esportazione clandestina assieme con l’esportazione mendace: ossia, parificare un reato di frontiera a un reato di frode.
Almeno in questi termini, come si ricava dai lavori parlamentari, si espresse il relatore, onorevole Giuliano Pisapia, penalista illustre e attuale sindaco di Milano.
L’articolo 123 del cosiddetto Testo Unico Melandri (d.lgs. 490/99) manteneva la norma incriminatrice sostanzialmente immutata, sia pure parificando all’illecita esportazione la mancata reimportazione di beni per i quali era stata ottenuta la temporanea esportazione. E sostanzialmente inalterata la norma incriminatrice è restata anche con l’articolo 174 del cosiddetto Codice dei Beni Culturali (d.lgs. 42/2004).
Pertanto, a partire dall’entrata in vigore della legge 88 del 1998 (apparsa sulla Gazzetta Ufficiale del 10 aprile 1998, essa è entrata in vigore il successivo 25 aprile, secondo l’ordinaria «vacatio legis»), l’ipotesi del mendacio all’esportazione, soppressa dal legislatore, non incontrerebbe più alcuna forma di punibilità in sede penale, per il cosiddetto fenomeno della «abolitio criminis». Recita infatti l’articolo 2 del Codice penale che «nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l’esecuzione e gli effetti penali». Quindi, se l’esportazione mendace è avvenuta nel tempo in cui la legge la puniva, la successiva modifica «a favore del reo» ha effetti retroattivi.
Una delle caratteristiche della pubblica accusa, in questo nostro travagliato Paese, è quella di non arrendersi mai, neppure di fronte all’evidenza: il mendacio all’esportazione, scacciato dalla porta, rientra dalla finestra. In che modo? Attraverso la normativa penale ordinaria in materia di falsità, che, all’articolo 479, punisce la falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici.
Si dice dalla pubblica accusa al riguardo:
- l’articolo 48 del codice penale prevede la non punibilità di un reato quando la sua realizzazione sia stata determinata dall’altrui inganno, con la specificazione, peraltro, che, in tal caso «del fatto commesso dalla persona ingannata risponde chi l’ha determinata a commetterlo»;
- pertanto, ingannando il pubblico ufficiale in sede di rilascio della licenza di esportazione (oggi si chiama «attestato di libera circolazione», ma la sostanza non cambia), il privato si rende responsabile del reato di falso da lui commesso.
- nonostante la soppressione dell’ipotesi delittuosa di mendacio, sussista tuttora un obbligo del privato di dire la verità in sede di rilascio della licenza di esportazione, estendendo addirittura tale obbligo anche alla comunicazione di pareri attributivi rilasciati da studiosi (!).
- Tale licenza (rectius, attestato di libera circolazione) sia destinato a provare la verità in ordine al bene culturale del quale viene autorizzata l’esportazione.
La prima: in sede di rilascio dell’attestato di libera circolazione, il privato deve soltanto descrivere la consistenza fisica dell’opera (ad esempio, olio su tela, cm. 100x70) e il valore economico che gli viene attribuito e che può non coincidere con il valore commerciale. Quest’ultima indicazione, infatti, serve solo a radicare il potere della pubblica amministrazione di acquistare il bene al valore dichiarato.
Nulla dice la normativa sull’esportazione in ordine a un preteso obbligo del privato di specificare, anche se cognito, l’autore dell’opera: sono i funzionari dell’ufficio, di altissima, specifica competenza, che debbono determinare a chi sia riferibile il bene da esportare.
Né un tale obbligo, in assenza di una specifica previsione, può essere desunto anche se non esplicitato e ricavato quindi per analogia juris: infatti, gli articoli 1 codice penale, 14 preliminare e 25 Costituzione prevedono la punibilità solo in presenza di una specifica norma di legge e l’impossibilità dell’analogia «contra reum» ossia a sfavore dell’incolpato. Quindi, un obbligo penalmente sanzionato non può non formare oggetto di esplicita previsione normativa. Cade quindi il primo presupposto della rilevanza penale del mendacio (a cui è parificabile la reticenza, ossia il tacere circostanze cognite).
Ma anche il secondo non sussiste: è infatti semplicemente bizzarro ritenere che la licenza di esportazione sia destinata a provare il nome dell’autore di un’opera esportata. Affermare un simile paradosso sarebbe negare una realtà conosciuta a chiunque abbia una qualche dimestichezza, anche modesta, con la storia dell’arte: l’individuazione dell’autore di un’opera è infatti fondata su criteri talmente labili (i cosiddetti «dati morelliani di scrittura») da sfuggire a ogni certezza. Vi sono capolavori destinati a rimanere perennemente anonimi; vi sono opere museali che cambiano continuamente attribuzione, a seconda del progredire della scienza storico-artistica per effetto di nuove scoperte e di nuove emergenze.
Come si fa allora ad affermare che la licenza di esportazione possa vincolare in eterno una conoscenza in perenne divenire, quale l’attribuzione di un bene culturale? A chi si ostinasse a sostenere il contrario, si potrebbe rispondere citando Voltaire, che nella voce «verité» del Dictionnaire philosophique, esprime l’aurea massima «les vérités historiques ne sont que des probabilités».
Altri articoli dell'autore
I beni culturali possono essere dichiarati di particolare interesse solo se la loro esecuzione risalga ad almeno cinquant’anni
La capacità (e l’obbligo) di correggersi della Pubblica Amministrazione
Va introdotta una distinzione tra ricerca significativa e ricerca inutile: la prima aggiunge qualcosa alle conoscenze già acquisite, la seconda si limita a riproporre il «déjà dit»
Il conflitto tra Russia e Ucraina mette in luce un relativismo che parte da Giovanni Battista Vico