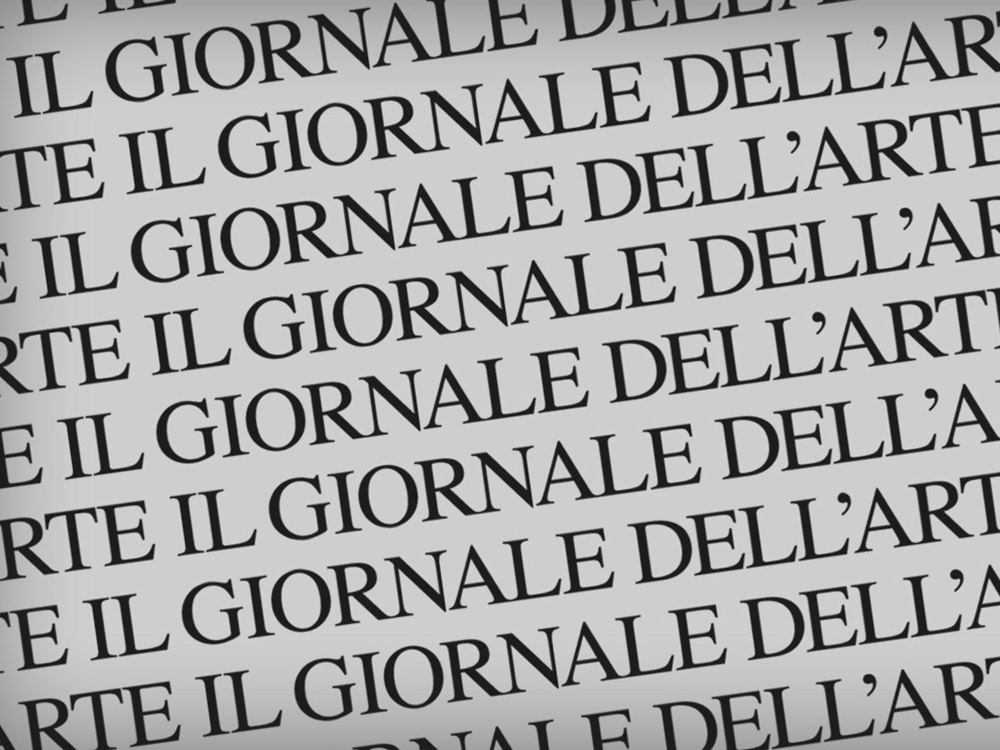Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Lidia Panzeri
Leggi i suoi articoliLa rivoluzionaria invenzione di Manuzio (e il contesto artistico) alle Gallerie dell’Accademia
«Aldo Manuzio. Il Rinascimento a Venezia», è l’attesa mostra che, già in programma lo scorso autunno in coincidenza con la ricorrenza dei 500 anni dalla morte del più celebre stampatore (1449-1515) di tutti i tempi, è allestita dal 19 marzo al 19 giugno alle Gallerie dell’Accademia (catalogo Marsilio). Il format è quello già sperimentato per la mostra di Pietro Bembo, a Padova nel 2013. Del resto i curatori sono gli stessi: Guido Beltramini e Davide Gasparotto, affiancati, per le Gallerie dell’Accademia, da Giulio Manieri Elia. Uguale è il periodo storico e culturale: il Rinascimento, in tutte le sue declinazioni, dalle premesse filosofiche alle ricadute artistiche. Certo il nodo centrale è costituito dalla rivoluzione tipografica di Aldo Manuzio, con l’invenzione del carattere corsivo e del formato in ottavo, quello tascabile, delle sue edizioni.
Sta di fatto che, grazie alle «aldine», si diffusero in tutta Europa e nel bacino del Mediterraneo i testi dei classici greci e latini, affiancati da quelli degli autori italiani del Trecento, come Petrarca e Boccaccio: la sintesi, e insieme il capolavoro, è l’Hypnerotomachia Poliphili (1499) corredato da fantasiose xilografie del miniatore Benedetto Bordon, a cui è dedicata una speciale sezione della mostra. L’altro protagonista nella diffusione del nuovo credo umanistico, peraltro attraversato dalle prime inquietudini di carattere religioso, è Erasmo Da Rotterdam, che per un anno, a Venezia, fu ospite dello stesso Manuzio.
Il nuovo clima culturale è decisivo anche per il rinnovamento delle arti, a cominciare da una nuova concezione della natura che raggiunge il suo apice nel paesaggio della «Tempesta» di Giorgione. L’iconografia classica trova la sua interpretazione nel «Doppio ritratto» in marmo di Tullio Lombardo; la ripresa della mitologia antica si esplica negli splendidi tondi «Il giudizio di Mida» (1505-10) ed «Endimione dormiente» (1505-10), entrambi di Cima da Conegliano e in prestito dalla Galleria Nazionale di Parma.
In un ambito filosofico sono da ascrivere le criptiche, allusive allegorie della malinconia» (altro tòpos della cultura umanistica), della virtù eroica, della calunnia e della verità di Giovanni Bellini, dalle collezioni delle stesse Gallerie dell’Accademia. I disegni di Tiziano, le incisioni di Giulio Campagnola e i bronzetti («Pastore che munge la capra Amaltea» dal Museo Nazionale del Bargello di Firenze) di Andrea Briosco completano il quadro per un totale di oltre 100 opere tra dipinti, sculture, incisioni, arte suntuaria e cartografie, e più di trenta rarissime edizioni stampate tra la fine del XV e i primi anni del XVI secolo.
Altri articoli dell'autore
Nella Collezione Peggy Guggenheim sculture, dipinti, disegni e performance della figlia di Umbro Apollonio, dimenticata protagonista dell’Arte optical e cinetica
Il restauro si concluderà nel 2027, con un preventivo di spesa di 6,7 milioni di euro. Da dicembre una nuova illuminazione della facciata
Ca’ Rezzonico-Museo del Settecento Veneziano espone 36 miniature su avorio dell’artista italiana più celebre nell’Europa del Settecento
Dopo un lungo oblio ritorna in Laguna, all’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, l’artista che dipinse una Venezia mondana e autentica