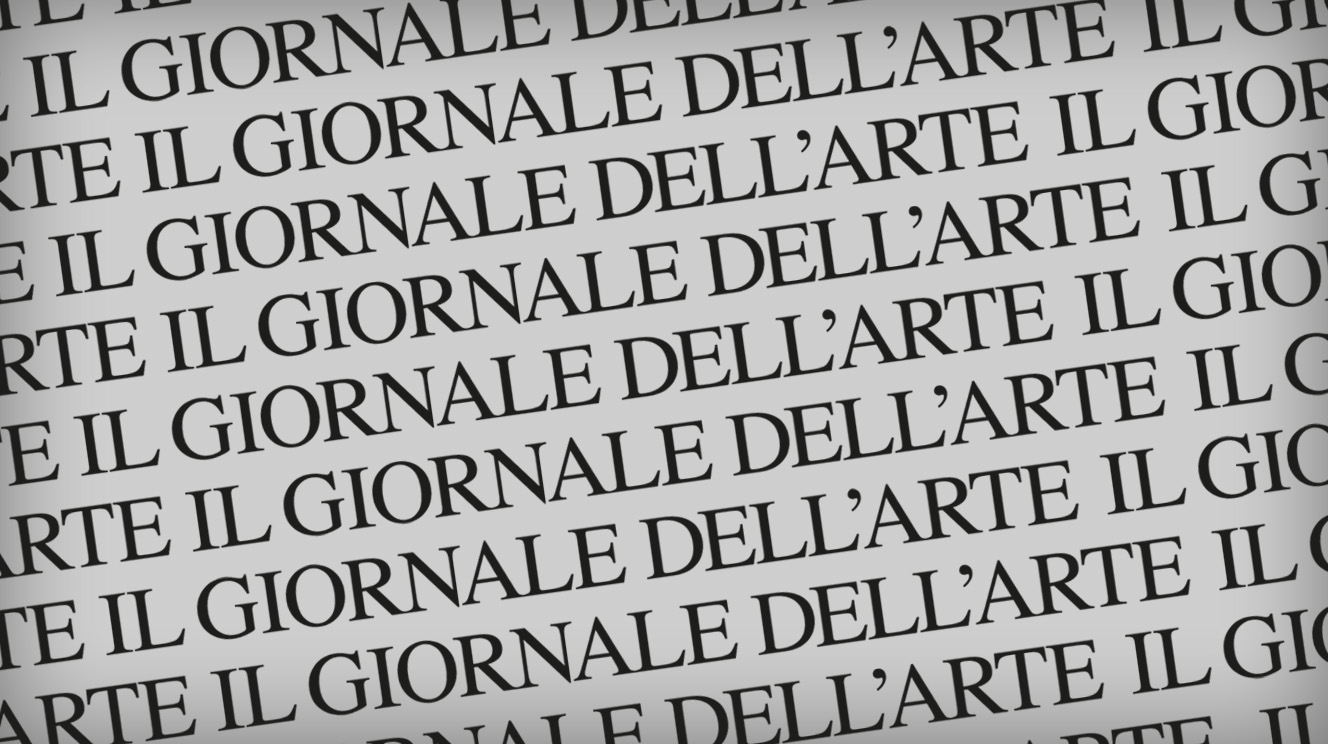Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Vittorio Sgarbi
Leggi i suoi articoliSembra incredibile che, mentre si vendono in America capolavori visti e riconosciuti da studiosi in Italia (mi riferisco al dipinto di Perin del Vaga, foto 6, venduto a un’asta Wannenes a Genova e poi acquistato dal Metropolitan Museum di New York dopo un’esportazione compiacente, e alla «Vergine orante» di Annibale Carracci, foto 1, ritrovata dall’antiquario Fiumicelli, periziata da Daniele Benati, e uscita, non si sa se legalmente, dall’Italia per essere venduta presso Christie’s a New York per un milione di dollari), i giornali non abbiano insistito a dar notizia del ritrovamento di una bufala, con valutazioni milionarie, messa sul mercato col nome di Leonardo, foto 7, e inseguita da finanzieri e carabinieri che hanno, evidentemente, tempo da perdere.
L’immonda ciofeca, che non meritava indagini della magistratura e dispiegamento di forze dell’ordine, era stata già denunciata da me dopo una prima pubblicazione su un giornale italiano. Non è stato sufficiente. Oggi si ripropone con il fascino di un mistero che non esiste, e con il giallo di una tresca che coinvolge una «nobile decaduta marchigiana e un ex camorrista».
Tutte balle, che meritano, ancora una volta, l’attenzione di Tomaso Montanari, con me già pronto a negare l’interesse dell’opera, ma altrettanto omertoso nel non denunciare lo scandalo vero dell’esportazione (legale o abusiva non importa) dell’Annibale Carracci, ignorando la notizia e proteggendo così il suo collega Daniele Benati. Il quale, dopo avere individuato l’opera e avere scritto, a pagamento, un’expertise, non si è preoccupato di conservarla in Italia, nonostante l’evidente collegamento con gli affreschi di Ludovico e Annibale Carracci in Palazzo Fava, affermando che «la “Madonna in preghiera” di Annibale Carracci è molto bella, ma non ritengo sia un’opera fondamentale per il patrimonio nazionale. Sono tantissime le opere di questo tipo che circolano in Europa e dovremmo prendere la penna in mano ogni giorno per difenderle». Bugie. E insiste, nonostante il clamoroso esito di quasi un milione di dollari all’asta americana: «In questo caso si tratta di un quadretto proveniente da una collezione privata. È molto bello ma Annibale Carracci ne fece diverse repliche». Falso.
La qualità dell’opera è evidente, e la sua fragranza pittorica è rara. Montanari tace. Preferisce occuparsi del finto Leonardo esportato clandestinamente solo per aumentarne l’inesistente appeal. In compenso cerca, arrampicandosi sugli specchi, di difendere un’operazione ancora più grave, da lui legittimata con una conferenza all’Accademia dei Lincei: «La Tavola Doria. Il ritorno di un grande capolavoro», foto 3.
Grande capolavoro la patacca Doria? Montanari sa benissimo che non è vero. E avendo legittimato un’operazione del costo di almeno 2 milioni di euro per recuperare un’opera del valore di non più di 2mila euro, è costretto a evocarne la inesistente «storia collezionistica eccezionale e il valore documentario» che ripagherebbero abbondantemente della mancata autografia. Ridicolo. La Tavola Doria è esattamente come il dipinto sequestrato in Svizzera dai finanzieri inviati dalla magistratura di Pesaro: una triste crosta di nessun valore. Davanti alle cose serie, esportate clandestinamente, dunque, Montanari tace; il suo collega Benati le dichiara «non fondamentali». E cosa sarà mai un Annibale Carracci!
Arriveremo a dire che anche un’opera inedita di Caravaggio può essere «non fondamentale», nonostante gli esiti delle aste internazionali.
Ma quando, nello stesso tempo, a New York è apparsa una modesta copia di Caravaggio, foto 4, il mercato l’ha respinta mandandola invenduta, non per minor interesse dell’arte antica rispetto all’arte contemporanea, come ha stupidamente scritto Francesco Bonami, ma perché l’opera non era buona, era una goffa derivazione, e nessuno l’ha acquistata. Contraddizioni del mondo dell’arte, ma anche complicità, furbizie, disonestà. Morale e materiale.
Tra i campioni di presunzione c’è un altro, in concorrenza con Bonami e Montanari, ed è Alessandro Morandotti, titolare di una rubrica su questo giornale. Naturalmente, essendo di famiglia di mercanti, esibisce un moralismo sospetto, come se le opere d’arte si trovassero sotto i cavoli. Anche capolavori come «La negazione di Pietro» di Caravaggio, acquistata per il Metropolitan da un perfettamente consapevole Keith Christiansen, era passata per il mercato. Ma quando un collezionista intelligente come Peter Silverman, che ha donato al Metropolitan, dove è esposto, un crocefisso attribuito a Michelangelo, riconosce un notevole dipinto proveniente da un codice miniato del 1496, la cosiddetta «Bella Principessa», foto 5, subito, senza alcuna autorevolezza e senza argomenti, il vanesio moralista ne stigmatizza la fortunatissima esposizione in Palazzo Ducale a Urbino e addirittura la pubblicazione sulla rivista «Paragone». Il suo occhio, che quando fu dipendente della Finarte confondeva Baldassarre Carrari con Baldassarre d’Este (ben lo ricordo), si rifiuta di rispettare e giudica con malinconica riprovazione Mina Gregori, la direttrice di «Paragone», Claudio Strinati, Nicholas Turner, e il più autorevole esperto di Leonardo, Martin Kemp, che hanno, con consolidata autorevolezza, ritenuto plausibile il riferimento a Leonardo che l’evidenza suggerisce. E, in ogni caso, al di là dell’autografia, i riscontri materiali ne garantiscono l’autenticità. Che è essenziale. Ma è arrivato il giustiziere, con la sua indignazione per i responsabili di Palazzo Ducale di Urbino non nominati, che hanno contestualmente ricostituito lo studiolo di Federico summa cum laude, e con la sua riprovazione per il comitato scientifico di «Paragone», che ha consentito la pubblicazione della «Bella Principessa» sulla prestigiosa rivista. E chi doveva impedirlo alla direttrice? Saremo stati distratti e non ci siamo accorti che Morandotti era un novello Berenson o un novello Longhi, incontaminati dal mercato? E dalla sua cattedra egli distribuisce sentenze. Altroché Gregori e Kemp!
Fatto sta che, tra opere buone scambiate per farlocche, opere farlocche scambiate per buone (niente da dire sulla Tavola Doria esposta al Quirinale, Morandotti?) e opere d’arte esportate all’estero nell’indifferenza dei moralisti (vero, Montanari e Morandotti?), non fa notizia l’apparizione di un’opera buona di una collezione pubblica, riconosciuta importante dopo essere stata considerata minore. È il caso della «Fortuna» dell’Accademia di San Luca a Roma, foto 2, riferita a Giovanni Andrea Sirani, sottoposta da Laura Cibrario e Fabiola Jatta a un restauro che ha rivelato la mano di Guido Reni.
In occasione della grande mostra «Da Cimabue a Morandi» ho pensato di esporla e addirittura di farne il simbolo della mostra e del catalogo. Lo schedatore, Massimo Francucci, aveva accettato il parere di alcuni studiosi, come Denis Mahon (più propenso a riconoscere autentici i propri quadri di quelli altrui) e Stephen Pepper, e aveva presentato l’opera come di Giovanni Andrea Sirani, composto allievo di Guido Reni. Nel corso delle indagini per il restauro appena concluso, le radiografie hanno però messo in evidenza, coperto da una successiva ridipintura, un borsello di monete nella mano della Fortuna, poi sostituito da una corona. La verifica delle fonti ha consentito di accertare che si tratta del dipinto iniziato da Antonio Giarola nello studio di Guido Reni per monsignor Altoviti, dipinto che il maestro bolognese decise di riprendere fino a renderlo autografo nell’intento di fare dispetto all’abate Gavotti (il proprietario della prima versione della «Fortuna») che aveva contravvenuto ad alcune indicazioni del pittore esponendo l’opera quando non era ancora finita, per poi venderla a 600 scudi, il doppio della somma pagata all’artista. Per distinguere le due versioni Reni sostituì il borsello alla corona.
Questa importante scoperta, accompagnata dall’indifferenza dei maestrini che non sono venuti a vedere l’opera dopo il restauro, è tanto più notevole perché ci viene restituita non dall’arbitrio degli esperti, bensì da una tecnologia intelligente, con il sapore della vita, delle polemiche, del carattere e del temperamento di Guido Reni, dopo Raffaello il pittore del bello ideale, ma con un umore fumantino. La critica, aldilà delle mitologie leonardesche, s’interroga, distingue e talvolta fa prevalere i documenti sugli occhi, fino a quando non è in malafede. I quadri pretendono attenzione, non presunzione, cari Montanari e Morandotti!
Già prima delle radiografie avevo pensato che la «Fortuna» potesse essere di mano del maestro, ne sentivo l’armonia e la freschezza esecutiva, ma ho preferito non anticipare il giudizio e aspettare l’esito delle indagini. Oggi abbiamo avuto la conferma. Una vera «Fortuna». I livorosi tacciano.
Il vittorioso
Altri articoli dell'autore
In una torrenziale arringa conclusiva al Convegno nazionale dei mercanti d’arte Fima, il sottosegretario, relatore ministeriale, ha evidenziato senza mezzi termini errori, incomprensioni e ostruzionismi autolesivi e talvolta perfino comici di una legislazione imperfetta e ostile e di una burocrazia statale ancora prevenuta nei confronti di un libero mercato adeguato ai tempi
In due volumi esce il Catalogo generale delle opere dell’artista milanese che rappresentò il senso della pittura come sogno, fiaba, visione. Si sentiva vicino ai metafisici perché le sue favole non sono altro dalla realtà, ma quello che si nasconde dietro le sue apparenze mutevoli e false
Pubblichiamo questo scritto di Vittorio Sgarbi in replica a «Il meglio e il peggio 2021» pubblicato nel numero di gennaio di «Il Giornale dell’Arte»
Il falsario di sculture ha tratto in inganno più di uno studioso e con la sua straordinaria perizia ha incantato i grandi musei. Anticipiamo un testo di Vittorio Sgarbi nel catalogo della mostra al Mart