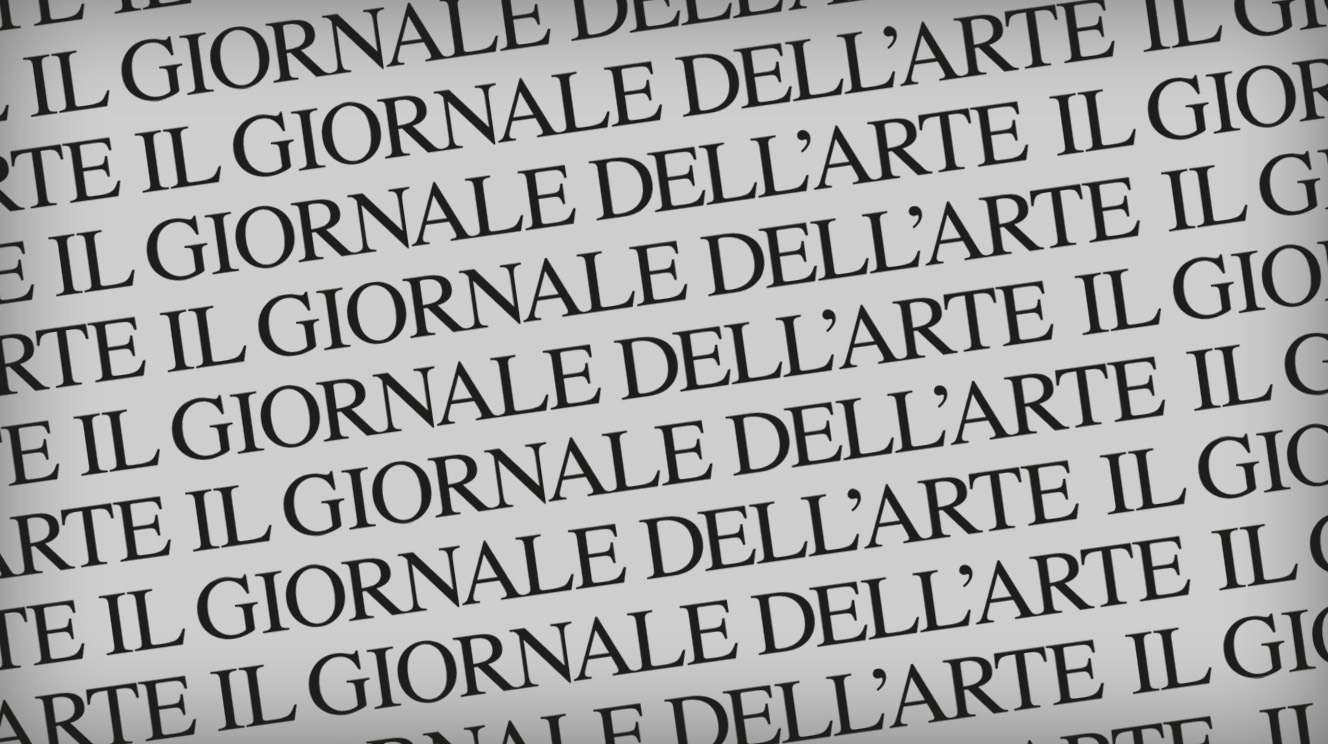Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
.jpeg)
Flaminio Gualdoni
Leggi i suoi articoliI custodi di museo sono una categoria di lavoratori sulla quale circolano i luoghi comuni più disparati: il mainstream è che siano fancazzisti radicali o, come usava dire un tempo, dei mangiapane a tradimento. Dopo un bel po’ di anni in cui mi è accaduto di aver a che fare con i custodi museali non solo come utente ma anche a titolo professionale, devo dire che un’opinione definitiva non sono ancora riuscito a farmela: anche se, nel frattempo, ho imparato che fa più fine dire «corpo di guardiania». E pensare che avevo debuttato con le aspettative più romantiche.
Quando ancora ero studente di Archeologia, in un museo del Sud mi fecero conoscere una specie di leggenda vivente, un signore mingherlino di mezza età che aveva affrontato da solo, naturalmente senz’altro ausilio che le sue mani e la capacità di proferire insulti con piglio assai convincente, una coppia di rapinatori riuscendo a metterli in fuga. Fico, pensai, ecco qualcuno che i beni li ama e li protegge davvero, con tanto di empito eroico annesso; ecco un caso da manuale di identificazione tra lavoratore e istituzione, di orgoglio del ruolo.
Poi sono arrivati gli anni del museo come professione e, nella dimensione degli istituti civici che ho frequentato, una casistica che è eufemistico dire balzacchiana. Il dato essenziale è che di soldi ce n’erano pochi (è bello avere delle certezze nella vita: nei musei i soldi sono sempre scarsi) e dunque bisognava arrangiarsi in tutti i modi.
A Milano e Varese ho avuto a che fare con quei benemeriti del Vami, i Volontari Associati per i Musei Italiani, che secondo statuto devono occuparsi di educazione permanente ma di fatto tappavano, già che c’erano, vistosi buchi in un personale sempre carente e spesso non all’altezza.
A Modena andavano forte le cooperative: i nomi delle associazioni non li ricordo, ma i nomignoli che si usavano sì. C’era la «cooperativa vecchietti», formata da pensionati che arrotondavano, e la «cooperativa tossici», ex tossicodipendenti restituiti alla vita vera che, visto che erano giovani e spesso nerboruti, già che erano lì venivano impiegati anche per gli allestimenti.
Quando nel 1992 avvenne la celebre e drammatica rapina alla Galleria Estense, al piano di sopra della «mia» Galleria Civica, ricordo un’allarmata riunione con vecchietti e tossici che si chiedevano e mi chiedevano come comportarsi in un caso del genere. Li guardai intenerito e non potei che dare l’unica risposta possibile: alzare prontamente le mani in alto e stare il più possibile fermi e zitti.
Naturalmente c’era sempre anche un manipolo sparuto di dipendenti a tempo pieno, il cui campionario umano è completo: il galoppino elettorale di partito messo lì per lo stipendio, che non faceva una mazza perché in realtà il suo vero datore di lavoro stava molto più in alto; alcune persone bellissime ed entusiaste (ricordo una signora che, partita come custode, è diventata apprezzata funzionaria); una percentuale per fortuna piccola di delinquenti; una massa compatta di tiratori a campare; gente che faceva decorosamente il proprio lavoro eccetera.
Nulla di più nulla di meno che in qualsiasi altra categoria di dipendenti pubblici, insomma, in tempi (ho scollinato, per dire, anche le stagioni procellose di Mani Pulite...) in cui sono arrivato ad auspicare che a provvedere alla selezione dei dirigenti pubblici, che sono il vero punto dolente della faccenda, dovessero chiamare uno come Pol Pot. Quando mi raccontavano che nell’amministrazione statale c’erano musei piccoli con pletore di custodi era da non crederci, mi pareva un altro mondo. Ma mi spiegavo benissimo il perché.
Poi qualcuno che aveva studiato teorizzò che quello che noi facevamo artigianalmente si chiama outsourcing e che i servizi di pulizia e guardiania (mestieri diversissimi ma, chissà perché, li mettono sempre insieme) si dovevano appaltare all’esterno, naturalmente al prezzo minimo. Quando obiettavi che così autorizzavi della gente mai vista e scelta da chissà chi a scorrazzare per sale in cui erano appese robe delicate che valevano un sacco di soldi, e che forse custodire ha un altro significato, venivi fatto oggetto di sguardi di commiserazione dai pasdaran del neobocconismo d’accatto.
Un borioso dirigente mi suggerì che si poteva nominare qualcuno di fiducia che, giuro, custodisse i custodi, e rimasi lì a chiedermi se era uno coltissimo e ironico che maneggiava Giovenale a menadito oppure un autentico, definitivo coglione.
Oggi, forte di queste memorie, leggo cronache in cui ci si accorge che la faccenda dei custodi è stata sottovalutata per decenni a tutti i livelli ed è diventata un groviglio inestricabile di ragioni e di torti. E continuo a coltivare la mia certezza che il difetto sta, come sempre, nel manico. È ufficiale, la mia proposta di far selezionare i dirigenti pubblici da Pol Pot (è morto, ma gli emuli non mancano) è ancora d’attualità.
Altri articoli dell'autore
Il Criptico d’arte • Conosciuto anche come Vasco dei Vasari, l’architetto italiano fu un personaggio anomalo: nonostante il suo contributo al Futurismo, indagò il modo in cui l’anarchia influenza l’arte
Il Criptico d’arte • La vicenda della Banana di Cattelan: da provocazione sul mercato a oggetto di gesti insensati e fuorvianti
A Milano una collettiva di 12 artisti omaggia in altrettante puntate il capoluogo culla della tecnica artigianale e artistica in grado di passare da generazione in generazione
La grande mostra sul movimento artistico voluta dall’ex ministro Sangiuliano in realtà arriva dopo settant’anni di studi specialistici sull’argomento. Ma l’Italia non è futurista