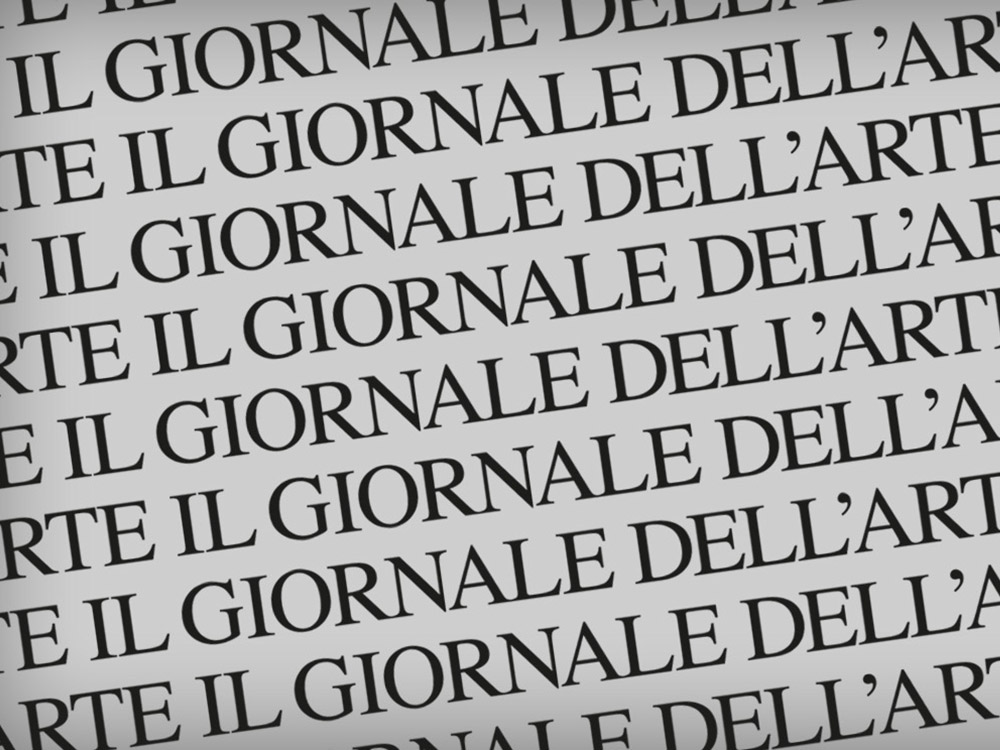Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Kenneth Goldsmith
Leggi i suoi articoliIl poeta Kenneth Goldsmith «rilegge» Apollinaire
Lo scorso mese, leggendo le notizie, ho scoperto che George Martin, produttore dei Beatles, era morto. Nel suo necrologio su «The New York Times» c’era questa frase: «Fu uno dei pochissimi produttori di musica pop a diventare famoso quasi quanto i suoi musicisti». Mi sono fermato a riflettere. L’unica figura che vi si avvicina nella storia dell’arte è il poeta e critico Guillaume Apollinaire (1880-1918). Vissuto al culmine delle avanguardie parigine e circondato da artisti come Marcel Duchamp, Pablo Picasso e Henri Matisse, Apollinaire è inesorabilmente legato alla storia dell’arte; anche soltanto per aver coniato nel 1917 il termine «Surrealismo», sarebbe ancora ricordato oggi, a quasi un secolo dalla morte.
Dal 6 aprile al 18 luglio il Musée de l’Orangerie presenta «Apollinaire: la visione del poeta», una mostra di circa 360 dipinti, sculture, fotografie e libri perlopiù realizzati tra il 1902 e il 1918 che illustrano l’importanza della sua critica per gli artisti della sua cerchia (da Rousseau il Doganiere a Derain, da Matisse a Braque a Delaunay, con una sezione particolare ricca di opere poco note, dedicata al suo legame con Picasso). Molti tra coloro che lo riveriscono come critico d’arte conoscono meno la sua poesia. Iniziò come post simbolista per poi passare ai romanzi erotici (di cui uno censurato in Francia fino al 1970), ma trovò la sua strada poco prima della morte, con una serie di poesie visive radicali, i Calligrammes, che portarono a un livello superiore l’aleatoria poesia di Mallarmé Un coup de dés jamais n’abolira le hasard (1897), sottraendo la poesia alla tirannia della rigorosa linearità.
Apollinaire trattava lo spazio della pagina come fa un pittore con la tela, ovvero come un campo aperto. In sostanza dipingeva con le parole. Era talmente convinto che la poesia potesse eguagliare la pittura da prendere in considerazione Et moi aussi je suis peintre come titolo alternativo per i Calligrammes. Ma le sue escursioni erano troppo eccentriche, delicate e verbose, in un certo senso troppo deboli, per competere con la bruta forza grafica di un’opera, ad esempio, di Fernand Léger, perciò il loro impatto si fece sentire più nella letteratura che nel mondo dell’arte.
L’influenza di Apollinaire conobbe fasi alterne. A metà degli anni Cinquanta l’impulso avanguardista della scrittura si era indebolito, portando il pittore e poeta canadese Brion Gysin a lamentare nel 1959 che la scrittura era di mezzo secolo indietro rispetto alla pittura. Ma appena pochi anni più tardi, l’arte concettuale si affermò con un rinnovato interesse alle proprietà visive del linguaggio, rinvigorendo la pagina e la tela in un modo che Apollinaire aveva anticipato. In Brasile, il gruppo di poeti concretisti Noigandres sviluppò un termine che si adattava perfettamente all’opera di Apollinaire, «verbivocovisual». Le sue poesie furono concepite per essere lette in silenzio, intonate a voce alta e ammirate per la loro bellezza visiva. Una di loro, La Mandoline, l’Oeillet et le Bambou (presente in mostra), consiste di lettere e parole scritte a mano che formano tre immagini raggruppate: un garofano, un mandolino e una pipa da oppio.
Ogni immagine è una poesia e ogni poesia sviluppa una proprietà fisica dell’immagine che rappresenta: il garofano allude all’odorato, il mandolino al suono e la pipa suggerisce l’odore dell’oppio. In altre parole si tratta di un precursore del multimediale: il modo in cui le parole volano sulle pagine internet, spesso accompagnate dal suono, richiama Apollinaire.
Nel 2008, il Jewish Museum di New York ha organizzato la mostra «Action/Abstraction», che presentava l’Espressionismo astratto dai diversi punti di vista dei critici d’arte rivali Clement Greenberg e Harold Rosenberg. Eppure, nonostante questi due studiosi godano di grande stima, non sono riveriti come lo fu Apollinaire, e certamente non da parte degli artisti. Dal 1916 al 1917, Duchamp storpiò per gioco il suo nome nel dipinto «Apolinère Enameled» e due anni prima Giorgio de Chirico lo raffigurò come statua classica con un paio di occhiali da sole (entrambe le opere sono nella mostra di Parigi).
È difficile immaginare Robert Rauschenberg o Jackson Pollock che trattano Rosenberg o Greenberg con lo stesso rispetto. Oggi Apollinaire è ancora importante? «Non si può trasportare ovunque il cadavere del padre», scrisse in un saggio sul Cubismo, ma ora viviamo in un tempo in cui tutte le idee sono vive e non ci sono cadaveri. Oggi la poesia è allo stesso livello della pittura, del cinema e della musica. Apollinaire non avrebbe motivo di ansia. La sua delicatezza, le eccentricità, la debolezza sono la nostra forza.