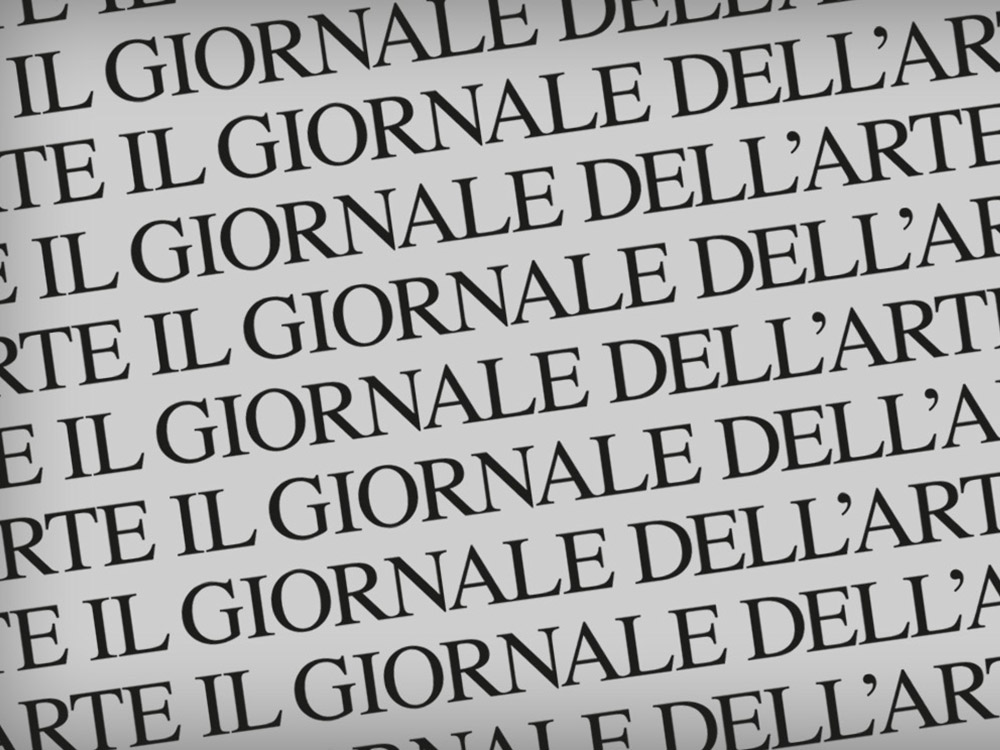Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Silvia Mazza
Leggi i suoi articoliOggi non ha senso definirsi “conservatori” o “progressisti”. Si tratta di amare il presente con una politica che “sappia” il passato ma non si volti indietro
Difficile immaginare un altro protagonista di questa rubrica a cui siano cucite addosso le vesti sia dell’«eretico» sia del «profeta». «Eretico» della politica italiana Fabio Granata, 57 anni, lo è per antonomasia: un uomo di destra che piace alla sinistra, che ne ha sempre apprezzato le battaglie culturali e il rigore nella lotta per la legalità. Sei anni fa, a conclusione di un’intervista, Corrado Augias gli chiedeva provocatoriamente: «Ma lei che cosa ci fa a destra?», oggi, nell’era dei social, Giuliano Volpe, presidente del Consiglio superiore dei Beni culturali, può dirgli su Facebook: «Ho sempre apprezzato il suo impegno e il suo lavoro, anche da posizioni diverse, ma con sincera stima, e sono convinto che gli innovatori veri sono distribuiti in vari ambiti, bisognerebbe solo ritrovarsi».
Intransigente sui valori non negoziabili, irriducibile nella richiesta di verità e giustizia per Paolo Borsellino e per tutti i martiri di mafia, proprio per l’azione politica portata avanti da vicepresidente nella Commissione parlamentare Antimafia sulle stragi del 1992, sarà espulso dal Pdl. Aveva ospitato il magistrato nel settembre del 1990 nella sua Siracusa, dove aveva organizzato la Festa Nazionale del Fronte della Gioventù. E «a Paolo» ha dedicato il suo ultimo libro Meglio un giorno. La destra antimafia e la bandiera di Paolo Borsellino (Eclettica Edizioni, 2015), racconto carico di «furore» della destra antimafia, ma anche momento di rilettura autocritica, tra disincanto e rabbia, della «contaminazione berlusconiana», di cui scrive: «Illudersi che non potesse arrivare a demolire l’anima e l’identità della nostra comunità politica fu errore letale e (...) “compromesso accettato” da moltissimi».
Nei suoi anni all’Assemblea regionale siciliana, dal 1994 al 2006, dove è stato vicepresidente della Regione Siciliana e presidente della Commissione Antimafia, il lungo mandato ai Beni culturali (specialmente se lo si confronta con l’instabilità del governo Crocetta, che ha cambiato 5 assessori in meno di tre anni) dal 2000 al 2004, e poi al Turismo fino al 2006, lo ha visto protagonista di tante battaglie, contro l’abusivismo edilizio nella Valle dei Templi (per cui fu posto sotto scorta), per salvare il Val di Noto dalle trivellazioni petrolifere, ottenendo ben due riconoscimenti Unesco, realizzando il primo Distretto culturale d’Italia, quello del Sudest, e soprattutto innovando profondamente la legislazione siciliana. Lo ha fatto con il Piano paesistico regionale, con la legge che ha dato vita alla Soprintendenza del Mare, e soprattutto con la legge regionale 20/2000, che ha istituito il «Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi e il sistema dei parchi archeologici siciliani», prevedendone l’autonomia gestionale e finanziaria: una riforma che fa a buon diritto di Granata un «profeta», anticipando di ben 15 anni il nuovo corso dei musei statali. E anni dopo, nella Commissione Cultura della Camera, dove era approdato nel 2008, aveva pure presentato proposte di legge per estendere a livello nazionale quel sistema dei parchi siciliani, in largo anticipo, anche qui, sulla riforma Franceschini.
Lo scrittore Andrea Camilleri, che oggi insieme al giornalista e scrittore Pietrangelo Buttafuoco firma la lettera appello al ministro Franceschini perché intervenga nella disastrata situazione siciliana, nel 2004, nella sua introduzione al libro di Granata L’identità ritrovata. Viaggio nel Sudest (2004), di lui dice: «Si tratta di un grande esempio. Di come cioè un’amministrazione soprattutto onesta e intelligente, guidata da illuminati intenti, sappia utilizzare la memoria storica come linfa vitale per il futuro. Quanti saranno a seguirlo?». Proprio Buttafuoco, in un recente elzeviro dedicato a Granata su «Il Fatto Quotidiano» questi concetti li concentra nel titolo: «Con politici come lui la Destra non sarebbe finita al Bar Sport».
Che il «modello Granata» dei parchi sia vincente lo dimostra proprio quello della Valle dei Templi, con un bilancio in costante ascesa. Nei primi tre mesi di quest’anno, rispetto al 2015, ha registrato un aumento del 35% dei visitatori. Fabio Granata, perché in tutti questi anni si è lasciato interrotto questo processo riformistico, non riprendendolo nemmeno adesso che è in corso una riorganizzazione del Dipartimento siciliano dei Beni culturali?
Perché la Sicilia non ha più una politica dei beni culturali, anzi non ha più una politica «tout court». I primi dieci anni del 2000 sono stati anni di impegno e coraggio contro le devastazioni, conseguenze del boom economico e dell’abusivismo edilizio, dello sviluppo abnorme e caotico dei centri urbani e dell’industrializzazione incontrollata e selvaggia. È proprio da questo impegno, subito dopo le prime 16 storiche demolizioni nella Valle dei Templi da me portate a termine dopo anni di chiacchiere, che elaborammo uno strumento legislativo all’altezza dello straordinario patrimonio archeologico siciliano, parallelamente all’altrettanto innovativa concessione al Fai dei Giardini della Kolymbethra. Il cuore della novità era rappresentato dalla piena autonomia gestionale e finanziaria riconosciuta al Parco attraverso la sapiente gestione di un organismo nuovo, il Consiglio del Parco, organismo aperto e partecipato. E mentre lo Stato introduce il modello autonomistico, ma separa tutela e valorizzazione, la mia legge le tiene ancora insieme, non solo inserendo anche la tutela tra le finalità del parco, ma prevedendo la presenza del soprintendente nel Consiglio, diversamente che nei comitati tecnici dei musei autonomi. Oggi, mentre del sistema dei parchi previsti dalla norma non c’è ancora traccia, si cincischia con improbabili «riforme». Non è con fantasiosi poli museali, peraltro coincidenti col superato assetto territoriale delle ex Province, né indebolendo l’attività delle soprintendenze accorpando le distinte unità disciplinari, né pensando di cancellare i due Centri regionali, del Restauro e del Catalogo, né tantomeno con la leggerezza nella gestione del patrimonio che si modernizza il nostro sistema.
Si riferisce al prestito dell’Annunciata di Antonello da Messina di Palazzo Abatellis per la mostra organizzata dalla Fondazione DnArt?
Sì, dissennata è l’idea annunciata di ricominciare a prestare reperti e quadri delicatissimi e caratterizzanti l’identità stessa dei nostri musei per «far conoscere la Sicilia» (sic) da parte dell’ennesimo assessore ai Beni culturali. Basterebbe invece rendere operativa la norma sui Parchi per risolvere, definitivamente, gran parte delle questioni legate alla valorizzazione e rendere possibile pure una virtuosa gestione economica del patrimonio. Così come basterebbe dare piena applicazione al rigoroso Piano paesaggistico regionale, che evidentemente infastidisce chi in nome di improbabili «rivoluzioni» apre la strada a trivelle, industria, aggressione al paesaggio e Muos (Mobile User Objective System, un sistema di comunicazione satellitare al servizio del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, Ndr).
Altro tasto dolente, l’incapacità di gestire i fondi comunitari, per cui al 31 dicembre 2015 la Sicilia non è stata in grado di spendere 51 milioni di euro, per progetti sbagliati o in ritardo. Quali sono secondo lei le ragioni di questo fallimento?
Le uniche risorse possibili per interventi di conservazione e valorizzazione del patrimonio siciliano sono oramai solo i Fondi comunitari, che vengono utilizzati solo al 20% e comunque senza alcuna «visione di sistema». Neanche questo dipende dalla Autonomia, ma solo dall’attuale incapacità di governo. Nella stagione nella quale ho avuto compiti di responsabilità diretta sul Patrimonio è stato reso possibile dispiegare, con un’utilizzazione virtuosa, rapida e trasparente delle risorse europee, la più grande operazione di recupero, valorizzazione e modernizzazione del settore dei beni culturali mai avvenuta in una singola Regione, con interventi realizzati che hanno impiegato il 98% delle risorse disponibili, oltre 1 miliardo di euro.
Ricordavamo la lettera appello di Buttafuoco-Camilleri, ma sempre più spesso intellettuali o giornalisti, da Salvatore Settis a Francesco Merlo o Gian Antonio Stella, chiedono l’abolizione dell’autonomia siciliana. Nel suo libro «L’identità ritrovata» lei scrive: «La competenza “specifica ed esclusiva” sui Beni culturali ha esaltato per la prima volta le enormi potenzialità dell’autonomia regionale». Ma oggi, di fatto, questa stessa «specialità» non sta tagliando fuori la Regione dalla riforma ministeriale?
L’appello nasce senz’altro da buone intenzioni ma ripropone un vecchio limite degli intellettuali siciliani che sembrano sempre aspettare un «salvatore» che venga da fuori la Sicilia e la possa redimere. La responsabilità non è dell’autonomia, come ho appena dimostrato, ma dell’uso che si riesce a farne. Gestire direttamente il patrimonio culturale è possibile, ma servono rigore, intelligenza, generosità e trasparenza.
Insomma, una passione autentica per il patrimonio che sembra oggi aver trovato la «formula» politica più aderente. Lei, infatti, è il principale ideologo del movimento civico #diventeràbellissima, che guarda anche ai «delusi» a sinistra: sfida lanciata, nel novembre 2014, al Pd e al Crocettismo per le prossime elezioni, da Nello Musumeci, presidente della Commissione regionale Antimafia, figura storica della destra siciliana.
Oltre le categorie politiche del ’900, il nuovo conflitto non sarà più tra destra e sinistra, categorie storiche oramai indistinte e sostanzialmente omologate dal pensiero unico, ma tra chi crede che ogni cosa abbia un prezzo e chi ritiene che invece debba sempre prevalere l’intangibilità e la difesa di ciò che ha valore per la comunità. Oggi è insignificante dirsi conservatori o progressisti poiché non si tratta di essere semplicisticamente a favore della modernità o contro. Si tratta, invece, di amare il proprio tempo e di provare ad affrontare un nuovo «viaggio» politico e un itinerario che «sappia» il passato ma non si volta indietro. L’Italia, e la Sicilia, rappresentano una dimensione peculiare e una promessa del tempo presente e hanno tutte le condizioni per esser declinate in modo «smagliante». Ma non serve una modernizzazione declamata e comunque stereotipata, magari dettata da provinciali complessi di inferiorità verso modelli altri e lontani. Soprattutto non serve alla Sicilia.
Altri articoli dell'autore
La proposta di legge Orlando-Franceschini è passata alla Camera
Pronta la nuova agorà del Museo Salinas in restauro da dieci anni
Cronaca e progetti a cinquant’anni dal sisma
Polemiche per la trasferta di una tavoletta del pittore messinese, tra le 120 opere scelte dal critico d'arte per il Castello Ursino di Catania.