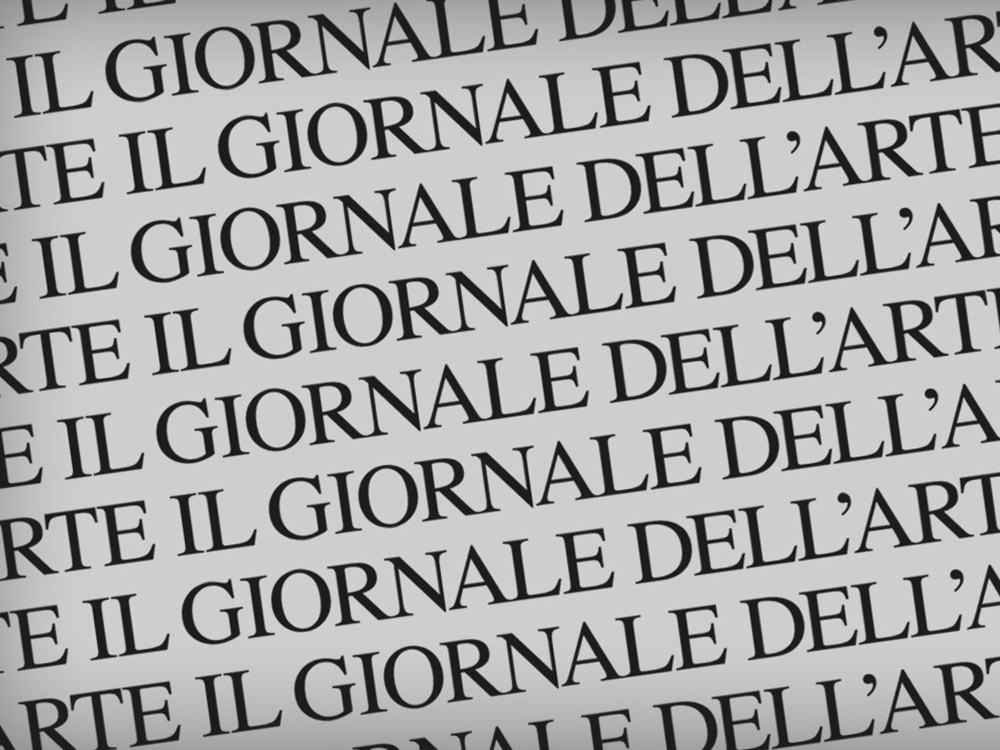Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Fabrizio Lemme
Leggi i suoi articoliOggi esiste una nozione normativa onnicomprensiva
Nel corso dei numerosi workshop che si svolgono in questi giorni sull’argomento «l’educazione all’arte e alla cultura» (sembra che la primavera propizi, oltre all’amore, anche le discussioni artistiche!), si succedono interventi, a volte di notevole livello, su come si debba promuovere la cultura, quali siano gli strumenti di tale promozione, quali i soggetti chiamati, istituzionalmente o per vocazione, a tale operazione. Mancano, peraltro, gli interventi che io riterrei preliminari: che cosa si intenda, oggi, per arte e per cultura. Benedetto Croce, in un suo fondamentale saggio del 1912, il Breviario di Estetica, esordisce dicendo, in buona sostanza, «alla domanda cos’è l’arte si potrebbe rispondere, e non sarebbe una risposta banale, che l’arte è quel che tutti conoscono sotto tale nome».
Anche oggi, alla domanda «che cos’è la cultura», si potrebbe rispondere allo stesso modo; ma la risposta potrebbe egualmente ritenersi «non banale»?
Perché le nozioni di arte e di cultura, nel secolo XX, sono state oggetto di una radicale rivisitazione, in data e in ambienti diversi da quelli in cui è fiorito il Neoidealismo di Croce e di Gentile.
Partiamo dalla prima (arte): un tempo esistevano le cosiddette Belle Arti, ossia quelle arti figurative che si assemblavano sotto il comune denominatore del disegno: la prima Accademia, quella fondata a Firenze da Giorgio Vasari nel 1563 che ebbe come primo presidente o principe Michelangelo, si chiamò appunto Accademia delle Arti del Disegno. L’arte era allora (e lo è stato fin quasi ai nostri giorni) sinonimo di creatività: l’artista doveva tradurre il concetto creativo in un opus da lui stesso realizzato e che avesse rappresentato, crocianamente, una «espressione nitidissima» di tale concetto. Sotto tale profilo, l’arte si distingueva totalmente dall’artigianato, che riproponeva in termini sostanzialmente immutati uno stesso prototipo.
Nel 1917, a Zurigo, sotto gli auspici di Tristan Tzara, si tenne la prima mostra del «Dadà», ossia di un’arte che, finanche nel nome, si richiamava al gioco dei bimbi piuttosto che alla professione di artista. In tale mostra, Marcel Duchamp (1887-1968) espose, sotto il titolo di «Fontana», un orinatoio rovesciato di forma rettangolare (quelli che si trovavano un tempo nelle cosiddette ritirate dei treni), con la misteriosa scritta «Mutt». Era nata l’arte preconfezionata, il «ready made». Da quel momento si può dire sia successo di tutto: nel 1968, Jannis Kounellis espose nella Galleria L’Attico di Fabio Sargentini dei cavalli vivi, che mangiavano, bevevano e defecavano. Marcel Duchamp, nell’ultima mostra da lui organizzata («Mostra di Marcel Duchamp») espose se stesso, seduto a un tavolino a sorbire un caffè: si potrebbe dire che non vi è mostra migliore di un artista che quella in cui egli ne rappresenti, allo stesso tempo, il soggetto e l’oggetto! Nel 1972, alla Biennale di Venezia, Gino De Dominicis (1947-98) espose addirittura un mongoloide, in carne e ossa, seduto con in mano un cartello con scritto «seconda soluzione dell’immortalità, l’universo è immobile» (e il fatto suscitò tale clamore da dare origine a un processo, nel quale io difesi l’artista e lo feci assolvere). Finalmente, Joseph Beuys (1921-86) fondò (1983) la Free International University (F.I.U.), alla quale sono iscritti d’ufficio tutti i sei o sette miliardi di uomini che popolano il pianeta: l’arte è diventata totalizzante.
Parallelamente a questa rivoluzione dell’arte, vi è anche una rinnovazione dell’estetica, intesa come riflessione filosofica sull’arte: nel 1929, a Parigi, da Lucien Febvre e Marc Bloch viene fondato il periodico «Les Annales», che rivisita dalle fondamenta il concetto di «cultura». Partendo dal recupero di una «cultura delle classi subalterne», alternativa di spessore non inferiore a quella delle «classi dominanti» e che si esprime anche attraverso gli strumenti del lavoro e della fatica manuale, acquistano dimensione culturale tutti i fatti della vita che siano in grado di esprimere una testimonianza del divenire umano.
Recependo normativamente questa nuova dimensione della cultura, nel Testo Unico dei Beni Culturali elaborato durante il Ministero di Giovanna Melandri (D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490), dopo avere specificato analiticamente le varie categorie di beni culturali tutelabili, si introduce una norma di chiusura: «Art. 4 - Nuove categorie di beni culturali. 1. Beni non ricompresi nelle categorie elencate agli articoli 2 e 3 sono individuati dalla legge come beni culturali in quanto testimonianza avente valore di civiltà». E tale disposizione è letteralmente richiamata nell’art. 2 del D.lgs. 42/04, oggi vigente (Codice dei Beni Culturali), che, in chiave riassuntiva, definisce come patrimonio culturale qualsiasi «testimonianza avente valore di civiltà».
Esiste oggi, dunque, non una nozione filosofica ma una nozione normativa di cosa sia la cultura, identificata appunto con qualsiasi testimonianza avente valore di civiltà. Oggi, dunque, qualsiasi manifestazione umana assume valore culturale: dall’arte del cuoco all’arte del barbiere a quella del sarto, del falegname, dell’ebanista, dell’artista ecc. In questa visione omnicomprensiva non esiste neppure una scala gerarchica.
E allora, in cosa consiste oggi l’educazione alla cultura? Forse la risposta è in questo: un’educazione alla umanità. Probabilmente, questa nozione pecca di genericità e qualcuno, come nella Fattoria degli animali di Orwell, potrà continuare a ritenere che le tradizionali belle arti (pittura, scultura, architettura: riassuntivamente, disegno), in un mondo di eguali, siano «più uguali degli altri».
Questa opzione è legittima ma a condizione che sia accompagnata dalla consapevolezza della sua problematicità.
Altri articoli dell'autore
I beni culturali possono essere dichiarati di particolare interesse solo se la loro esecuzione risalga ad almeno cinquant’anni
La capacità (e l’obbligo) di correggersi della Pubblica Amministrazione
Va introdotta una distinzione tra ricerca significativa e ricerca inutile: la prima aggiunge qualcosa alle conoscenze già acquisite, la seconda si limita a riproporre il «déjà dit»
Il conflitto tra Russia e Ucraina mette in luce un relativismo che parte da Giovanni Battista Vico