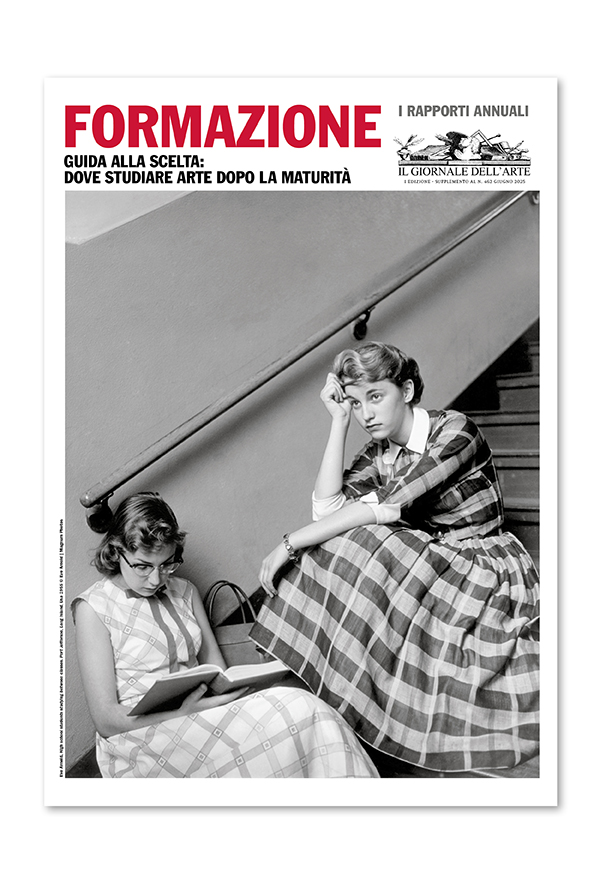Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Vittorio Sgarbi
Leggi i suoi articoliProsegue fino al 17 maggio, a Palazzo Fava Palazzo delle Esposizioni di Bologna, la mostra «Da Cimabue a Morandi. Felsina Pittrice», curata da Vittorio Sgarbi e dedicata a Roberto Longhi, a ottant’anni circa dalla sua celebre lezione all’Università di Bologna (1934) sulla grande tradizione artistica della città, fino ad allora subordinata dalla critica a Firenze e a Venezia. Nelle sale affrescate dai Carracci e dalla loro scuola, sono riunite 200 opere provenienti da chiese, istituzioni e collezioni private che illustrano quanto di più significativo in campo artistico la città di Bologna ha realizzato nel corso di oltre sette secoli. Il testo che segue è tratto dal saggio di presentazione di Vittorio Sgarbi che appare in apertura del catalogo (edizione Bup), a cura di Sgarbi e Pietro Di Natale.
Iniziava, nel 1934, una stagione nuova, per la storia dell’arte, per Bologna, per la pittura contemporanea. Roberto Longhi era stato chiamato alla cattedra di Storia dell’Arte dell’Università (...). Longhi illustra agli studenti (...) i Momenti della pittura bolognese. Scelta semplice; ma rivoluzionaria e innovativa, perché mai affrontata, e quindi originaria, come se nella grande storia dell’arte Bologna fosse marginale o periferica. (...) Longhi inizia a minacciare il primato dell’arte toscana, con un avanzamento a tenaglia: le parole, anima e cuore del docente, e gli scritti, metodo e ragione dello studioso. Subito annuncia e spiega: «Condotto dalla mia conformazione mentale a un amore per la lettura diretta dell’opera come documento parlante, non mai stanco di spremerne i significati quasi inesausti», ed entra risolutamente in medias res: «Se ora desidero far cenno di alcuni momenti della pittura bolognese nessuno si attenderà, ne sono certo, che ciò sia per il retorico fine d’infiorare di nuovi serti le glorie più note di questa vostra vera storia, ma piuttosto per isforzarmi di recare qualche nuovo lume interpretativo sulle zone più buie di essa, o più variamente giudicate». Le «zone più buie» indicano, in termini più affettuosi che polemici, l’arretratezza degli studi in alcune aree della storia dell’arte, diverse e lontane dalla predominante cultura toscana, in un risoluto esordio di geografia della storia dell’arte che nessuno più di Longhi aveva fino a quel momento innescato. (...) Parole, davanti agli studenti, dense e cariche di significati, e insidiose nel dire di ciò che avrebbe dovuto essere, ma certo non era, familiare, e neanche genericamente noto, a chi lo ascoltava. Al quale, studente soggiogato e intimidito, quelle parole iniziavano ad aprire orizzonti certamente sconosciuti, e suggerivano di andare lestamente a prendere confidenza con quelle opere e quei monumenti che, parlando a Bologna, lui di Alba che meglio di loro li conosceva, agli allievi bolognesi diceva «vostri», tra divertimento e affettazione, come se non potesse essere (e invece era) altrimenti: «I vostri bei san Francesco, san Domenico... postulano insomma, già come esigenza culturale (ciò che invece non varrebbe per Francia o Germania), l’esistenza di una pittura contemporanea di un livello coerente a quell’architettura, che non è già di gotico popolaresco, ma nobilissimo, italianamente spazioso, e pertanto buon portatore di buona figurazione dipinta». (...) Tanto gli bastava per concludere: «Ci fu dunque una volta la buona pittura bolognese del Trecento. Ma bisogna lasciar la speranza di ritrovarne quanto basta per interpretarla e, forse, in modo diverso dal corrente?». (...) Inizia così, davanti a studenti affascinati e attoniti, la nuova lettura della pittura bolognese da parte del Longhi, (...) che intendeva sbarazzarsi e sbarazzarci di un impedimento di ordine teorico: «Quello cioè che avrebbe preteso di trascurare la pittura trecentesca di Bologna poco più che come massa informe di refusi e di storpiature sui grandi e indefettibili modelli toscani; un atteggiamento critico che, sia pur riformato, dura nella coscienza comune dai tempi del Ghiberti e del Vasari». (...) Longhi inizia a delineare i caratteri storici e psicologici della pittura bolognese: «sommamente icastica veristica asintattica, direttamente espressiva, talora persino “espressionistica”, non poteva, nelle mani dei minori... che scadere ad approssimazioni confuse, ad oltranze, poco manca, caricaturali».
Morire di raffaellite
(...) Siamo entrati nel secolo nuovo. A Venezia avrà il volto di Giorgione. A Bologna, impermeabile all’apparenza (ma non il curiosissimo Aspertini), quello del sofisticato e cavilloso Filippino Lippi, che concepisce nel 1501, per la famiglia Casali, la tavola con il «Matrimonio mistico di santa Caterina» nella basilica di San Domenico. Perché si avverta la novità di queste presenze aliene, con un effetto dirompente, occorrerà aspettare il 1515, con la messa in opera, ancora in San Giovanni in Monte, dell’«Estasi di santa Cecilia» di Raffaello. L’effetto che determinò è spiritosamente e tragicamente raccontato da Vasari, appena trent’anni dopo, e quindi con una certa attendibilità, nonostante l’apparenza inverosimile: «Era la tavola di Raffaello divina, e non dipinta, ma viva, e talmente ben fatta e colorita da lui, che fra le belle ch’egli dipinse, mentre visse, ancora che tutte siano miracolose, ben poteva chiamarsi rara. Laonde il Francia; mezzo morto per il terrore e per la bellezza della pittura, che era presente agli occhi, ed a paragone di quelle che intorno di sua mano si vedevano, tutto smarrito; la fece con diligenza porre in San Giovanni in Monte a quella cappella, dove doveva stare; ed entratosene fra pochi dì nel letto, tutto fuori di sè stesso, parendoli non essere rimasto quasi nulla nell’arte, appetto a quello che egli credeva e che egli era tenuto, di dolore e malonconia, come alcuni credono, si morì...». E se il trauma per il Francia fu un colpo al cuore, per altri si riflesse prontamente nella duplicazione delle forme nuove, come nel Bagnacavallo junior o nello scultore Alfonso Lombardi; e, in modo risoluto e sperimentale, in Girolamo da Carpi. (...) Ma Bologna non poteva piegarsi davanti a Raffaello senza l’estrosa risposta umorale, di testa e di pancia, in un delirio di forme capricciose, quali troveremo fin dalla «Pala del Tirocinio», di Amico Aspertini. Sulfureo, incontinente, drammatico, sgangherato e dolente, soprattutto nella tavola per la distrutta chiesa di San Tommaso di Strada Maggiore, sul 1520-22, tra Mazzolino, Dürer e Lotto. Due rivoluzioni indipendenti convivono, con Raffaello e Aspertini. E, nel caso del secondo, non si tratta di una variante manieristica alla Pontormo, ma di una profonda, radicale insoddisfazione per il classicismo raffaellesco. Longhi puntualizza: «Sbadata consuetudine mentale quella di considerare l’Aspertini come una bizzarria senza portata effettiva! Peggio, che grosso errore... nei riguardi di un manierista sommamente romantico, e, per di più, appartenente al barbaro e dissestato settentrione. Ma l’Aspertini è un vero pittore... Ed è un autentico scopritore di nuova terra, una specie di Filippino, di Cranach bolognese. (...) Un grottesco, ma che non si esaurisce in se stesso, anzi vibra intensamente nel patetico; e dà superbamente l’avvio, con un bell’anticipo, a quella che sarà la controparte spirituale del manierismo, negli animi più accorati, come il Beccafumi il Rosso il Pontormo e il Sodoma; tutti parecchio più giovani dell’Aspertini».
Poussin il bolognese
(...) Principia dunque negli ultimi anni del Cinquecento l’avventura dei Carracci, ed è, dopo le secche del Manierismo, inizio di storia moderna. Anche qui l’autoanalisi del Longhi, che mette a confronto l’entusiasmo suo per Caravaggio con la tiepidezza con cui si era accostato, solo tardivamente comprendendone l’importanza, ai Carracci, è illuminante: «Intendere i Carracci, mi avvedo, è affare di maturità, cui non escludo si possa giungere anche in giovinezza; ma insomma non è stato il mio caso». E così, sorretto da «giovanile» entusiasmo, il Longhi ci offre un’altra nuova apertura critica, dando lustro al luogo nel quale questa mostra si distende: «A indovinar la giornata dal mattino, bastano gli affreschi giovanili dei Palazzi Fava e Magnani; dove è palese che il movente dei Carracci fu sin dall’inizio un movente “lombardo”, inteso a scavalcare il cadavere del manierismo e a comunicare direttamente, ad apertura, non di libro, ma di finestra, con lo spettacolo mutevole delle circostanze di natura, con la gaietta pelle del paese, con la grana delle cose sotto la luce vera. È l’aspetto solito di ogni rivoluzione artistica, quello insomma del “ritorno alla natura”... Senonché, appena le circostanze del tempo li toccano più davvicino e li costringono a impegnarsi coi temi canonici, l’incontro (e che romantico incontro fu quello) con i precedenti artistici tradizionali li getta in un furioso amore per la vera grande pittura italiana». (...) I Carracci ripensano i grandi modelli senza ossequio, senza soggezione, con grande naturalezza. Osserva il Longhi: «Ma l’atteggiamento dei Carracci... resta intimamente romantico, non dottrinale e archeologico; evocativo, non retrospettivo... Qui, insomma, io avverto che è il segreto dei Carracci: in questa epopea, in questo romanzo storico, immaginato sulla grande pittura precedente, la quale viene riassunta non già come obbligazione metodica, ma come costume insostituibile, quasi come soggetto di grado più profondo per la propria pittura nuova e diversa; di affettuoso timbro lombardo. Ecco l’errore di voler sceverare e spuntare, ecletticamente, i frammenti di Tiziano, di Raffaello, di Correggio, di Michelangelo e dell’antico nelle opere dei Carracci; mentre è l’antica, ormai olimpica, cultura pittorica italiana, che, fusa e impastata come costume civile, latino ed italico, transita, rivive, si atteggia nella tenera illusiva moderna epidermide dei Carracci». E, in effetti, dipinti come la «Famiglia del pittore» e l’«Autoritratto», di Annibale, non mancano di sorprendere per l’immediatezza e la dimensione di domestica verità che indicano un naturalismo tanto diverso da quello programmatico di Caravaggio. «Ai Carracci sta a cuore di evocare soltanto non questo o quello stile, ma come l’incarnazione affettiva di essi, ora cioè quella fastosa floridezza, ora quell’atteggiata eleganza, ora quella rupestre potenza, e ridottele a costume, a ethos, muoverle più vicine a noi, in un tono dolcemente illusivo di vero». (...) Meditando sugli affreschi di Annibale nella Galleria di Palazzo Farnese, Longhi riconosce una inedita interpretazione dei frammenti della vera antichità, ispirazione per tanti artisti dalla fine del Quattrocento: «Anche l’arte antica è reimmaginata per via di affettuosa verosimiglianza, non per via metodica». Di questo classicismo affabile, affettuoso, immerso in una luce mentale, sono diversamente titolari anche il Domenichino e l’Albani. Il primo, talmente innestato sulla cultura romana da avere, delle origini bolognesi, soltanto un istinto, una natura, trasferiti nel mito con più autenticità e verità dello stesso Poussin. Anche qui l’intuizione di Longhi è straordinaria: «Ecco perché ci sembra ormai insopportabile condizione l’odierna [1934!], in cui i cugini francesi trattan di grecoantico, sic et simpliciter, il loro Poussin, pretta creatura dei bolognesi, e noi sembriamo persino esserci scordati di poter chiamare appropriamente latini Annibale, e dopo di lui (genus unde latinum), almeno il Domenichino e l’Albani».
Altri articoli dell'autore
In una torrenziale arringa conclusiva al Convegno nazionale dei mercanti d’arte Fima, il sottosegretario, relatore ministeriale, ha evidenziato senza mezzi termini errori, incomprensioni e ostruzionismi autolesivi e talvolta perfino comici di una legislazione imperfetta e ostile e di una burocrazia statale ancora prevenuta nei confronti di un libero mercato adeguato ai tempi
In due volumi esce il Catalogo generale delle opere dell’artista milanese che rappresentò il senso della pittura come sogno, fiaba, visione. Si sentiva vicino ai metafisici perché le sue favole non sono altro dalla realtà, ma quello che si nasconde dietro le sue apparenze mutevoli e false
Pubblichiamo questo scritto di Vittorio Sgarbi in replica a «Il meglio e il peggio 2021» pubblicato nel numero di gennaio di «Il Giornale dell’Arte»
Il falsario di sculture ha tratto in inganno più di uno studioso e con la sua straordinaria perizia ha incantato i grandi musei. Anticipiamo un testo di Vittorio Sgarbi nel catalogo della mostra al Mart