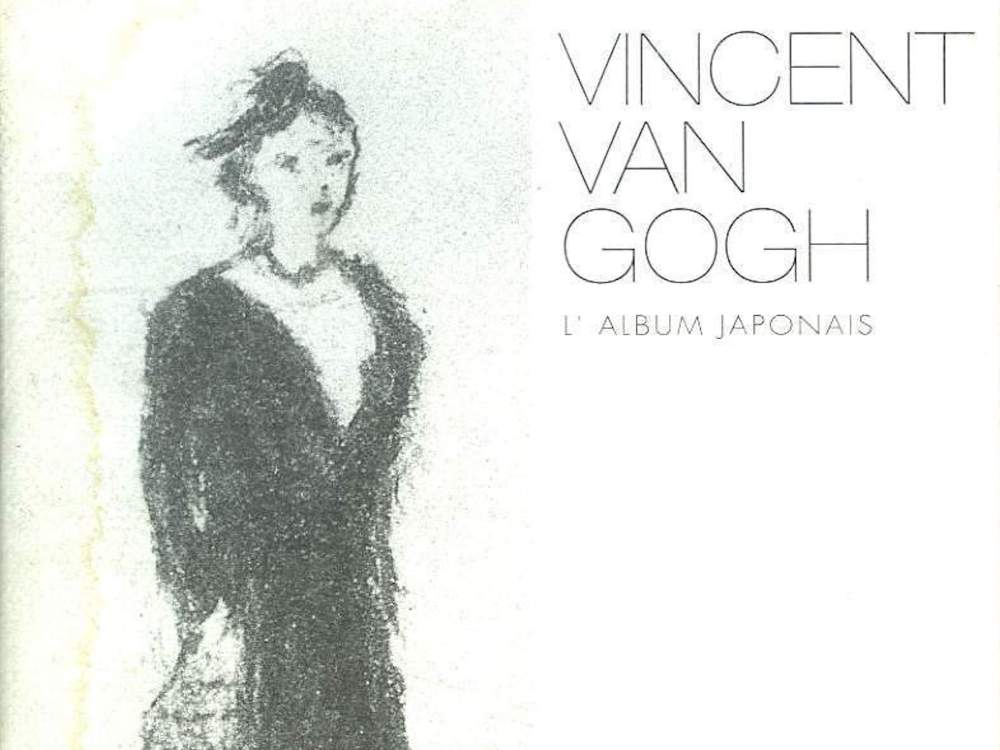Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Gloria Gatti
Leggi i suoi articoliL’art. 532 c.p.c. norma, prevede che il Giudice possa, con provvedimento motivato, affidare la vendita delle cose pignorate a un soggetto specializzato nel settore di competenza, per consuetudine una casa d’aste, iscritto, in ragione di trasparenza, nell’elenco di cui all’art. 169 sexies disp. att. c.p.c., allorquando ritiene che questo possa portare a una maggiore valorizzazione e realizzo dei beni pignorati operando una parziale esternalizzazione delle attività dell’ufficio esecutivo.
La prassi di nominare una casa d’aste denota una presa di coscienza del fatto che, anche all’interno del processo esecutivo, le opere d’arte meritino di godere di un trattamento differenziato in ragione del loro sensibile valore culturale ed economico. In questo caso la casa d’aste, però, opererà come ausiliario del Giudice ex art. 168 disp. att. c.p.c. quale «commissionario giudiziario per la vendita dei beni pignorati, e pubblico ufficiale in quanto svolge, senza alcuna dipendenza funzionale dalle parti, compiti d’ausiliario del giudice non meramente esecutivi» (Cass. Pen. 31656/2008 e 3872/2008) e non come mero mandatario senza rappresentanza del venditore, qual è nel compimento ordinario della sua attività peculiare.
In caso di «aste private» la casa d’aste «effettua proprio una “vendita per conto terzi” così come essa dichiara nei suoi cataloghi, agisce cioè come mandataria senza rappresentanza assumendo gli obblighi relativi al negozio posto in essere. L’attività da essa esplicata è attività giuridica, e più specificamente attività di venditrice, sia pure per conto terzi. Essa pubblicizza la vendita attraverso la stampa e la diffusione dei cataloghi nei quali indica le caratteristiche dell’oggetto, il valore, il prezzo d’asta, stabilisce in maniera autonoma il giorno della vendita, le modalità dell’incanto, le “condizioni della vendita”, le clausole di esonero di responsabilità “oltre quelle sulla qualità di intermediaria”, compie le operazioni d’incanto, provvede all’aggiudicazione, percepisce il prezzo totale, o esercita la facoltà di domandarne “solo una parte a titolo di caparra”, ha facoltà di valutare la “inadempienza” e di rimettere l’oggetto in vendita» (Corte d’Appello di Roma, 17 luglio 1979, in Foro Italiano, 1980, 1, pp. 1447 e ss.) e soggiace alle norme di cui agli artt. 1705 c.c. e ss.
Nel caso invece di una vendita giudiziaria, benché battuta da una casa d’aste, la stessa vendita soggiace alle norme di legge in tema di espropriazione e alle condizioni predeterminate dal Giudice dell’esecuzione. Si rammenta la vendita del «Ritratto di donna Franca Florio» di Giovanni Boldini, aggiudicato a 1.133.029 euro il primo marzo 2017, nell’ambito di una procedura di concordato preventivo affidato come Commissionario alla casa d’aste Claudia Bonino.
Va tuttavia segnalato che ai fini di attribuire stabilità al trasferimento coattivo compiuto con l’esecuzione forzata, l’art. 2922 c.c. esclude l’applicabilità delle regole dettate per la compravendita in tema di tutela dell’acquirente, come di recente precisato dal Tribunale di Monza con sentenza n. 437/2018 del 14 febbraio 2018 e già dalla Suprema Corte di Cassazione (n. 7233/1983) in epoca più risalente.
In particolare, i beni pignorati e, quindi, anche le opere d’arte, vengono venduti nello stato in cui si trovano, essendo di provenienza giudiziaria, poiché nella vendita forzata non opera la garanzia per i vizi della cosa. Si vende secondo la formula del «visto e piaciuto». Conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi o mancanza di qualità o difformità della cosa venduta non potranno dare luogo a risarcimento, indennità o riduzione del prezzo.
L’esclusione dell’operatività delle garanzie per l’acquirente nell’alienazione forzata si sostanzia nel carattere complesso della vendita coattiva nella quale convivono l’elemento privatistico del trasferimento del bene e quello pubblicistico della responsabilità patrimoniale del debitore tramite l’alienazione forzosa operata senza la volontà del proprietario a cui si sostituisce un organo di giustizia per il soddisfacimento dei creditori.
Ne consegue che le condizioni generali di vendita standard di norma applicate dalle case d’asta, benché pubblicate nel catalogo, dovranno essere modificate in relazione alle peculiarità dello specifico caso della vendita giudiziaria. Il mandante, infatti, non è un privato venditore, ma il Tribunale non potrà essere ritenuto responsabile per gli eventuali vizi delle opere d’arte in virtù del già citato art. 2922 c.c. poiché l’asta è una vendita giudiziaria.
Ogni eventuale controversia che coinvolga il mandante, che è per l’appunto il Tribunale, dovrà essere formulata nel rispetto della forma con un ricorso ex art. 617 c.p.c. (opposizione agli atti esecutivi) davanti all’ufficio giudiziario competente per legge, non potendo operare la deroga convenzionale del foro competente, indicata dalla casa d’aste in catalogo. Se lo squalo da 12 milioni di dollari di Damien Hirst («The Physical Impossibility Of Death In the Mind Of Someone Living») fosse stato venduto in un’asta giudiziaria e non da Saatchi e Gagosian, lo sventurato acquirente non avrebbe potuto invocare la garanzia per vizi una volta che il grosso pesce in formalina aveva iniziato a diventare «verde e raggrinzito» e ad andare in decomposizione.
Ipotetici «vizi redibitori o mancanze di qualità» dell’opera d’arte per i quali l’acquirente agli incanti astrattamente potrebbe restare senza tutela attengono, ad esempio, allo stato di conservazione o al degrado dell’opera; si pensi, ad esempio, a un olio su una tavola irreparabilmente compromessa da tarli del legno o a un disegno su una carta compromessa da funghi o muffe. Qualora, invece, un dipinto o una scultura si rivelassero non autentici, si ritiene che l’aggiudicatario possa agire per la risoluzione del contratto per inadempimento consistente nel trasferimento di un aliud pro alio, fattispecie applicabile anche alle vendite giudiziarie.
Si vedano Cass. civ., Sez. I, 14 ottobre 1960, n. 2737 e Cass. Civ., Sez. II, l° luglio 2008, n. 17995: «la cessione di un opera d’arte falsamente attribuita ad artista che in realtà non ne è stato l’autore costituisce una ipotesi di vendita di “aliud pro alio”, e legittima l’acquirente a richiedere la risoluzione del contratto per inadempimento del venditore, ex art. 1453 c.c.». Secondo la giurisprudenza di legittimità è aliud pro alio anche la cessione di un’opera autentica, ma modificata e alterata da terzi e non più corrispondente all’originale concepito dall’artista (Cass. civ., Sez. II, 8 giugno 2011, n. 12527).
Un’eventuale errata datazione dell’opera d’arte, come accadde per l’«Orchidea Bianca» di Mimmo Rotella, per contro, ad avviso di chi scrive, pur incidendo sensibilmente sul valore economico della stessa, potrebbe costituire, al più, una «mancanza di qualità» e il compratore restare privo di tutela in caso di acquisto ai pubblici incanti. Per quanto concerne, invece, l’eventuale dichiarazione di interesse storico artistico «particolarmente importante», ai sensi dell’art. 10 del Codice dei Beni Culturali, di un’opera d’arte pignorata in una vendita giudiziaria, una recente pronuncia del Tar del Lazio del 2 luglio 2019 riguardante «La falaise du Petit Ailly à Varengeville» di Claude Monet, facente parte della collezione Tanzi, ha chiarito che il provvedimento di avvio del procedimento deve essere notificato sia al debitore ed esecutato sia al creditore procedente, per evitarne l’annullamento dovuto a vizi procedimentali.
Altri articoli dell'autore
Nella trasmissione «Report» il caso di un’opera scomparsa in provincia di Torino: ma è veramente la stessa della Collezione Cavallini Sgarbi, attribuita a Rutilio Manetti?
Venduta al Führer nel 1938 dal principe Lancellotti, riportata in Italia da Rodolfo Siviero nel dopoguerra, la statua romana in marmo è di nuovo al centro di una querelle tra Italia e Germania. E nessuno chiarisce il mistero che ha permesso di trasformare un bene privato in un bene pubblico
Una sentenza del Consiglio di Stato dà lo spunto per un parallelo tra il nostro ordinamento e la normativa in materia di beni culturali al di là delle Alpi
Se in mostra c’è un falso, vero o presunto, la colpa è loro. In un caso, poi, le opere esposte erano addirittura fotocopie