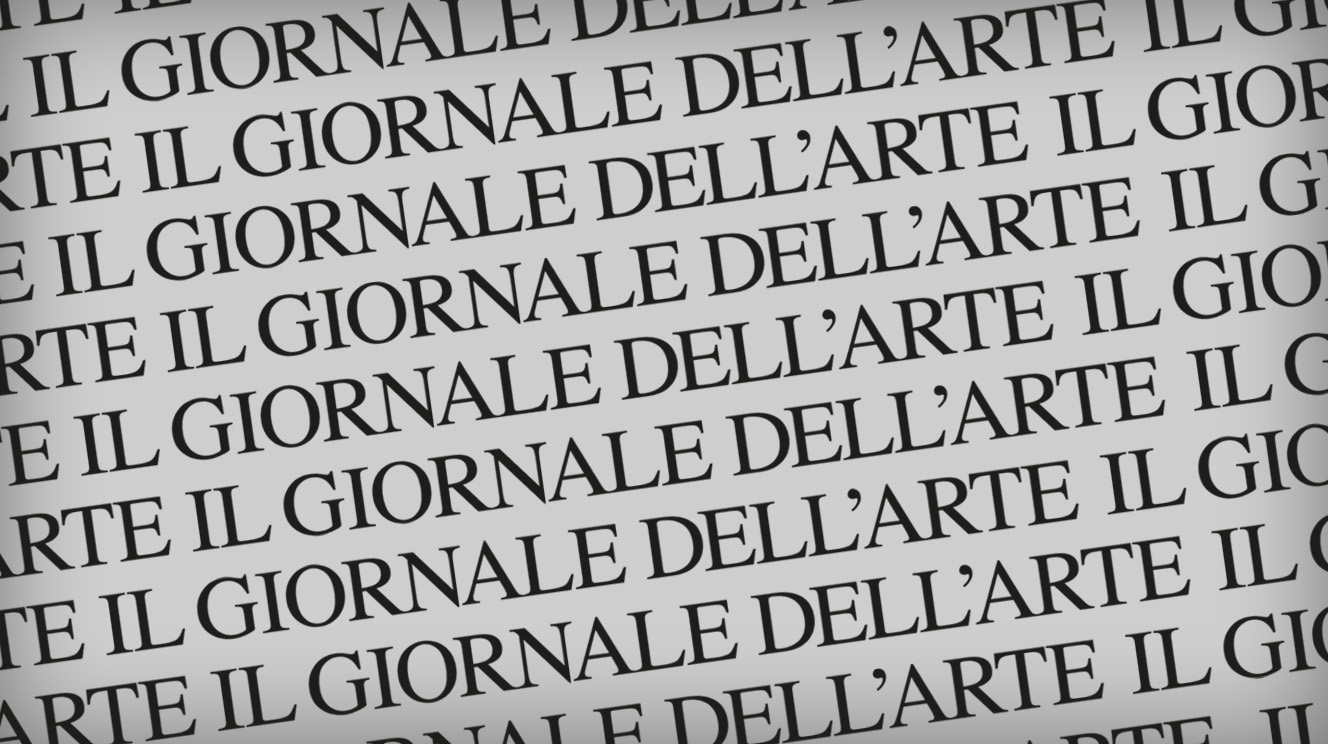Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Stefano Miliani
Leggi i suoi articoliGiuliano Volpe, presidente del nuovo Consiglio superiore per i Beni culturali e paesaggistici (sub, di sinistra e non credente) promette: «Dobbiamo dimostrare che la tutela del territorio non vuole bloccare lo sviluppo. Nei beni culturali troppi torcicollo»
Essere archeologo, per Giuliano Volpe, significa anche capire com’è cambiato il paesaggio agricolo nei millenni per affrontare con miglior cognizione di causa e senza dogmi il difficile rapporto del nostro presente con territori spesso feriti o da salvaguardare.
Il professore, appena confermato alla presidenza del nuovo Consiglio superiore per i Beni culturali e paesaggistici che dovrebbe insediarsi a giugno (cfr. box qui sotto), è una figura piuttosto fuori dal comune. Insegna all’Ateneo di Foggia (di cui è stato rettore dal 2008 al 2013) e ha condotto scavi nella Puglia settentrionale con gli studenti; sub per interesse professionale, twitta volentieri, scrive sui giornali; si descrive di sinistra (a suo tempo si candidò, come indipendente, per Sinistra ecologia e libertà); laico e non credente, 57enne, vorrebbe sentire i politici italiani dire e mettere in pratica quanto va predicando papa Francesco.
Partiamo dai piani paesaggistici. Tranne Puglia e Toscana, che li hanno pianificati con il Mibact come prevede il Codice dei Beni culturali e poi li hanno approvati, le altre Regioni sono in ritardo.
Dopo Puglia e Toscana in realtà qualcosa si muove (cfr. lo scorso numero, p. 5). Li hanno in preparazione Marche e Campania, la Sardegna sta revisionando quello redatto dall’allora governatore Renato Soru, che però riguardava prevalentemente le coste e sul quale la Giunta cadde. Va riconosciuto che il nuovo direttore generale alle Belle arti e paesaggio del Ministero, Francesco Scoppola, presta un’attenzione particolare al tema e che la delega al sottosegretario Ilaria Borletti Buitoni ne sottolinea l’interesse strategico per il Mibact. Il Consiglio superiore, che ha sostenuto i piani pugliese e toscano, avrà questa tra le sue priorità.
Eppure il ritardo è clamoroso, no?
È grave e scandaloso perché si è perso molto tempo negli anni passati. Da quando è ministro Dario Franceschini ne sono stati approvati due. Quello pugliese ha fatto un po’ da cavia richiedendo un lunghissimo lavoro per definire procedure che potranno essere utilizzate in tutti i piani regionali. D’ora in avanti mi aspetto tempi più celeri. Stiamo recuperando e la struttura è attrezzata.
Quali caratteristiche ritiene debba avere un buon piano paesaggistico?
Intanto servono piani conoscitivi approfonditi. In passato ne sono stati fatti senza elementi analitici, invece sono fondamentali per garantire la qualità delle norme.
Quali punti cardine indicherebbe?
Primo: puntare sul recupero e porre fine al consumo di territorio e alle nuove costruzioni, alla perdita di equilibrio tra città e campagna; in ambito urbano penso a una cura delle periferie e al recupero degli immobili esistenti. Nelle campagne penso a un blocco sostanziale di nuovo cemento e del cosiddetto «sprawl», l’edilizia diffusa. Secondo: allentare la pressione sulle coste. È fondamentale anche per il turismo. Pensiamo alla Calabria dove si sono costruite case perfino sulla spiaggia o in aree archeologiche esulando da qualsiasi regola. Invece, anche per il turismo, vanno individuate procedure che valorizzino le aree interne recuperando immobili nei piccoli centri. Terzo: va sviluppata una mobilità dolce; lungo coste come quella pugliese, ad esempio, si può fare maggior uso delle imbarcazioni. Pensando soprattutto al Sud, bisogna evitare un’ulteriore cementificazione trovando le formule corrette affinché il turismo porti beneficio ai piccoli centri interni ed eviti lo spopolamento. Quarto: è fondamentale valorizzare il patrimonio culturale. In Puglia abbiamo realizzato una Carta dei beni culturali che mi piacerebbe diventasse uno strumento per tutte le Regioni. È un sistema informativo che, oltre a censire il patrimonio culturale, incluso quello immateriale, nell’intera regione e ogni sito, dalla preistoria al ’900, permette anche di pianificare i finanziamenti, di monitorare i flussi turistici comprendendo musei, parchi, tradizioni, musica, feste. È uno strumento di conoscenza che consente una gestione corretta ed è fortemente collegato con il paesaggio.
Secondo diversi critici, il decreto governativo «Sblocca Italia» dell’autunno scorso colpirebbe pesantemente paesaggi anche non compromessi, schiacciando ogni concetto di tutela.
I piani paesaggistici servono appunto ad avere strumenti che evitino che uno «Sblocca Italia» faccia saltare ogni pianificazione e tutela del territorio. Ma finché questi temi saranno materia solo dei professori e degli intellettuali rischieremo di perdere la partita: dobbiamo invece dimostrare che questa visione non vuole bloccare lo sviluppo bensì promuovere forme più innovative. Non voglio passare per un passatista che vuol mettere sotto una teca il territorio: le società lo hanno sempre trasformato. La scommessa sta nel soddisfare le nuove esigenze e forme di crescita con una pianificazione attenta.
Regole rigorose non sono però indispensabili, tanto più in un Paese dove vengono regolarmente ignorate?
Sì, ma non si vince la battaglia della tutela soltanto con i vincoli perché sono legati a una visione puntiforme: il singolo sito, la singola enclave... I piani paesaggistici invece si occupano del tutto: non selezionano le parti da conservare e quelle da lasciare alla trasformazione selvaggia bensì propongono misure compatibili con la trasformazione stessa. Spesso assumiamo una posizione elitaria ed esiste il rischio di identificare la valorizzazione con una mercificazione tout court. Invece bisogna dimostrare che beni culturali e paesaggio sono strategici per lo sviluppo economico. Il problema è intendersi su quale sviluppo economico vogliamo ed è qui che bisogna capire chi pensa davvero al futuro: noi che vorremmo conservare e valorizzare il patrimonio culturale o chi pensa, con una visione arcaica, che lo sviluppo corrisponda al consumare le risorse del territorio?
Lei ha avuto un percorso singolare: com’è arrivato all’Archeologia del paesaggio?
Partendo da altre esperienze da archeologo sono arrivato a pensare che l’archeologia non possa che essere globale, nel senso che deve affrontare le tracce del passato con tutte le fonti a disposizione.
Può fare un esempio?
Posso citare la Puglia settentrionale che studio da anni. In età neolitica centinaia di villaggi hanno trasformato il Tavoliere in una grande pianura coltivata. Dopo sono arrivate l’alternanza con la transumanza e quindi il pascolo, le grandi divisioni agrarie in età romana, i casali e le aziende agricole medioevali. Capendo le forme di integrazione tra agricoltura e allevamento si possono cogliere le peculiarità più profonde dell’area: solo così si può comprendere come il futuro della Puglia settentrionale sia nell’agricoltura di qualità e nel valorizzare il patrimonio culturale.
Lei come si è formato, a partire da quando era ragazzo?
Al liceo classico grandi professori mi hanno stimolato alla conoscenza dell’antico e a non chiudere gli occhi sul presente. Dopo filologia e storia antica, nel mio percorso di studente universitario ho incontrato Andrea Carandini in uno scavo a Orbetello e poi Daniele Manacorda alla Crypta Balbi a Roma. Da allora è nato il mio interesse per l’archeologia in età romana legata all’agricoltura, allo sviluppo economico. Poi mi sono avviato all’archeologia subacquea per studiare i commerci antichi. Ho scavato in Francia e in Albania, sempre interessandomi alle rotte commerciali, ai carichi di anfore con vino e olio. In Daunia, nella Puglia nord-occidentale, scavo da quasi 30 anni in città abbandonate come Herdonia presso Ordona oppure a continuità di vita come Canosa; a Faragola stiamo scavando una villa romana con sale da pranzo e terme, una specie di Piazza Armerina, e un abitato altomedioevale non meno importante.
Lei si definisce laico non credente eppure in una sua conferenza a Sassari ha citato papa Francesco quando ha esortato a tenere vivo il fuoco e a non adorare la cenere. Che cosa intendeva dire?
Pur non avendo la fortuna di avere la fede, ma rispettando la religione, trovo questo pontefice straordinario: oltre ai credenti disorientati infonde fiducia a chiunque creda nell’uguaglianza e nella solidarietà in un momento di scontri tra civiltà. E sa dire parole che la sinistra non sa più dire. A mio parere abbiamo bisogno di una sinistra che non riproduca le formule del passato, che sappia conservare valori come uguaglianza, solidarietà, libertà e sappia dare soluzioni nuove, non limitarsi alla difesa di totem di poco senso per i giovani precari, per chi vive nuove forme di povertà o di disagio. Ecco, vorrei una sinistra più innovativa e meno conservatrice. Anche nei beni culturali vedo molti con torcicollo rivolti al passato quando servono risposte nuove, quando bisogna avere progetti per tenere vivo quel fuoco. Non adorare le cenere, appunto.
Altri articoli dell'autore
Nuova pavimentazione, nuovi lampioni e una nuova, contestata pensilina: i lavori, costati 7,5 milioni, scatenano discussioni e malumori
Nella Rocca Albornoz e a Palazzo Eroli, a Narni, una settantina di sculture di uno dei maestri del Nouveau Réalisme per riflettere sul rapporto tra alto artigianato e creazione artistica
Il 6 aprile avrà luogo una commemorazione in ricordo delle 309 vittime del terremoto del 2009. Diamo conto della condizione di alcuni monumenti: il Castello spagnolo, le mura urbiche presso porta Brinconia, la Chiesa di San Marco e Palazzo Centi
La «culla» del francescanesimo era a rischio in quanto la soprastante cupola della Basilica di Santa Maria degli Angeli era preoccupantemente fessurata dal terremoto del 2016