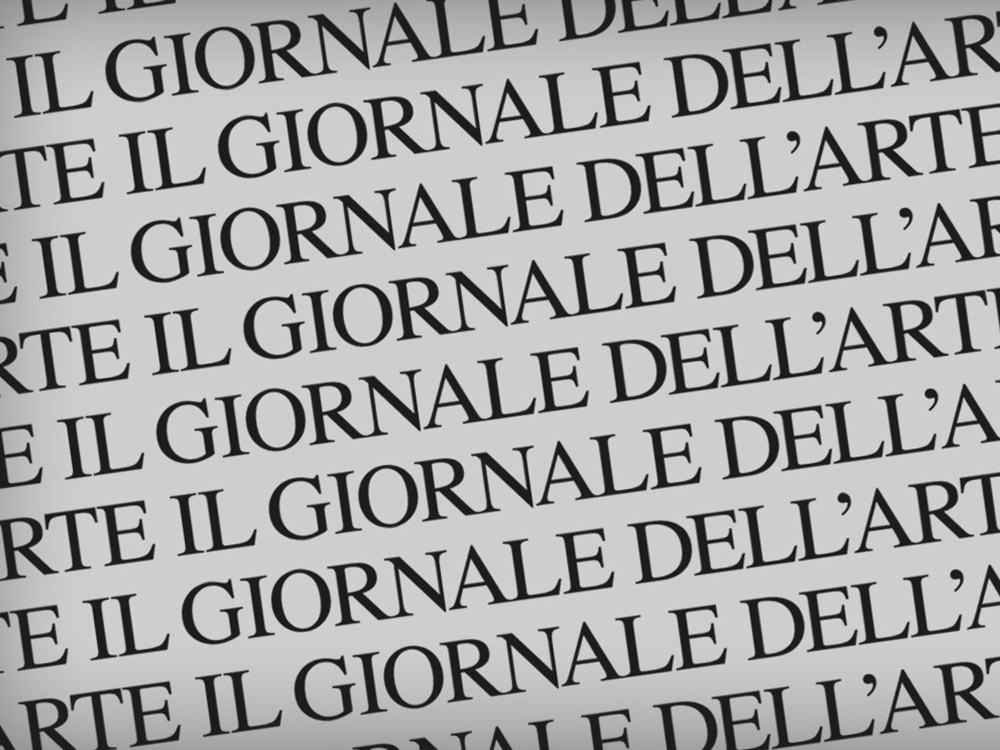Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine
Fabrizio Lemme
Leggi i suoi articoliIl D.Lgs. 42/2004 considera come beni culturali suscettibili di tutela anche (art. 10/3 lett. a) «gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono l’interesse storico particolarmente importante» e (lett. c) «le raccolte librarie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale».
Che cosa si intende per «archivio» e «raccolta libraria»? Un ammasso di documenti o di libri non consultabili a causa delle difficoltà di reperire quanto oggetto di ricerca, può considerarsi archivio o biblioteca? E quale rapporto si istituisce tra chi abbia accumulato i libri o i documenti e chi tale materiale abbia, successivamente, ordinato? In altri termini in quale momento dall’ammasso informe cominciano a definirsi un archivio e una biblioteca suscettibili, in quanto tali, di tutela? L’archivio, la biblioteca, la collezione di opere d’arte non si perfezionano con un unico atto bensì sono espressione della ricerca incessante del collezionista che tende a un progressivo assemblaggio.
Solo l’attività razionale di dare un ordine a quanto appare informe consente di parlare di un archivio, di una biblioteca, di una collezione. Poniamo il caso: per tutta la vita il ricercatore continua ad assemblare disordinatamente quanto è oggetto del suo desiderio e al momento della morte lascia un ammasso informe di beni, che non costituiscono né un archivio, né una biblioteca, né una collezione. Gli eredi danno ordine a questo materiale confuso e, gradualmente, si individua un archivio, una biblioteca, una collezione, nel senso proprio di questi termini secondo il linguaggio comune. Il legislatore, infatti, assai spesso, non definisce concettualmente le categorie che disciplina, per il cui senso è necessario ricorrere alle cosiddette «valutazioni sociali medie».
L’attività degli eredi può durare anni o decenni ed è un tipico work in progress che rende problematica l’individuazione della «fine». A questo punto si pongono due problemi: 1. La biblioteca, l’archivio, la collezione sono opere dell’erede o del ricercatore che ha lasciato il materiale da ordinare? 2.. La biblioteca, l’archivio, la collezione presuppongono il totale completamento dell’opera di riordino o si possono ritenere integrati quando ne sia possibile un’individuazione ontologica? Al primo quesito risponderei che il «busillis» si risolve secondo l’atteggiamento che il riordinatore abbia assunto nei confronti del materiale lasciato dal ricercatore: se la sua attività è stata svolta con spirito di devozione alla memoria di chi non è più, è quest’ultimo l’autore dell’archivio, della biblioteca, della collezione. Al secondo viceversa risponderei che un’attività di riordino potrebbe essere infinita: data all’archivio o alla biblioteca o alla collezione una sistemazione organica, quest’ultima potrebbe avere infinite, ulteriori specificazioni. Prendiamo una collezione di pittura: riterrei che l’ammasso di dipinti si possa definire una collezione già al momento in cui ne sono definiti, ove storicamente possibile, i diversi autori (scuole, criteri iconologici e iconografici potranno poi essere elementi ulteriori).
La classificazione per autore è per me elemento indefettibile e non surrogabile con altri fumosi criteri, in particolare con quello assai di moda del «contesto». Vi è poi un ulteriore problema. I beni culturali appartenenti a privati sono suscettibili di tutela solo «ratione aetatis»: debbono risalire ad autore non più vivente e la loro realizzazione deve essere ultracinquantennale. Mi chiedo se tale criterio valga anche per gli archivi e le biblioteche: in altri termini debbono essere passati almeno cinquant’anni dalla morte di chi abbia messo insieme la biblioteca o l’archivio perché la tutela possa trovare applicazione o, viceversa, tale tutela si attua appena si sia passati dall’ammasso alla definizione concettuale di biblioteca o archivio? L’art. 10/5 D.Lgs. 42/04 sembrerebbe circoscrivere il requisito della ultracinquantennalità ai soli beni indicati alle lett. a) ed e) del III comma, escludendo, conseguentemente, gli archivi (lett. b) e le raccolte librarie (lett. c): quindi, mentre per le collezioni il criterio trova applicazione, esso non sarebbe applicabile per archivi e biblioteche.
Ora, a mio avviso, questa diversità di trattamento non trova giustificazione razionale e, pertanto, non è costituzionalmente ammissibile, in base al principio di uguaglianza dell’art. 3 della Costituzione. Si impone allora un’interpretazione costituzionalmente orientata che allarghi la nozione (definita nell’art. 11/1 lett. h) di «beni e strumenti per l’interesse della storia e della tecnica aventi più di cinquant’anni» ritenendo comprese in essa anche le categorie degli archivi e delle biblioteche. Non si vede infatti quale giustificazione possa avere una diversità di trattamento come quella ipotizzata, che si allargherebbe a dismisura se anche gli ammassi di libri o di documenti venissero considerati in se stessi tutelabili. In tal caso la tutela avrebbe un effetto contrario perché scoraggerebbe l’attività di catalogazione che buoni eredi potrebbero fare in memoria del loro dante causa.
Altri articoli dell'autore
I beni culturali possono essere dichiarati di particolare interesse solo se la loro esecuzione risalga ad almeno cinquant’anni
La capacità (e l’obbligo) di correggersi della Pubblica Amministrazione
Va introdotta una distinzione tra ricerca significativa e ricerca inutile: la prima aggiunge qualcosa alle conoscenze già acquisite, la seconda si limita a riproporre il «déjà dit»
Il conflitto tra Russia e Ucraina mette in luce un relativismo che parte da Giovanni Battista Vico